Speciale
Presuntuosi e impreparati / Allarmi inascoltati
Nella conferenza scientifica “Ambiente e virus a mutazione genetica” che si tenne a Long Island a metà degli anni ‘80, Edwin Kilbourne – uno dei più importanti virologi americani, morto nel 2011 – propose un contributo inusuale. Kilbourne immaginava la possibilità che un nuovo pericolosissimo virus emergesse nel mondo, un virus più contagioso, letale e difficile da controllare di tutti i virus allora conosciuti. Kilbourne lo chiamò MMMV (Maximally Malignant Mutant Virus) e ne descrisse le immaginarie caratteristiche. MMMV aveva la stabilità nell’ambiente dei poliovirus, l’alto tasso di mutazione dei virus dell’influenza, la capacità di spillover del virus della rabbia e la lunga potenzialità di latenza dell’herpes virus. Ancora, si sarebbe trasmesso attraverso l’aria e replicato nelle basse vie del tratto respiratorio, come l’influenza, e avrebbe potuto inserire i propri geni direttamente nel nucleo delle cellule ospiti, come l’HIV.
Ora, SARS-COV-2 non è naturalmente il mostruoso virus immaginato da Kilbourne quarant’anni fa, ma diciamo che ci si avvicina: viaggia nell’aria con le goccioline di salive (droplet), rimane attivo a lungo sulle superfici e si moltiplica nelle basse vie respiratorie. Come sappiamo, il nuovo coronavirus ha un’altra subdola capacità con il quale ci stiamo confrontando: un alto potenziale di contagio dovuto alla maggioranza di individui che lo sviluppano in forme lievi, se non del tutto asintomatiche.
Nel 1994 Robin Marantz Henig, la giornalista scientifica al quale dobbiamo questo ricordo, pubblica un libro (non tradotto in italiano) dal titolo estremamente attuale: Dancing Matrix, How Science Confronts Emerging Viruses. Descrivendo il lavoro di biologi e medici che operavano trent’anni fa, Henig metteva in guardia sul rischio d'insorgenza di nuovi patogeni virali dagli effetti potenzialmente devastanti sulla salute pubblica. Quali erano i fattori che alimentavano questo nuovo rischio? I cambiamenti climatici e le alterazioni degli ecosistemi ecologici, la forte spinta all’urbanizzazione e l’inedita prossimità delle popolazioni umane (e delle grandi aziende agricole e zootecniche) con la fauna selvatica che funge da reservoir di virus. Tutti questi elementi erano indicati dagli esperti come benzina sul fuoco per questa incipiente minaccia.
Ma non era finita qui. I ricercatori segnalavano un’altra circostanza preoccupante. I nuovi virus avevano davanti a loro una vera e propria autostrada per diffondersi: come mai nella storia avevano la possibilità di raggiungere un’enorme popolazione, infettando rapidamente diversi paesi e zone del mondo. Questa autostrada rispondeva al nome di globalizzazione: al virus sarebbe bastato inserirsi nella rete planetaria di persone che già allora si spostavano nel mondo grazie al trasporto veloce. “La singola minaccia più rilevante al costante dominio dell’uomo sul pianeta sono i virus”, aveva sintetizzato in quegli anni il genetista e premio Nobel Joshua Lederberg (la frase è messa ad esergo del film Virus letale, uscito nel 1995, con Dustin Hofmann nei panni di un medico militare alle prese con un virus ad alto contagio di origine animale).
Al libro della Henig si sarebbero aggiunti negli anni molti altri, alcuni dei quali diventeranno dei veri e propri bestseller sulla tematica virus (come l’ultimo e citatissimo Spillover di David Quammen, pubblicato nel 2014). Tutti questi libri convergevano sulle medesime conclusioni, come non poteva essere altrimenti considerata la sostanziale unanimità degli esperti internazionali.
Ma libri, pubblicazioni scientifiche e rapporti di organizzazioni internazionali sono in fondo solo parole inerti, che non incidono direttamente sulla vita di centinaia di migliaia di persone. Eppure, dagli anni ‘80 ad oggi non ci sono state solo grida inascoltate, ma anche un manifestarsi sempre più evidente della verità di quegli allarmi.
Nel giugno del 1981 viene per la prima volta segnalata una nuova malattia che colpisce il sistema immunitario, dovuta a un virus di provenienza animale che verrà in seguito indicato con la sigla HIV (Virus dell'Immunodeficienza Umana). Nel 1993 sono già due milioni e mezzo i casi di HIV/AIDS nel mondo e si stima che oggi siano quasi 38 milioni le persone infettate. A febbraio del 2003 l’Organizzazione mondiale della sanità conferma l’esistenza di focolai di una nuova grave forma di polmonite. All’origine dell’epidemia ad alta letalità c’è un coronavirus (SARS-CoV), proveniente da un reservoir animale (probabilmente pipistrelli), che fino a luglio 2003 colpisce quasi 9000 persone in 26 paesi diversi. Nel 2012 è la volta di una nuova malattia respiratoria acuta denominata MERS, anche in questo caso causata da un virus trasmesso dagli animali (dromedari); per circa il 35% dei contagiati sopraggiunge la morte. Dicembre 2013: inizio della diffusione della malattia da Ebola (EVD), un virus identificato per la prima volta nel 1976. Nel biennio 2014-16 si consuma una devastante epidemia, sia per numero di focolai che per numero di contagiati e di morti: 28.652 casi confermati con 11.325 decessi in dieci paesi diversi. L’origine dell’epidemia è stata attribuita ad un passaggio del virus dalla fauna selvatica all’uomo.
Perché non abbiamo considerato questo evidente pericolo virologico che era sotto i nostri occhi ormai da anni, ampiamente documentato e segnalato, e che si è manifestato con epidemie devastanti per interi paesi e zone del mondo? La risposta presuppone un’altra domanda, che ho volontariamente evitato nella mia breve ricostruzione. La domanda è questa: chi è stato colpito dai virus insorti degli ultimi decenni?
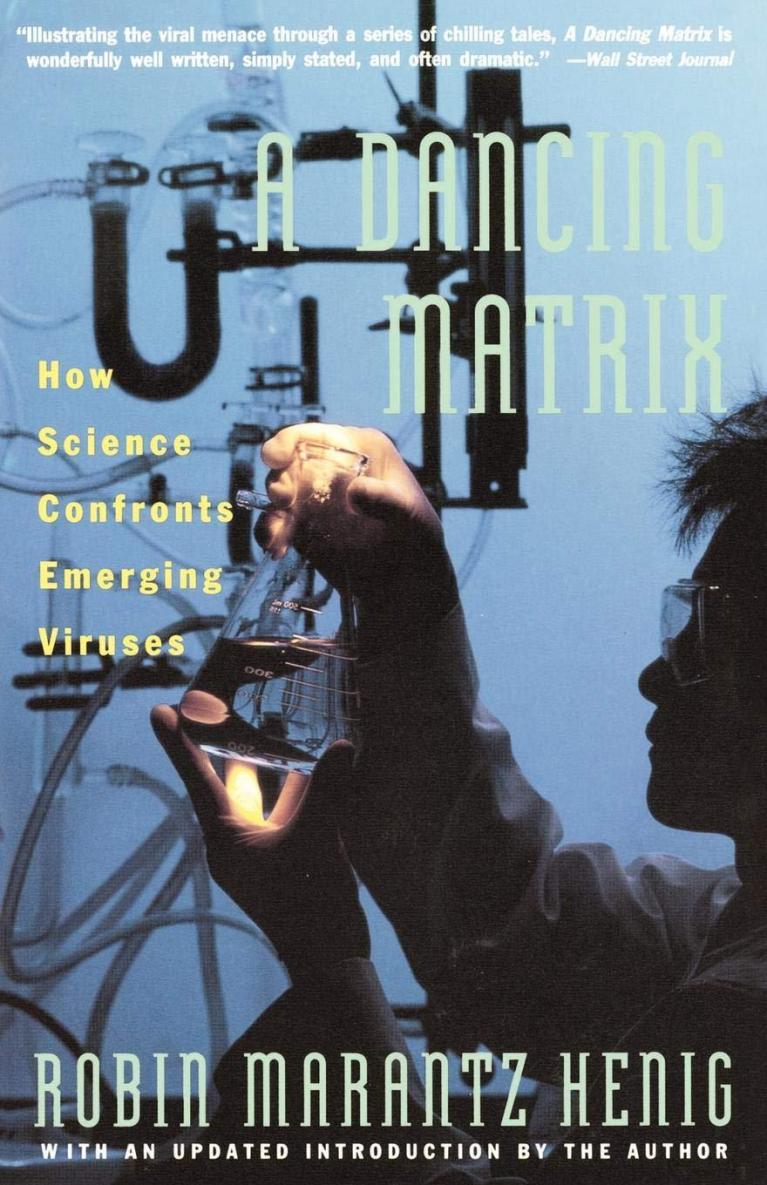
HIV/AIDS: la comunità omosessuale, i drogati, sex worker e a livello globale i paesi africani (oltre i due terzi dei contagi al mondo).
SARS: la Cina e altri paesi asiatici.
MERS: arabi e mediorientali (80% dei casi in Arabia Saudita).
Ebola: gli africani, in particolare i paesi poveri dell’Africa occidentale.
Cosa manca in questo rozzo elenco? Manchiamo noi, il ricco e sviluppato Occidente. E quando l’epidemia ci ha raggiunti, come è il caso dell’AIDS, sono le minoranze ad essere state colpite.
E quindi non è esagerato affermare che non abbiamo preso sul serio il rischio globale dei nuovi virus di origine animale perché, in fondo, pensavamo fosse un problema che riguardasse solo gli Altri. I paesi europei e gli Stati Uniti, che della globalizzazione sono stati i più importanti promotori, hanno chiuso gli occhi di fronte al combinato disposto tra insorgenza di nuovi virus ed enorme velocità di diffusione planetaria, il tutto perché ci si è cullati nell’idea che fosse un problema confinato agli Altri, ai poveri, agli asiatici e agli africani, a coloro che magari hanno usi e costumi alimentari primitivi e incomprensibili.
Insomma, senza girarci intorno, per una forma di razzismo. Non abbiamo agito, preparandoci a livello nazionale ed europeo e approntando con gli altri paesi quell’infrastruttura globale necessaria ad affrontare le nuove pandemie, per una supposta forma di superiorità. E ora scopriamo amaramente che il virus, come anche il cambiamento climatico, non conosce confini. Non distingue tra Noi e Loro.
Del resto, ce lo insegna lo storico George Mosse tra i maggiori studiosi di razzismo, esiste un legame profondo tra degenerazione e visioni razziste: l’idea di una corruzione patologica, di derivazione biologica, che affligge alcuni gruppi umani, definendone caratteri morali e comportamenti. E le epidemie non hanno fatto che confermare questa retorica negativa dell’Alterità. Untori e peccatori puniti per la loro, presunta, immoralità. Pensiamo all’AIDS come "peste gay": le comunità omosessuali sono colpite a causa dei costumi degenerati, uno stigma che gay e transessuali hanno dovuto portare a lungo, insieme a tutte le persone sieropositive.
Ma a renderci ciechi ha contribuito anche un’altra forma di razzismo, quella che va sotto il nome di specismo, la convinzione secondo cui gli esseri umani siano superiori per status e valore agli altri animali. Abbiamo pensato che la nostra specie fosse ormai avulsa dalla vita biologica di cui è parte, dalla grande catena e ragnatela di rapporti che ci lega alle altre forme biotiche, dalle più semplici e rudimentali alle più complesse e a noi evoluzionisticamente vicine.
In questo senso, la pandemia di COVID-19 che stiamo vivendo ci riconsegna al posto che oltre 150 anni fa un attento e meditabondo naturalista inglese ci aveva assegnato, con la grande teoria dell’origine della specie. Oggi non pensiamo più, come ai tempi di Darwin, che l'uomo è la specie che rappresenta Dio sulla Terra, creato appositamente per sfruttare la natura e le altre specie, ma solo perché abbiamo sostituito Dio con ciò che più ci conviene: bisogni e profitti. E invece il rispetto degli altri soggetti non umani che abitano il pianeta, e la difesa dei loro ecosistemi, sono la migliore garanzia per la nostra stessa sicurezza e sopravvivenza. In questo senso antispecismo, ecologismo e antirazzismo sono elementi che si devono ricomporre in un’unica prospettiva. Del resto e non a caso, lo stesso Darwin – come già suo nonno Erasmus – era un fervido sostenitore di posizioni antischiaviste.
Non abbiamo voluto guardare al pericolo che ci minacciava per una fatale presunzione di eccezionalismo (“noi non siamo come loro”). E anche quando il pericolo era ormai evidente, e vicino, abbiamo continuato a girare la faccia dall’altra parte e la mancanza di umiltà ci ha impedito di imparare dai paesi che sono stati colpiti prima di noi da COVID-19.
Come ha notato lo storico e scrittore indiano Mukul Kesavan, i paesi europei e gli Stati Uniti hanno via via sollevato obiezioni alla possibilità di seguire gli esempi di risposta alla pandemia messi in campo dai paesi asiatici. Dalla Cina per differenze di regime politico, dai paesi pienamente democratici come la Corea del Sud o Taiwan per supposte incompatibilità dei nostri modelli sociali. In ogni caso quello che è emerso è un’incapacità a prendere sul serio ciò che questi paesi avevano appreso dall’epidemia SARS del 2004, ovvero la creazione di un sistema di test di massa, tracciamento e quarantena, che è stata la vera differenza vincente tra Oriente e Occidente nell’affrontare l’attuale pandemia.
Abituati ad avere la leadership scientifica e politica, non abbiamo avuto l’umiltà e la razionalità d’imparare dagli esempi degli Altri. L’esempio evidente – nota sempre Kesavan – è stato il balletto sul tema delle mascherine protettive, misura di profilassi così comune nei paesi asiatici che non necessita di essere ribadita, essendo universale anche per semplici influenze.
Per settimane in Italia, come negli Stati Uniti, ci è stato detto che non andavano indossate dalle persone comuni, perché non si trattava di un dispositivo utile o necessario. Ora tutti i paesi ne raccomandano, o costringono, all’uso, rivelando che l’indicazione precedente non aveva dietro ragioni sanitarie ma di natura per così dire economica: andava gestita la scarsità del prodotto, e quindi dire di non usarle avrebbe permesso di farle avere agli operatori sanitari in prima linea (cosa che comunque è avvenuta male e con ritardi). Ma su questo come su altri esempi la confusione del messaggio è stata del tutto evidente, e non si può evitare di pensare che abbia contribuito il fatto che l’abitudine fosse degli Altri, degli asiatici, di coloro che, a differenza nostra, non riescono a considerarsi come individualità pensante ma solo come massa.
Con la crescita vertiginosa del contagio nei paesi occidentali, con gli USA che hanno superato il totale degli infetti di tutta l’Asia, con il numero dei morti in Spagna che fa rimpicciolire, come in un cannocchiale al contrario, il dato minimo della Corea (20mila spagnoli morti contro 200 coreani) – e la popolazione dei due paesi è equivalente – emerge in maniera plastica la differente capacità di gestione della pandemia tra Est ed Ovest.
Il caso coreano è l’esempio principale. Il primo malato di Covid-19 in Corea del Sud risale al 20 gennaio, i numeri all’inizio rimangono bassi prima di subire un’improvvisa crescita con il picco di 909 nuovi contagiati del 29 febbraio. Ma nel giro di poche settimane il paese riesce a passare dal plateau di un centinaio di nuovi casi alle decine di fine marzo, per scendere alle poche unità registrate ad aprile. Questo risultato è stato ottenuto senza giungere al totale lockdown imposto nei paesi europei. La Corea è il primo paese per test diagnostici effettuati (da metà marzo sono stati testati più di 270mila persone, fino a 20mila al giorno) e ha messo in campo un sistema di tracciamento e isolamento dei contagiati studiato in tutto il mondo. Gli esperti sottolineano la capacità di mobilitare la cooperazione volontaria della popolazione, che è stata sempre informata in modo trasparente, per cambiare i comportamenti all’insegna del distanziamento sociale e delle norme di igiene e profilassi. In Corea non si sono registrate scene di panico e di disorganizzazione che abbiamo visto altrove, e le uniche file alle quali i sud coreani di sono sottoposti sono quelle per esse testati, per ottenere le mascherine e per votare (settimana scorsa milioni di coreani hanno partecipato alle elezioni della nuova assemblea nazionale).
Non dimentichiamo che la Corea è stata colpita negli anni scorsi sia dall’epidemia di SARS sia da quella di MERS, e questo ha lasciato un segno a livello collettivo. Basti ricordare il bellissimo e inquietante The Host di Bong Joon-ho, il regista premio Oscar di Parasite. Attraverso la lente del moster movie - anche qui, al centro del racconto, una famiglia povera e lacerata – il film mette in scena lo stato di emergenza che sconvolge la Corea per il diffondersi di un nuovo virus altamente contagioso e pericoloso.
L’economista Gianni Fodella, amico di Fosco Maraini e grande conoscitore della vasta area influenzata dalla civiltà cinese, indicava nell’orgware la chiave per comprendere l’Est Asia. L’orgware è un indicatore del livello di organizzazione strutturale di un sistema socio-economico. Un criterio per stabilirne la qualità è la relazione tra i comportamenti concreti e regole, norme e relazioni reciproche. Quando essi coincidono, la qualità dell’orgware è massima. Un’ampia evasione fiscale, ad esempio contribuisce a deprimere la qualità dell’orgware. Non si tratta semplicemente del rispetto delle leggi, ma della prevedibilità dei comportamenti alle aspettative, come pure della fiducia che intercorre tra cittadini e istituzioni. Secondo Fodella nei paesi dell’Est Asia si trova un orgware di qualità elevata, che converge in una somma di comportamenti eticamente motivati verso obiettivi comuni, quali ad esempio la riduzione del rischio di contagio in una pandemia.
E così noi, che della globalizzazione siamo stati i maestri, che in questi anni di strettissimi rapporti con l’Asia abbiamo in fondo pensato di aver assimilato l’Oriente ai nostri superiori modelli economici, ci troviamo ora a dover ammettere che questa volta è l’Occidente a dover guardare ad Oriente. Come conclude Kesavan, c'è un Primo mondo che emerge da questa storia non ancora conclusa. E la capitale di questo Primo mondo si chiama Seul.







