Nadežda Mandel'štam, la parola non terminata
Nel secondo libro di Memorie di Nadežda Mandel'štam (Speranza abbandonata, Ed. Settecolori, Milano, 2024, p. 880), leggiamo, senza mediazioni, il ‘dolore espresso’ di Nadežda: “Ma come posso dimenticare se ci hanno interrotti su una parola pronunciata a metà? Una parola che ancora mi affligge, perché la sento qui come un nodo alla gola. Vale forse la pena di invidiare la nostra sofferenza, colma di mutismo e di assurda distruzione? Morte e mutismo. E una parola mai terminata. Se non fosse stato per la fede nel nostro incontro futuro, non sarei mai sopravvissuta a questi decenni passati da sola. Rido di me stessa, non so alimentare questa fede che tuttavia non mi abbandona. L’incontro ci sarà, la separazione non esiste. Così mi hanno promesso, ed è questa la mia fede” (SA, 386-387).
Da questa parola mai terminata inizia il libro. Scrive Nadežda: “Mi attende un compito nuovo e non so come affrontarlo. Prima tutto sembrava ovvio: bisognava custodire i versi e raccontare quello che ci era accaduto” (SA, p. 15). Ma tutto questo sembra fragile e insufficiente, adesso, alla moglie di Osip, al suo sconfinato desiderio di giustizia. Lei stessa lo afferma poche pagine dopo: “Io parlo di chi, come me, ha avuto fortuna ed è riuscito a conservare la libertà. Conoscevo bene quell’esistenza che la libertà ci riservava, ma non dimenticavo chi era finito dietro il filo spinato” (SA, p.16).
Nel 1972, in collaborazione con Nadežda, Serena Vitale aveva pubblicato una selezione delle sue Memorie per l’editore Garzanti con il titolo: Nadežda Mandel'štam, Le mie memorie. Con poesie e altri scritti di Osip Mandel'štam. Già allora Vitale osservava come fosse necessario “rendere giustizia a un grande poeta, umiliato in vita da persecuzioni ottusamente crudeli” (MV, p. 5). Già allora, per la critica e saggista, era indispensabile rendere giustizia alla vita “offesa” del poeta russo, una storia che occorreva definire nella giusta misura di un destino, tragico nella sua esemplarità.
In questo secondo libro di Memorie emerge con chiarezza la personalità di Nadežda, che Josif Brodskij liquidò come una “non-persona”, perfetta nel trascrivere i versi del marito, abituato da sempre a parlare ritmicamente e a non scrivere direttamente su carta. Proprio quella “parola mai terminata”, scritta in foglietti sparsi e ricordata oralmente dalla vedova, “persona” e autentico “testimone”, resta oggi lapidario atto di accusa contro l’intelligencija sovietica che ha offeso un poeta sulla cui grandezza oggi la civiltà occidentale non nutre alcun dubbio. “Il libro che sto finendo – annota Nadežda – potrebbe andare perduto. Non c’è niente di più facile che distruggere un libro prima che sia diffuso nel samizdat e stampato in tipografia come avveniva nell’epoca gutemberghiana della storia russa. Ma, anche se perirà, non andrà completamente perduto. Prima di essere bruciato sarà letto da esperti nella distruzione di manoscritti, parole e pensieri. Non capiranno nulla, ma nelle loro teste si conficcherà l’idea che la vecchia pazza non teme nulla e disprezza la forza. Che riconoscano almeno questo” (SA, p 864).

La “vecchia pazza”, la moglie di Osip, è co-autrice volontaria dell’opera del marito, destinata, senza la sua presenza, a rimanere dispersa. Se vogliamo sperare che non tutto si distrugga, è necessario che certe voci esistano per ricordare altre voci. “Il silenzio al silenzio fa la guardia” osserva Anna Achmatova, amica intima di Nadežda e di Osip. Ad Anna, che si lamentava della penuria di cibo negli anni sovietici postrivoluzionari, Osip rispondeva: “Di cosa ti lamenti? Solo da noi hanno rispetto per la poesia, visto che si uccide in suo nome!”. Attraverso la parola di Nadežda non solo rivive il destino del poeta scomparso, visto nel suo quotidiano inventare e reinventare la musica dei suoi versi, ma soprattutto i rapporti, effimeri e dolorosi, che il poeta, i suoi amici, la stessa Nadežda, intrecciano faticosamente in quegli anni dove la vita è insidiata dai tradimenti, dai soprusi, dalla morte. Memorabili, nelle sue scritture fitte di ricordi, certi ritratti di poeti contemporanei. “Posso aggiungere che è difficile immaginare due persone più diverse: Mandel'štam dinamico, asciutto, allegro, loquace e pronto a reagire al minimo stimolo, e Chlebnikov, chiuso e confinato in se stesso, taciturno, capace solo di annuire, rigirando senza sosta frasi ritmiche nella sua mente. Sono convinta che non esiste lettore in grado di amare contemporaneamente questi due poeti. Non è possibile. Il lettore meccanico, quello che si inebria solo del ritmo e dell’aspetto esteriore della parola, servendosene per soffocare la propria coscienza, può far convivere qualsiasi cosa, ma il lettore che sa penetrare il significato profondo del pensiero poetico, potrà vivere o nel mondo di Chlebnikov o nel mondo di Mandel'štam. Se esiste qualcuno capace di vivere nell’uno e nell’altro, allora lo definirei ricorrendo a un termine mandel’stamiano: ‘onnivoro’. Mandel'štam non sopportava questo genere di individui e considerava la capacità di scegliere e di definire il proprio universo come la caratteristica distintiva di un essere umano” (SA, p. 145). Capacità di scegliere e di definire in cui eccelle Nadežda, che nella cronaca di quegli anni non risparmia né lodi né giudizi a nessuno, viva sempre intorno al suo Osip, sole della sua esistenza nei diciannove anni di matrimonio e nei quarantadue di vedovanza. Sembra singolare che il ruolo di testimone postuma del poeta amato l’abbia liberata da ogni censura espressiva e abbia fatto di lei non solo un’osservatrice scrupolosa e appassionata, dotata di prodigiosa memoria, ma una scrittrice di vasto, felice respiro. Nadežda non è solo testimone di una delle poesie più originali del XX Secolo ma appassionata rabdomante di quell’opera: i versi di Osip che lei ha trascritto entrano nella storia della letteratura grazie alla trascrizione della sua mano e alla memoria della sua mente. Purtroppo, però, non ha vissuto il destino di Antigone. Come scrive Nadežda: “Ho sempre invidiato Antigone – non colei che accompagnò il padre cieco, ma quella successiva, che diede la vita per il diritto di seppellire il fratello” (SA, p. 219). Alla sposa di Osip fu negato il destino di piangere il suo corpo, di congedarsi fisicamente da lui. Da un uomo che sentiva oltre la musica delle cose. “Puskin è l’unico poeta – riferisce Nadežda dagli appunti di Osip – giunto alla soglia di una comprensione autentica e matura di Dante, poiché il fascino esclusivamente vocale, fisiologico del verso gli era sempre andato stretto, anzi aveva paura di diventare schiavo e di attirare su di sé la tetra fine di Tasso” (SA, p. 355). Mandel'štam aveva sempre considerato la poesia una “schiava liberata da Dante”.
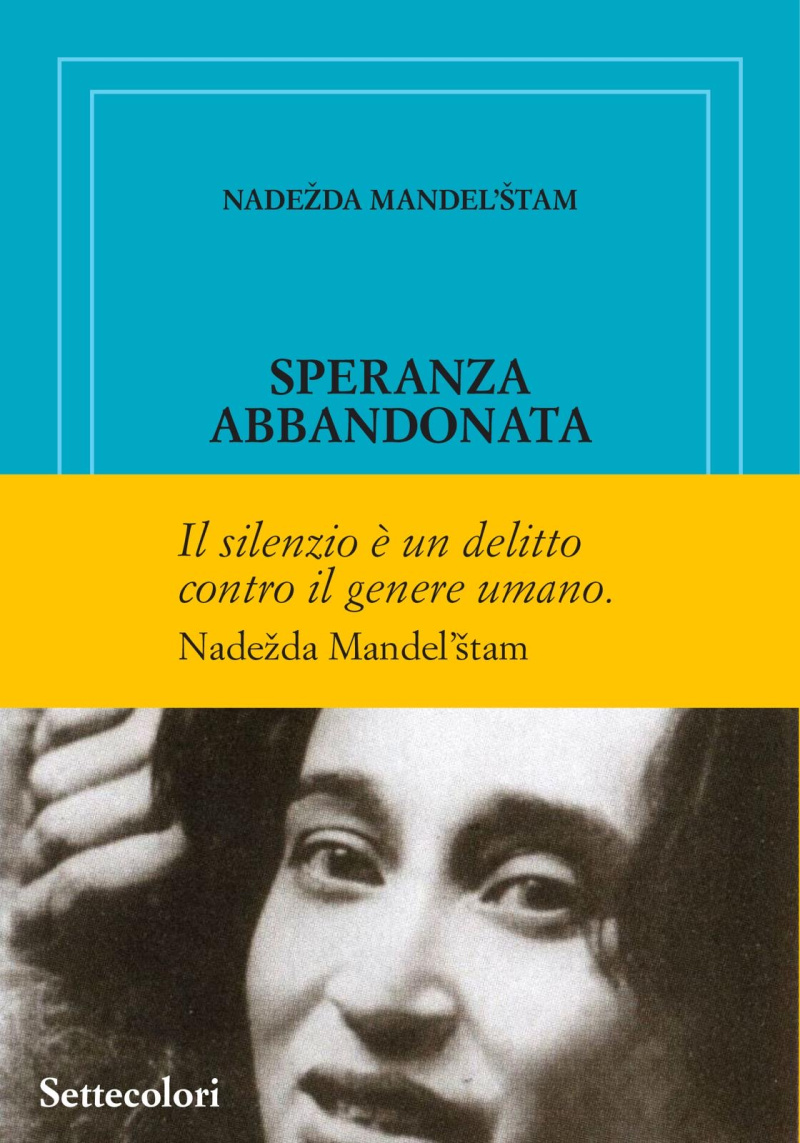
Osserva Josif Brodskij: “C’è da rimanere trasecolati quando ci si rende conto che Madame Mandel'štam scrisse quei suoi due volumi all’età di sessantacinque anni. In famiglia lo scrittore era Osip, non Nadežda. Se lei aveva scritto qualcosa prima di quei volumi, si trattava di lettere agli amici o di appelli alla Corte Suprema. Non si può parlare, nel suo caso, di una persona che, arrivata alla pensione, ripercorre tranquillamente un’esistenza lunga e ricca di avvenimenti. Perché i suoi sessantacinque anni non erano stati propriamente normali. Non per niente c’è nel sistema penale sovietico un paragrafo in cui si specifica che un anno scontato in certi “campi” vale per tre. A questa stregua le vite di molti poeti russi, nel nostro secolo, sono quasi arrivate ad eguagliare quelle dei patriarchi biblici – con i quali lei aveva in comune un’altra cosa: la devozione alla causa della giustizia. E tuttavia non fu solo per devozione alla giustizia se all’età di sessantacinque anni prese la penna e usò la parentesi della tregua per scrivere quei libri. Ciò che li fece nascere fu una ricapitolazione, su scala individuale, di un fenomeno che già una volta aveva avuto luogo nella storia della letteratura russa. Penso all’avvento della grande prosa russa nella seconda metà dell’Ottocento. Questa prosa, che può apparire nata del nulla, un effetto di cui non è discernibile la causa, in realtà era semplicemente un prolungamento, una meteora staccatasi dalla poesia russa dell’Ottocento” (FB, pp. 96-97). Ricapitolazione che, nel caos di queste Memorie, è letterale resurrezione visiva e sensoriale del marito amato, colto nei minimi gesti e nelle singole parole, e di tanti poeti che incrociarono la loro vita con la sua, nel bene e nel male. Le Memorie di Nadežda sono il lungo poema del ri-sorgere di un’epoca, quella della poesia russa di inizio secolo, che qui non viene mitizzata o reinventata ma narrata nella capillare fermezza di una memoria offesa dal dolore, dentro un abisso che genera altri abissi di ricordi, che ruotano sempre attorno alla figura dell’amato, la cui vita non smette di essere viva nelle parole della sposa abbandonata, vecchia ma felice che Osip possa ardere grazie alle sue parole, fiamma perenne e unica. Non sfugge a Nadežda il potere tanto simbolico quanto reale della sua scrittura: “Non si può ubriacarsi come porci per sfuggire alla realtà, non si possono collezionare icone russe e mettere i cavoli sottaceto finché non verrà detto tutto fino all’ultima parola, fino a quando non verrà ricordata ogni moglie che ha seguito il marito nel lager o è rimasta a casa, ingoiando la lingua. Chiedo a tutti di passare in rassegna i miei sogni di cinquant’anni, compresi i trent’anni di solitudine assoluta. Provate, iniziate, poi forse non avrete più voglia di uccidere” (FB, pp. 850-851).
Se riflettiamo alla sua lunga vita, quasi pensiamo che Osip sia stato graziato dalla morte, benché sia stata una morte tragica e crudele. Lei, destinata a sopravvivere e a testimoniare per lui, ha sofferto, per un tempo psichico e fisico interminabile, ancora più crudele, la sua morte, senza poterle più sfuggire, raccontandola ancora, perché non aveva “ingoiato la sua lingua”. La scrittura delle sue Memorie, invece di essere solo il racconto biografico e autobiografico del tragico poeta russo, è un poema che termina la “parola mai terminata”, che invade le vite del morto e della superstite, e si chiude non con una postfazione ma con la lettera reale dell’autrice, ma scritta il 22 ottobre del 1938, a Osip che immagina morto, mai spedita, lettera scritta e non arresa alla morte: “Osip, caro, amico mio lontano! Tesoro mio, mi mancano le parole per questa lettera, che forse tu non leggerai mai. La affido allo spazio… La vita è lunga. Deve essere lungo e difficile morire da solo, da sola. Possibile che proprio a noi inseparabili tocchi questo destino?… L’ultimo sogno: sto comprando qualcosa da mangiare nel lurido buffet di un lurido albergo. Sono circondata da perfetti sconosciuti e, dopo aver comprato tutta quella roba, mi rendo conto che non so dove portarla, perché non so dove sei tu. Quando mi sono svegliata ho detto a Sura: Osja è morto. Non so se sei vivo, ma da quel giorno ho perso ogni tua traccia. Non so dove sei. Puoi sentirmi? Sai quanto ti amo? Non ho avuto il tempo di dirti quanto ti amo. Non riesco a dirlo nemmeno adesso. Dico soltanto: per te, per te… Sei sempre con me e io, selvatica e cattiva, io che non ho mai saputo semplicemente piangere – io adesso piango, piango, piango. Sono io, Nadja. Dove sei? Addio”.
Libri consultati:
Josif Brodskij, Fuga da Bisanzio, Adelphi, Milano 1986 (FB)
Nadežda Mandel'štam, Le mie memorie. Con poesie e altri scritti di Osip Mandel’stam, Garzanti, Milano 1972 (MM).
Nadežda Mandel'štam, Speranza contro speranza, Memorie 1, Edizioni Settecolori, Milano 2022 (SCS).
Nadežda Mandel'štam, Speranza abbandonata, (trad. di Valentina Parisi e Marta Zucchelli, Introd. di Paolo Nori, Edizioni Settecolori, Milano 2024 (SA).
Osip Mandel'štam, Poesie, Garzanti, Milano 1972 (PM)
Leggi anche:
Marco Ercolani - Nadežda Mandel'štam: questa contrada nell'acqua buia







