La voce degli dei e la coscienza
In Le voci perdute degli dèi. Sull’origine della coscienza (Tlon editore, 2021), lo psicologo americano Julian Jaynes (1920-1997) scrive: «Chi sono io? Si tratta di una domanda estremamente importante che sorge in diversi momenti della nostra esistenza, in particolare durante l’adolescenza: Chi e che cosa sono io? Ho uno scopo nella mia vita? Che significato ha la mia vita?… Vorrei ricordare Peer Gynt, il più grande poema drammatico di Henrik Ibsen. In una delle sue grandiose scene Peer Gynt, dopo aver vissuto avventure straordinarie di vario genere, giunge a chiedersi: “Qual è il mio vero sé?”. Tira fuori una cipolla e dice: “Adesso ti sbuccio, mio caro Peer”. Sbuccia allora il primo strato, poi il secondo... avvicinandosi al sé autentico toglie un altro strato, poi ancora un altro, finché... non rimane nulla» (VPD, p. 13). Jaynes coglie, in questo percorso di esfoliazione verso il nulla, la consapevolezza dell’essere-nel-mondo. La sua ipotesi, sviluppata nel suo capolavoro Il crollo della mente bicamerale (Adelphi, 1996) è questa: la memoria cosciente nasce intorno al 1000 A.C., cento generazioni fa, e l’origine della coscienza coincide con il “crollo della mente bicamerale”. La mente bicamerale, nella riflessione di Jaynes, è una mente divisa a metà: da un lato c’è la parte esecutiva, che edifica gli eventi, e dall’altro quella decisionale, incarnata dalla voce degli dèi, l’allucinazione imperativa che comanda quegli eventi. L’esempio fondamentale è il “Sogno di Agamennone”, nell’Iliade, quando Zeus appare in sogno al re acheo e gli impone di conquistare Troia. Non esiste ancora, qui, una facoltà critica o una funzione coscienziale: la voce del sogno impone, la volontà della veglia dispone, in un patto implicito di sacra ubbidienza.
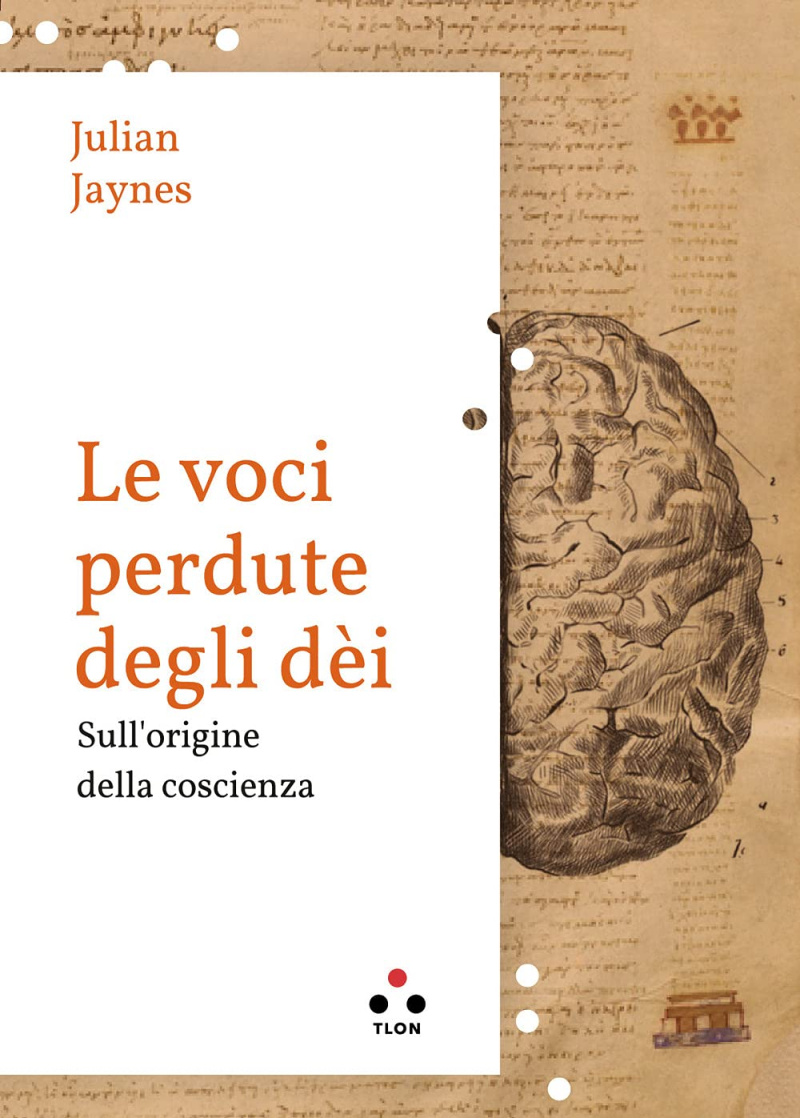
Se il mondo antico è immerso nelle voci degli dèi e solo dal crollo della mente bicamerale che ospita queste voci nasce la funzione della coscienza, se ne potrebbe dedurre che, quando la follia sparisce come voce, appare la ragione. Ma è una deduzione corretta? “Gli dèi sono diventati i sintomi” – afferma Jung quasi con rimpianto. Se il “sentire le voci” è un sintomo schizofrenico, “non sentirle più”, vivere il loro definitivo silenzio, sarebbe davvero il segno di una guarigione in corso? Il processo non è così lineare.
Anil Seth, celebre neuroscienziato contemporaneo, in Come il cervello crea la nostra coscienza, afferma che è proprio il nostro cervello a creare l’esperienza cosciente. Noi non percepiremmo il mondo come oggettivamente è, ma saremmo in grado di inventare e correggere la percezione. Ma cosa vuol dire essere un “sé” e distinguersi da un altro sé? Noi tutti “siamo”, in quanto esseri dotati di una struttura mentale che aderisce alla realtà e per i quali percezioni ed esperienze sono l’ininterrotto lavoro della mente: vedendo, ascoltando, toccando, introduciamo nella nostra testa (cervello e mente) dati che poi dovremo elaborare, formuliamo ipotesi plausibili sulle cose, creiamo “allucinazioni percettive” che solo la realtà potrà confermare, in un continuo processo di adattamento dei dati sensoriali e percettivi. Se la conferma non dovesse arrivare, cambieremmo ipotesi riadattandola: questo è il concetto che va sotto il nome di coscienza. Per ragioni psicologiche ed evoluzionistiche siamo abituati a pensare che la percezione del nostro essere noi stessi, in prima persona, sia un’idea spontanea, immediata, e quindi vera, come accade nel cogito cartesiano: “penso, dunque sono”, e sono me stesso. Chi altri dovrei essere, se non io? Invece non è così semplice.

Proprio il “Chi sono io?” apre un palinsesto di domande ed è la prima domanda che Jaynes si pone, a inizio libro. Il sé, in prima persona, è frutto di una costruzione mentale utile al nostro organismo biologico per sopravvivere nel mondo. L’essere se stessi, la prospettiva di percepire le cose in prima persona, è la nostra verità del reale. Ma, poiché questa verità è diversa per ognuno di noi, non ci agitiamo forse nella zona d’ombra delle dispercezioni? Se per Seth il nucleo della coscienza è il cervello che la genera, un filosofo contemporaneo, David Chalmers, in Che cos’è la coscienza? (Castelvecchi, 2020) enuncia il problema diversamente: perché mai dalle cellule del cervello dovrebbe nascere qualcosa di simile alla coscienza? La coscienza è un labirinto che si compone di livelli diversi, di forme multiple, e non assomiglia mai a un unico modello. Se la intendiamo come “vigilanza”, andrà dallo zero del coma e dell’anestesia fino ai sogni febbrili e alle dispercezioni poetiche o psichedeliche (forme differenti di allucinazioni, comunque coscienti), talvolta legate alle dissociazioni della follia. Sotto il profilo dell’identità personale il viaggio si compie dalla percezione di essere corpo, nella prospettiva della prima persona, fino al sé narrativo e sociale: è la narrazione continua di noi stessi attraverso la memoria a costruirci un’impressione di identità personale, imprescindibile per non frantumarci. Il groviglio dei riferimenti teorici produce una realtà indefinita, disseminata, porosa, multipla di sé. Quando usciamo da queste fluttuazioni non siamo convinti di tutte le soluzioni proposte, ma qualcosa abbiamo intuito di quella complessità irriducibile alla ragione comune, che è la coscienza.
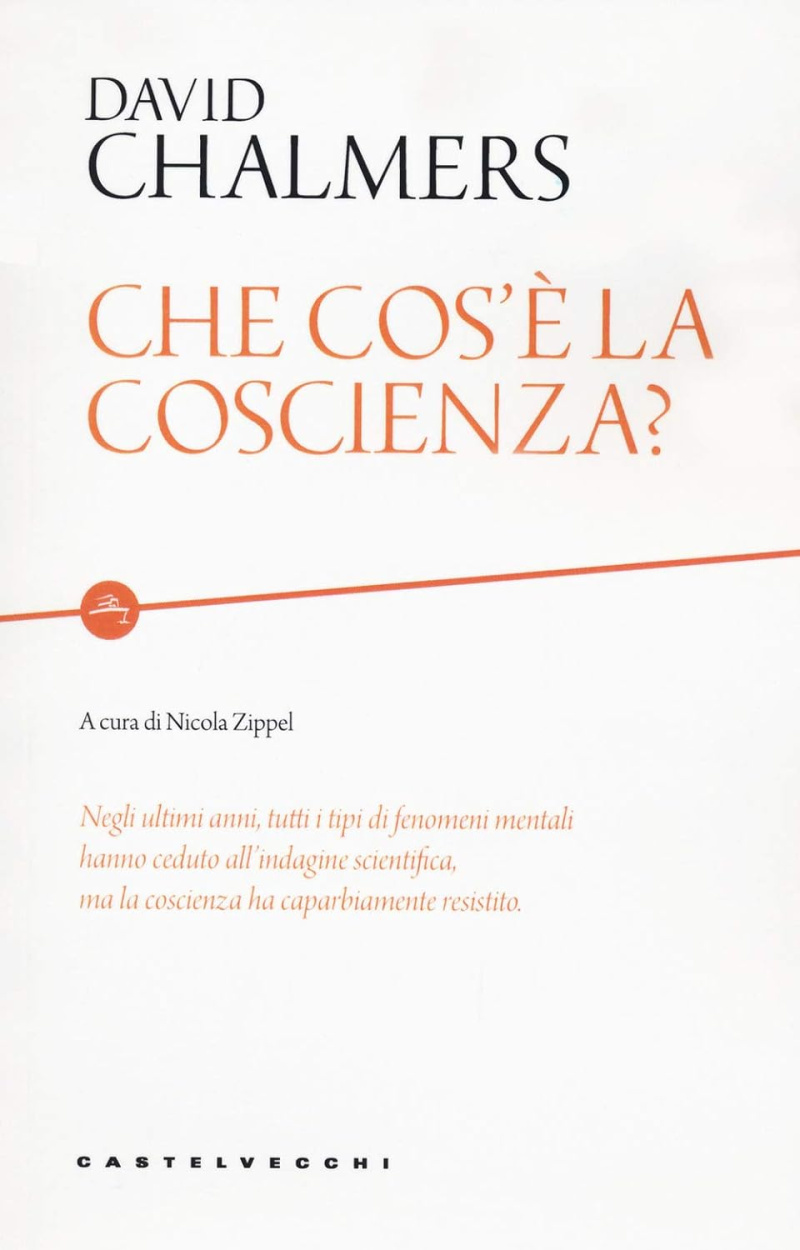
Anche secondo Antonio Damasio la mente non è, cartesianamente, un distillato mentale di razionalità, ma vive e si forma nell’intimo legame con la corporeità, con l’emozione. Nel suo L’errore di Cartesio (EC, p. 189), scrive: «Circa un secolo fa William James, le cui intuizioni sulla mente umana si possono porre a confronto solo con quelle di Shakespeare e di Freud, formulò un’ipotesi sorprendente sulla natura dell’emozione e del sentimento. Egli scriveva: “Se noi immaginiamo qualche emozione intensa e poi cerchiamo di astrarre dalla nostra coscienza di essa tutte le percezioni dei suoi sintomi corporei, troviamo che non rimane nulla, che non vi è una “materia mentale” della quale l’emozione possa essere costituita e che tutto quello che rimane è uno stato neutro e freddo di percezione intellettuale”» (EC, p. 189). E invece una materia mentale esiste: non come cellula esatta, non come freddo nucleo percettivo, ma come ricerca di una identità mobile, reversibile, nebbiosa, connessa alle emozioni del corpo e al caos del mondo. Scrive Edouard Glissant: «Credo che ci sia “un’evoluzione generale della scienza” che ci interessa dal punto di vista della questione stessa dell’identità. La scienza occidentale nel suo momento di trionfo, cioè quando non aveva alcun dubbio – né sul suo avvenire né sui suoi metodi – aveva la pretesa di andare in profondità, continuamente, anche al prezzo di rivoluzioni drammatiche del pensiero, verso una verità che sarebbe stata la verità della materia e che un giorno o l’altro avrebbe fornito la spiegazione dell’universo, del mondo. Questa era la pretesa della scienza occidentale. Fino al giorno in cui le rivoluzioni della scienza hanno mostrato, a partire dal principio di indeterminazione di Heisenberg, che forse non si potrà arrivare al “fondo della materia” (…) Questo principio di indeterminazione è diventato uno dei luoghi comuni del pensiero contemporaneo. C’è un’opacità della materia che è qualcosa di inevitabile, di insuperabile. Ed è a partire da questo momento che la scienza occidentale opera la propria rivoluzione e produce le nuove teorie che hanno formato la scienza del caos, in cui si rinuncia alla linearità equazionale, cioè alla pretesa di andare in profondità (radice unica…) a favore di una verità che sarebbe quella della materia e dove si comincia a dire che bisogna descrivere quello che c’è nell’estensione, che è indescrivibile. Bisogna cercare di descriverlo e di non avere la pretesa di una conoscenza assoluta alla quale arrivare (SC, pp. 64-65).
Ridotta la “pretesa di una conoscenza assoluta”, non ci resta che approfondire la nostra esperienza sensoriale e mentale. Impossibile dimenticare l’approccio percettivo che ha rivoluzionato i nostri parametri conoscitivi come i “neuroni specchio”. Sono proprio i neuroni-specchio a provarci che il mondo esterno, le cose viste, i gesti degli altri, sono fondamentali per influenzare le nostre attività neuronali, che così smettono di essere isolata astrazione della mente e ci “connettono” al nostro essere nel reale, trasformandolo. Chi ci guarda dall’esterno può mutare il nostro sentimento del mondo: ecco in che modo e con quale intensità si profila un labirinto della coscienza del quale noi non siamo i soli autori attivi, gli ingegneri di un congegno, ma gli attori sonnambuli o i sismografi inquieti che sorprendono passaggi e soprassalti. Nel labirinto reale in cui viviamo non è mai possibile orientarci se non per intuizioni, visioni, approssimazioni. Suggerisce Jaynes: “L’io che articola il mio pensiero cosciente è un punto in una relazione, come un punto matematico. Non è il sé, che è una costruzione completamente diversa. Si tratta di ciò che chiamo l’analogo “io”, capace di muoversi nell’immaginazione e fare cose che il mio corpo non sta effettivamente facendo. Giungendo a un bivio, questo “io” analogo può immaginarsi di viaggiare in entrambe le direzioni: posso osservare indirettamente il mio sé immaginario che beve da un ruscello o che lotta per strada, e può decidere quale strada prendere. Questo analogo “io” è l’agente che la mia mano ha creato mediante la metafora e che opera da spettatore interno” (VPD, p. 76).

La metafora è, allora, il nostro vero mezzo di conoscenza: impalpabile, molteplice, oggetto di ricerca e di visione. Non appagarsi di una sola visione del mondo è l’implicito suggerimento metaforico di Jaynes. Il chiedersi “chi sono io” è un’ipotesi euristica che inventa mondi o ne distrugge altri. Il crollo della “mente bicamerale”, esatta nel distinguere la voce astratta degli dèi dall’opera realizzata dell’uomo, si trasforma in un “crollo” più decisivo: quello della verità che spiega tutte le domande. Più si accresce il desiderio di conoscenza meno sono evidenti le risposte che placano quel desiderio. Non resta che “descrivere l’indescrivibile”, come ci annuncia Glissant. E l’unica soluzione possibile sembra, alla fine, lo spirito volatile e inattuale evocato da Giorgiomaria Cornelio: «Gli scenari della finzione… possono essere impiegati anche come strategie di compenetrazione del mondo escluso dalla sfera umana. Uscendo da noi stessi e dalla nostra “attualità”, facendo come se fossimo “altri”, ci scopriamo improvvisamente volatili, penetriamo spazi solitamente preclusi, prendiamo soggiorno nella vita degli oggetti, agitiamo l’intelligenza multiforme della materia. Diventiamo cioè capaci di sperimentare nuovi modi d’interazione con l’ambiente, e – allo stesso tempo – ci rendiamo conto di come una tale plasticità sia una risorsa imprescindibile per la nostra sopravvivenza» (FR, p. 258)
Libri consultati
David Chalmers, Che cos’è la coscienza? (a cura di N. Zippel), Castelvecchi, Roma 2020.
Giorgiomaria Cornelio, Fossili di rivolta, Immaginazione e rinascita, Tlon Editore, Città di Castello 2024 (FR).
Antonio Damasio, L’errore di Cartesio (traduzione di F. Macaluso), Adelphi, Milano 1995 (EC).
Edouard Glissant, Sole della coscienza. Poetica 1 (a cura di Giuseppe Sofo, con traduzione di Francesca Neri), Meltemi Linee, Milano, 2022 (SC).
Julian Jaynes, Il crollo della mente bicamerale, Adelphi 1976 (ed. economica 1996)
Julian Jaynes, La natura diacronica della coscienza, Adelphi 2014
Julian Jaynes, Le voci perdute degli dei. Sull’origine della coscienza (a cura di Marco Carassai) Tlon Editore, Città di Castello 2021(VPD).
Anil Seth, Come il cervello crea la nostra coscienza, (traduzione di S. Parmigiani), Cortina Editore, Miilano 2023 (CNC).
In copertina, Uno studioso nel suo studio, Rembrandt van Rijn, c. 1652.







