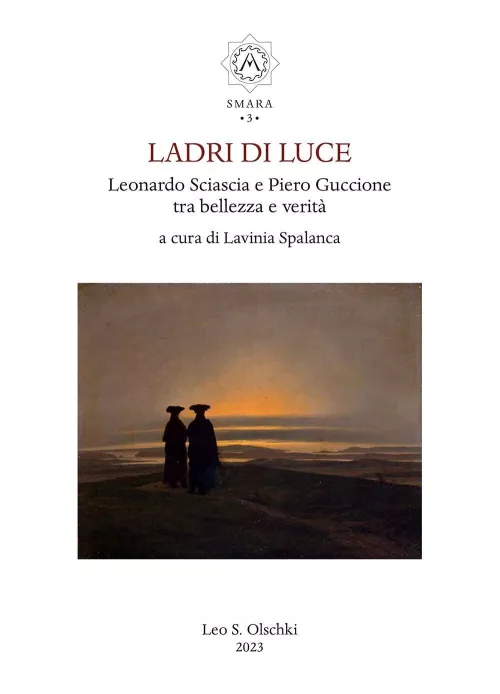Sciascia e Guccione, luce e riflessi
In un’intervista rilasciata nel 2010 a Vincenzo Cascone per il documentario Iblei. Storia e luoghi di un parco, Piero Guccione, parlando del motore che ne innescava il desiderio di dipingere, diceva: «parto sempre da, io la chiamo emozione ma insomma, parto sempre da una cosa vista che si amplifica e acquista un certo significato dentro di me, ma senza però farci una riflessione vera e propria». Concatenato a questa affermazione emerge un aneddoto sui giorni trascorsi davanti al mare di Punta Corvo: «in questa casa che avevo lì a Punta Corvo a un certo punto spuntarono dei pali di luce che non erano una bellezza, anzi erano decisamente brutti e però mi è venuta voglia di dipingerli, forse sottintendendo la volgarità. Non li dipingevo perché erano belli, li dipingevo perché erano una presenza». Tra le pagine del volume Ladri di luce. Leonardo Sciascia e Piero Guccione tra bellezza e verità, edito da Olschki nella nuova collana Smara, in collaborazione con gli Amici di Leonardo Sciascia e curato minuziosamente da Lavinia Spalanca, Dominique Fernandez ricostruisce il momento in cui questi pali vennero posizionati e che Guccione non esita a definire «un guasto irreparabile», poiché «il mare non è più vuoto» e concludendo con una sentenza che pare definitiva: «Hanno introdotto del pittoresco in quella che era pura metafisica».
La reazione chimica che porta dalla protesta alla resa in pittura è individuabile nei due termini che Spalanca posiziona in copertina: bellezza, contemplativa ed emotiva, cui potremmo legare il mare, soggetto caro a Guccione e su cui tornerò a breve, e verità, invadente ma non meno emotiva, che sposta l’attenzione del pittore dall’universale al particolare.
Se volessimo giocare a trovare un procedimento opposto e complementare, potremmo prendere a esempio le prime pagine di Il cavaliere e la morte di Leonardo Sciascia. Nel presentare l’incisione di Dürer, l’occhio di Sciascia si decentra quasi subito, attento a cercare con attenzione – come nella posa in cui lo ritrae Guccione in un famoso ritratto – un particolare da cui avviare la propria ricerca, fino a giungere al castello posto in alto, «irraggiungibile», e lì resta finché il vice non torna a osservare il quadro. Quando accade, lo sguardo del protagonista, filtrato attraverso un continuo interscambio con il reale, si allarga e, culminando sulla figura del cavaliere – rigido, corazzato e attorniato da figure grottesche e piegate dalla stanchezza – si dilata fino ad astrarre una vera riflessione esistenziale: «dentro la sua corazza forse altro Dürer non aveva messo che la vera morte, il vero diavolo: ed era la vita che si credeva in sé sicura: per quell’armatura, per quelle armi».
Sciascia e Guccione sembrano dunque costruire una ellisse di universali soggettivi intersecandosi attraverso (o a partire da) particolari oggettivi. Il punto di contatto non è mai perfettamente centrato, ma ondeggia ora piegandosi su un polo, ora sull’altro, come le due parti del simbolo taoista – o come le onde del mare. Questa percezione è rafforzata dalla stessa struttura del volume di Spalanca, che parte dagli scritti che ciascuno dei due dedica all’altro, sembra distanziarsi quando iniziano gli interventi critici (intervallati dallo studio del carteggio, che è il centro non solo tematico ma anche fisico del libro), e si riavvicina con le testimonianze dirette e con la carrellata di immagini in cui spicca proprio una foto dei due a Quartarella (Modica).

Ripercorrendo la lettura del volume quindi si è immediatamente posti davanti alla figura che ognuno aveva dell’altro. Figura che nonostante una visione politica spesso divergente – come lo studio del carteggio mostra, analizzando anche alcuni dei momenti salienti della carriera politica sciasciana – si fonda su un rispetto e riconoscimento reciproco sintetizzato perfettamente da Guccione stesso in una lettera del settembre ’79: «mi veniva in mente l’incontro o meglio lo sguardo che tanto mi ha commosso, leggendo la prima volta il Consiglio d’Egitto, tra l’abate Vella e l’avvocato di Blasi: non tutto si può dire, né tutti i vuoti che sono dentro di noi si possono colmare; ciò nonostante può accadere una volta di incrociare i propri sguardi e sentirsi fatti della stessa carne e dello stesso sangue».
L’essere fatti di una stessa pasta siciliana – più pratica e dell’entroterra quella sciasciana, che infatti per Guccione rappresentava «un punto d’arrivo, il fiore finissimo germogliato da generazioni di solfatari e contadini»; più costiera e contemplativa quella guccioniana, cui Sciascia ricollega il concetto di «platitude», di una piattezza «che non è da intendere nel senso della banalità quotidiana, della svogliante abitudine, dell’accidioso spegnersi del mondo intorno a noi; ma tutt’al contrario: come una fuga dalle sensazioni, e cioè dal tempo, per andare (e restare) oltre» – gli consente di avere un perno comune attraverso cui percorrere orbite uguali e opposte. Ecco allora che Guccione giunge a raffigurare la statua di Voltaire in Rue de Seine nello stesso momento in cui ci arriva anche il Candido sciasciano – come analizzato da Deidier in uno dei saggi contenuti nel libro; ed ecco che il solco tracciato dal lavoro sul Gattopardo di Guccione permette a Sciascia di tornare sul testo di Tomasi e di rileggerlo – come ha ben notato Bossi in un altro dei saggi del volume – distaccandosi dal primigenio scontro generazionale che l’aveva portato a “detestarlo”.
In questo percorso il mare, simbolo di «fissità mobile», ma anche strumento per individuare e catturare la luce, diviene un’ulteriore chiave di lettura sul mondo: se Sciascia sembra scandagliarlo dall’alto, in cerca della giusta luce che porti alla «trasparenza delle cose profonde», Guccione, che per il racalmutese è l’unico pittore in grado di dipingerlo, in grado cioè di «rendere questo contrasto fra vuoto e pieno» e di farci capire «che questa distesa d’un nulla infinito ha la consistenza, la compattezza, lo splendore di un oggetto materiale, robusto e duro», pare alle volte rovesciarne il monocolo e partire proprio dalle profondità del reale per catturare non una sola luce, ma una moltiplicazione di visioni che l’attraversano e vi si rifrangono. Non è questo forse quello che osservava Bufalino – terzo polo possibile di questo triangolo amicale secondo la ricostruzione che ne fa Traina – quando parlava, a proposito della pittura guccioniana, di sintesi tra “vista”, “visione” e “visibilio”?
Questo Sciascia l’aveva colto, nonostante – come scrive Guccione – non fosse un «competente di pittura […] i suoi scritti sui pittori erano sempre di grande acutezza e verità», perché «vedeva bene e con chiarezza quel che accadeva intorno», ed è attraverso quella vista che troverà nell’amore dell’amico per la pittura la stessa capacità poetica di rendere il mondo attraverso il proprio riflesso: «un quadro di Guccione, insomma, dà il senso dell’amore, della poesia: l’occhio vi si posa e vi indugia come su qualcosa di raro, di ricreante, che ancora ci fa sentire valida, autentica, l’equazione bellezza-verità».
Il continuo gioco di specchi tra i due, la ricerca di un «altro sé stesso» – per usare le parole di Paola Guccione – entro cui ritrovarsi e a cui dedicare «la propria arte, l’intera vita», il riconoscimento primordiale e affettivo emerge a viva forza, non solo dal carteggio, ma da qualsiasi stralcio che l’uno abbia scritto per l’altro: «personalmente i quadri di Piero Guccione mi aiutano a vivere, allora li amo», dirà Sciascia, «aver conosciuto Leonardo Sciascia è stata una delle cose più belle della mia vita», lascerà scritto – quasi echeggiandolo – Guccione.
Tornare a osservare il ritratto di Sciascia fatto da Guccione dopo aver terminato la lettura, analizzare quell’espressione concentrata e attenta, quella griglia che sembrava inesorabilmente separarlo dall’amico, lo pone sotto un’altra luce, e il volume curato da Spalanca ci permette di coglierne l’essenza.