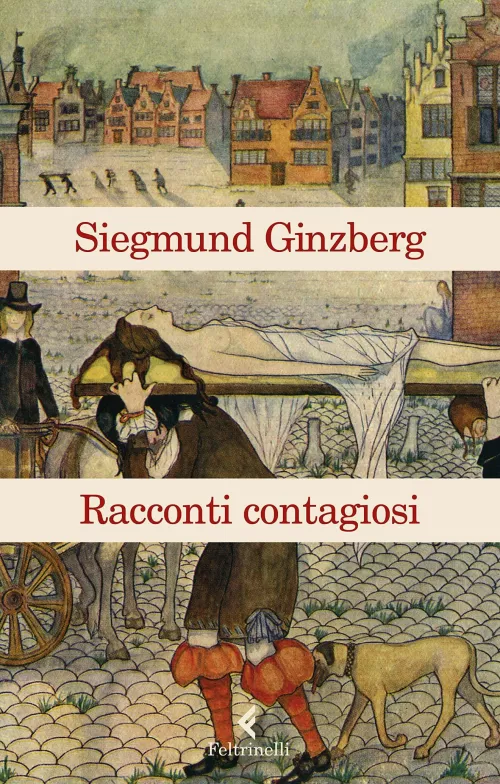Racconti contagiosi / Dalla pandemia, prose e poesia
Gli dèi tessono disgrazie affinché alle future generazioni
non manchi di che cantare
Odissea, Libro VIII
Ho da qualche tempo sul tavolo di lavoro due libri usciti nell’ultimo quarto dell’anno appena trascorso, entrambi originati dallo sforzo di raccontare e comprendere i tempi di pandemia che ci tocca vivere.
Il primo è Sospeso respiro, a cura di Gabrio Vitali, che ha raccolto e commentato i versi nuovissimi di quattro poeti italiani, nati attorno al millenovecentosessanta e attivi fra Emilia e Toscana, dei quali dirò in seguito. Vitali è bergamasco e a Bergamo, la città ferita, ha dedicato il suo libro, arricchito dai contributi iconografici di Cristina Rodeschini, direttrice dell’Accademia Carrara di Bergamo, e di Mauro Ceruti, protagonista dell’elaborazione filosofica europea del pensiero complesso. I tre sono amici fin dai banchi del liceo classico di Bergamo ma amici di Vitali sono pure, da lungo tempo, i poeti di cui sopra, così che lo spirito fecondo dell’amicizia sembra effettivamente circolare fra queste pagine.
L’altro libro è Racconti contagiosi di Siegmund Ginzberg, a lungo inviato di l’Unità in Asia e America e capitali europee e autore negli ultimi anni di pubblicazioni eccentriche e gustosissime, fra storia e memorie familiari.
Nel primo si scava nel presente, nella primavera della nostra inedita reclusione, nel sentire e nel patire di ognuno di noi. Il secondo invece sorvola i secoli e gli spazi sconfinati attraversati dalle epidemie del passato e pesca fra le mille testimonianze letterarie, ma anche pittoriche, mediche, cronachistiche e giudiziarie, di quelle catastrofi così lontane eppure così vicine e familiari. Due prospettive diverse quindi, l’una sincronica e l’altra diacronica, rappresentabili forse con le immagini comuni della scavatrice e della rete a strascico.

Mosaico romano III sec. D.C. (part.) Museo Archeologico di Susa in Tunisia.
La riflessione di Mauro Ceruti, “Un groviglio inestricabile”, con cui si chiude Sospeso respiro, ci offre una chiave possibile per afferrare il senso delle quattro sillogi poetiche commentate da Vitali. Scrive Ceruti che era stato il filosofo israeliano Yehuda Elkana a suggerirgli che “i generi della tragedia e dell’epica ci aiutano a comprendere i due atteggiamenti che si confrontano di fronte alle sfida” che la storia pone alla conoscenza e all’agire degli uomini. “L’atteggiamento tragico considera la storia come il manifestarsi dell’inevitabile… L’atteggiamento epico considera invece che ciò che è accaduto avrebbe potuto andare diversamente”.
Ecco, quello che fanno i quattro poeti di fronte all’enormità dell’evento-pandemia è adottare un approccio letterario epico e civile, direi quasi agonistico: non ci si rassegna alla solitudine né alla ritirata domestica, anzi, si rilancia un punto di vista corale allo scopo di “gettarsi fra le braccia del mondo” (Iacuzzi). Ricordava Vitali nella prefazione che “nell’epica l’autore si pone il compito di tradurre nel canto della propria vicenda soggettiva il canto a più voci di una vicenda corale… di capire e restituire le storie e le memorie di tutti nel fuoco più vivo della propria storia e della propria memoria”.
Alberto Bertoni, Paolo Fabrizio Iacuzzi, Giancarlo Sissa e Giacomo Trinci, forse per ragioni anagrafiche, sembrano condividere un’idea comune della fatica di scrivere poesia: si ha l’impressione di sentire nei loro versi risuonare l’eco delle battaglie (e delle sconfitte) che accomunano una generazione di cittadini italiani, quella fra i sessanta e i settanta per intenderci.
“Tutto si paga, nell’umano / e si sconta amplificato / ogni colpo fortunato (…) Però per pagare paghiamo / e paghiamo caro / come un tempo speravamo / che pagassero tutto / gli assortiti poteri / del denaro e del lutto”. (Bertoni)
“…E ora siamo quasi / da soli. Sopravvissuti a pensare ciò che saremo poi. Quando / potremo coatti uscire di nuovo a correre nei prati. Ma non avremo / la libertà di ora. Saremo di nuovo consegnati ai nostri desideri. / Ai nostri consumi. Mentre questo poco ci basta”. (Iacuzzi)
“10 marzo: il virus ci mette di fronte a noi stessi: / i vili nella viltà, i generosi in dignità, gli ignavi nella pochezza. / L’ottusità della fretta sfuma in lontananza, il mondo si svela nella / sua ineludibile concretezza. / Sia ognuno presente a se stesso, se può, / senza scuse, senza volgari infingimenti”. “06 marzo: Il mondo quando ha paura diventa il posto delizioso dove studiare / l’arte di fermarsi”. (Sissa)
“Ho deciso di tenere a distanza / la distanza, per infettarmi bene / di accostata letizia e disianza”. “Ripensare il respiro è la poesia, / la critica feroce, inapparente, / per un presente che, mai più, non sia”. (Trinci)
È sempre difficile dare conto in poche righe del cammino diverso, degli incroci e delle traiettorie che intersecano l’esperienza letteraria degli autori di un’opera, per così dire, collettiva. Occorre semplificare, a rischio di erodere la complessità dei singoli dettati. Lo sa chi scrive articoli simili e lo sa chi li legge, spero. Me ne scuso e mi affido, infine, agli auspici di Vitali: “Essere almeno in due: la poesia è un operatore di civiltà. È un fatto comunitario. Un antidoto alla solitudine. (…) È la risposta del lettore, in ultima analisi, che completa e ogni volta riapre un’opera di poesia. La fa durare”.
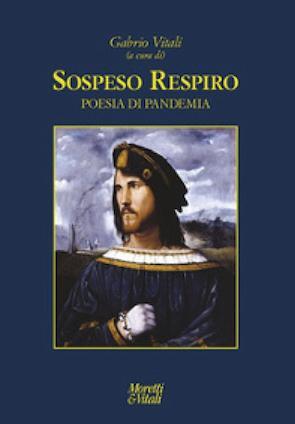
A metà circa del suo Racconti contagiosi, Ginzberg ci racconta qualcosa della peste del 1575 a Venezia, che costò la vita di quasi un terzo dei residenti lagunari: in quell’occasione il Senato della Repubblica aveva disposto la chiusura della grande fiera agostana di Bergamo, da decenni appuntamento annuale per migliaia di mercanti veneti, lombardi, svizzeri e tedeschi. La città non la prende bene e protesta al punto da ottenere la revoca del provvedimento. Anche l’ultima grande epidemia di peste in Europa occidentale, quella del 1720 a Marsiglia, era stata originata dall’irresponsabilità dei commercianti della fiera di Beaucaire in Occitania, mandanti dello sbarco clandestino di merci bloccate per la quarantena imposta dalle autorità portuali marsigliesi. A Parigi, invece, dove all’inizio del dicembre 1889 comincia a diffondersi una temibile epidemia influenzale arrivata dalla Russia, si scatena la polemica sui giornali: il contagio era partito fra clienti e commessi dei Grands Magasins du Louvre, la paura di compromettere il buon andamento delle vendite natalizie dilaga fra i commercianti. Louis Pasteur non sa che pesci prendere mentre l’ispettore generale dei servizi d’igiene, Adrien Proust (sì, è il padre di Marcel), invita alla prudenza. Non ci si mette d’accordo e così, a fine anno, le pompe funebri non riescono più a smaltire il lavoro arretrato e i contagi giornalieri si contano a migliaia.
Ecco come Ginzberg, ricordandoci il passato, ci mette in guardia: a chi non vengono in mente, leggendo delle resistenze alle misure sanitarie di quei commercianti, le pressioni esercitate in Lombardia la scorsa primavera per evitare la chiusura della Valle Seriana? A me che ci vivo, un po’ sono venuti i brividi.
Racconti contagiosi, però, non ha nulla a che fare con il genere del pamphlet polemico: innanzitutto per la tonalità sorridente della scrittura, che percorre tutto il libro e rende piacevolissima la lettura, e poi per la vastità dei contenuti, a partire dalla vertiginosa rassegna dei rimandi letterari che illustrano come, a partire da Sofocle e Tucidide (V sec. A.C.), tutti gli scrittori che hanno intercettato il tema della pandemia si siano abbeverati degli stessi racconti, a volte addirittura delle stesse ricorrenti metafore. Si va dagli autori greci citati ai latini, Lucrezio, Ovidio, Tito Livio, Procopio di Cesarea, che ritroviamo (non citati) nei grandi medioevali, Boccaccio, Villani, lo stesso Petrarca. E quelle storie rimbalzano poi in Machiavelli e Rabelais, Shakespeare e Montaigne, su su, fino a Defoe, Chateaubriand, Manzoni, Camus. Già l’impagabile Luciano, nel II secolo, aveva fatto satira sul cronista Crepeius Calpurnianus di Pompeiopolis (!) che narra della peste siriana copiando pagine intere della descrizione della peste ateniese di Tucidide…
Scrive Ginzberg: “Anche i virus copiano, all’infinito: copiano se stessi, e, tanto per non annoiarsi, introducono mutazioni, fanno errori di trascrizione (…) I libri – anche, oserei dire soprattutto, i grandi libri – si contagiano l’un l’altro. Non è banale plagio. È un contagio estremamente produttivo”.
Spesso sembra sorridere, Ginzberg, ma in realtà vola alto, anche sulla storia della medicina, e ci offre spunti per riflettere maledettamente seri. Come quando ci mette di fronte all’odio per i medici nella Milano infestata dal colera del 1835 o a Liverpool, due anni prima, dove ottanta sanitari denunciano ‘vergognose aggressioni’. Oppure quando, implacabile, ci ricorda i pregiudizi, il negazionismo e la caccia al capro espiatorio che caratterizzano in tutta Europa i comportamenti collettivi dal medioevo fino alla Germania dell’inizio del XX secolo, dove il tifo era chiamato Judenfieber, febbre giudaica. “E forse non è un caso che per sterminarli poi usarono il Zyklon B, ritrovato che originariamente doveva servire a eliminare i pidocchi, portatori di tifo”.
Talvolta una paura cancella l’altra: chi ha più sentito parlare qui da noi, dalla primavera scorsa, dei pericoli dell’immigrazione clandestina? Un’ultima perla ci regala Ginzberg, quando ricorre alle parole pronunciate da Edgar Morin nel corso di un’intervista del 1993: “Funzioniamo così. Siamo condannati ad apprendere a vivere con l’incertezza […] Non so se una grave crisi travolgerà il nostro mondo o se, al contrario, ne usciremo apprendendo che bisogna vivere con una certa dose d’incertezza […] I capri espiatori non sono l’unico modo di sopportare l’insopportabile. Esistono anche la convivialità, la solidarietà. I periodi di grande turbamento generano generosità, dedizione, partecipazione alla collettività e, infine, l’amore. La riaffermazione di un legame è uno dei grandi antidoti contro la paura: due esseri che si amano non si dicono continuamente che moriranno, e nemmeno che invecchieranno”.
Inutile dire che un lavoro simile non poteva che chiudersi con una bibliografia che da sola vale il prezzo del volume; si tratta di un vero e proprio capitolo, brillantissimo, dal titolo “Virologia di questo libro”, che consiglio di leggere fino all’ultima riga. Anche perché vi si condensano le ragioni per affermare che forse una strategia per sopravvivere alla pandemia esiste e sarebbe quella di raccoglierci e scaldarci attorno al gran fuoco della narrazione. E della poesia.