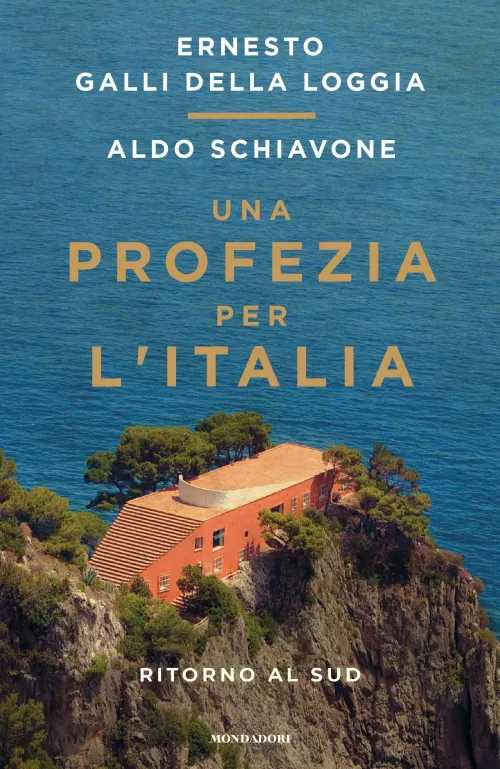Una profezia per l’Italia: ritorno al sud
Non sempre la fusione tra due soggetti ha un esito felice. In politica abbiamo più di un esempio di amalgama mal riuscito. E anche nella scrittura non è facile fondere due personalità, due intelligenze, due stili di pensiero diversi. Sono certo – conoscendoli bene – che un timore del genere lo abbiano avuto anche Galli della Loggia e Schiavone durante la stesura di Una profezia per l’Italia. Ritorno al sud (Mondadori, 2021). Ebbene, adesso posso dire che era un timore infondato. Non perché i due autori non siano diversi – lo sono, nelle competenze disciplinari, nella prospettiva analitica, nel carattere. Ma perché in questo caso le loro differenze, anziché stridere, hanno interagito positivamente, sommandosi in un saggio di grande qualità – solido, coraggioso, innovativo.
I due tratti più marcati del loro modo di lavorare e, prima ancora, di pensare – l’ampiezza e la profondità ermeneutica da parte di Schiavone, la nettezza e l’incisività di giudizio da parte di Galli della Loggia – sono confluiti in un disegno che mette a frutto le loro differenze, senza perdere in unità e compattezza. Quello che ne è risultato è un quadro complesso, interrogato da due angoli di visuale diversi, ma convergenti su un unico fuoco.
Da un lato il Mezzogiorno guardato dal punto di vista dell’Italia e dall’altro l’Italia pensata dall’angolo del Mezzogiorno. Il tutto in una cornice europea e globale che non si limita a costituire lo sfondo del discorso, ma ne viene a sua volta illuminata. Direi che l’elemento più innovativo del libro stia proprio in questo doppio piano incrociato – a un tempo locale e globale, meridionale e nazionale, italiano e europeo – che conduce il lettore continuamente dall’uno all’altro, senza fargli mai perdere di vista la loro connessione. È un’ulteriore riprova che la novità di un’interpretazione – nella storiografia come in ogni impresa scientifica – viene sempre da uno scarto dell’ottica che modifica la visuale consueta, configurando una diversa relazione tra parti e tutto: guardato da un punto di vista particolare (quello meridionale) il tutto (la realtà italiana) può acquistare un rilievo che altrimenti restava nascosto. Ma, corrispondentemente, in un quadro più ampio, il particolare perde la propria limitatezza per attingere un significato più generale.
Questa dialettica tra parte e tutto non vale solo per lo spazio, ma anche per il tempo. Nel libro le due dimensioni, sincronica e diacronica, s’incrociano continuamente.
D’altra parte, senza geografia la storia resta indeterminata, ma senza storia la geografia rimane muta. Come è adoperata la storia in questo libro? E soprattutto storia di cosa? Galli della Loggia è uno storico della politica e Schiavo ne uno storico del diritto con una marcata vocazione teoretica. E già questa prima articolazione tra storia, politica e filosofia conferisce al testo uno spessore difficilmente riscontrabile in altri libri di storia. Difficilmente, per esempio, si trovano in essi pagine come quelle che gli autori dedicano al pensiero meridionale. Va aggiunto che le competenze degli autori non s’incrociano solo sul piano del lessico, ma anche su quello della diacronia. Schiavone è uno storico delle società antiche, Galli della Loggia uno storico contemporaneo. Ma se conferiamo al termine ‘contemporaneo’ il suo significato letterale, vale a dire di compresenza in ogni tempo di tempi diversi, anche molto lontani, possiamo dire che entrambi sono storici della contemporaneità. Per esempio, sul piano paradigmatico, un’istituzione antica può esserci più vicina di tante istituzioni moderne.
È quello che i filosofi chiamano genealogia – vale a dire la ricerca del significato di un fenomeno o di un evento a partire dalla sua origine. In questa prospettiva quanto accade in una data stagione rimanda, certo, a quel che è accaduto nei decenni precedenti, ma può trovare una risonanza, e perfino una spiegazione, in eventi accaduti diversi secoli prima. Le pagine finali sull’origine dell’Europa costituiscono un esempio straordinario di questo metodo genealogico che incrocia e mette in tensione presente e passato, in vista di un futuro che ancora non s’intravede. Quelle pagine sul rapporto tra Italia, Europa, mondo non solo non risultano estrinseche al tema del libro, ma sono del tutto necessarie a calare la questione del Meridione nella sua dimensione più propria – vale a dire nella geografia e nella storia del Mediterraneo. Senza dover evocare Braudel, o le pagine visionarie di Carl Schmitt su terra e mare, va detto che solo questa dimensione profonda, a un tempo materiale e simbolica, conferisce alle domande che il libro pone un respiro inconsueto.
Quali domande? Intanto, esiste un Mezzogiorno – qualcosa che, nonostante e dentro le sue molteplici facce, unifica il territorio che va dall’Abruzzo alla Sicilia in un quadro omogeneo? E, se esiste, in cosa si distingue dal resto d’Italia? Da dove nasce e cosa ha conservato tanto a lungo inalterata tale differenza? Infine, questa differenza, che certamente ha prodotto e ancora produce esiti negativi, può trovare una valorizzazione in un sistema italiano diversamente integrato? Intorno a queste domande gli autori costruiscono il loro disegno. Si tratta di un percorso talmente ricco, nato anche dall’interlocuzione con alcuni protagonisti della società meridionale – politici, imprenditori, intellettuali – che non può essere riassunto in poche battute. Quello che è possibile fare è indicare rapidamente alcuni snodi che mi appaiono particolarmente rilevanti. Direi tre in particolare: il rapporto tra Meridione ed Europa, il rapporto tra regionalismo e Stato nazionale e il rapporto tra antropologia e politica.
Partiamo dal primo. Alla fine del libro Galli della Loggia e Schiavone contestano l’identificazione, assai diffusa, dell’impero carolingio – quello creato da Carlo Magno in territorio franco-tedesco – con l’origine dell’Europa. In realtà quell’impero ebbe una durata assai breve, prima di essere disintegrato dalla pressione congiunta dei vichinghi a Nord, dei saraceni a sud e dei magiari a est. Se l’Europa in senso spirituale sopravvisse a queste invasioni non si deve al fragile impero carolingio, ma alla duplice, potente, eredità della Chiesa cristiana e della storia di Roma. Senza il diritto romano, senza il papato e le stesse crociate, con tutta la violenza che hanno portato nel mondo, non sarebbe nata quella che è stata chiamata civiltà cristiano-borghese. Ciò vuol dire che per quasi duemila anni, dalla fondazione di Roma al Cinquecento, il cuore, non solo spirituale, ma politico, economico, militare, dell’Europa, è stato il Mediterraneo. Solo nel tardo Cinquecento, con le scoperte geografiche da un lato e la Riforma protestante dall’altro, l’asse della civilizzazione moderna si è spostato dal Mediterraneo all’Atlantico. Ma già con l’apertura del canale di Suez, e poi con le guerre mondiali fino alla guerra fredda, il Mediterraneo è tornato a giocare un ruolo cruciale negli equilibri mondiali, naturalmente sotto l’egemonia americana, con le portaerei visibili dal centro di Napoli.
Poi, con la fine della guerra fredda e il progressivo ritiro americano, rovinosamente ultimato in Afghanistan, un ciclo si chiude. Dopo essere stato una prima volta sostituito dall’Atlantico, il Mediterraneo cede adesso il primato al Pacifico, confinato nel ruolo minore di mare di emigrazione e dunque anche di morte. Da qui la scelta dell’Europa, arroccata sulla linea Parigi, Bruxelles, Berlino, di abbandonarlo al suo destino. A tale ‘settentrionalizzazione’ dell’Europa ha corrisposto la scelta dell’Italia di ‘aggrapparsi alle Alpi’, fino a cedere all’Europa perfino il potere di legittimare i suoi governi. Ma questa – sostengono a ragione Schiavone e Galli della Loggia – è stata una scelta miope.

L’abbandono del proprio mare ha significato, per l’Italia, non solo perdita di centralità, ma anche di specificità all’interno di un continente dominato dal blocco centro-settentrionale. Una prima avvisaglia di cosa significasse questa egemonia, non solo economica, ma anche politico-culturale, la si è avuta dal trattamento della Grecia durante la crisi economica. In quella fase l’Italia è stata tagliata fuori da tutti i tavoli europei importanti, più volte umiliata dalla Francia, con cui solo adesso, in ritardo, tenta di stringere una nuova alleanza di tipo funzionale, ma priva di presupposti politico-culturali.
Ma poi il covid – che ha rivelato, accanto a una terribile carica distruttiva, anche una sorta di potenza istituente – ha cambiato le carte in tavola, restituendo all’Italia quantomeno l’occasione per modificare il proprio ruolo geo-politico e, prima ancora, il proprio profilo politico-culturale all’interno del continente. Certo, siamo lontani dal poter immaginare il Mediterraneo come mare nostrum. Ciò non toglie che un paese, quasi interamente peninsulare, con 8 mila chilometri di costa, possa ambire ad essere il necessario punto di incrocio tra Europa e Africa, valorizzando le sue risorse più specifiche – natura, arte, turismo, cucina mediterranea, da affiancare alla filiera agro-alimentare e alla ricerca tecnologica avanzata, presente in diversi centri meridionali. Non aveva torto, alla fine della seconda guerra mondiale, Alexandre Kojève, di immaginare un ‘raccordo latino’ tra Francia, Italia e Spagna, per confrontarsi da pari a pari con l’asse nordico. In questo modo, come a volte accade nella storia, è possibile rovesciare un dato negativo – il carattere geograficamente decentrato rispetto all’asse franco-tedesco-baltico – in un’opportunità positiva. A patto di riscoprire quella che gli autori chiamano una nuova consapevolezza mediterranea. Certo Lombardia, Piemonte, Veneto restano radicate nell’Europa continentale. Ma il protagonista di questa scelta mediterranea, se mai ci sarà, rimarrà il sud. Napoli, Bari, Palermo, ma anche Catania, Messina, Reggio solo nella propria mediterraneità potranno trovare quel riscatto che ancora aspettano, dando qualcosa di importante anche all’Italia e all’Europa.
Vengo così al secondo punto – regionalismo e Stato nazionale. Anche da questo lato la pandemia ha svolto una funzione apocalittica, cioè di rivelazione di qualcosa che pure avevamo sotto gli occhi: e cioè quello che Galli della Loggia e Schiavone definiscono senza mezzi termini il disastro del regionalismo italiano. Se lo si confronta con le speranze che aveva messo in moto, il regionalismo culminato con la riforma dell’articolo V, ha avuto un bilancio disastroso. Concordo con questo giudizio. La cacofonia, nei mesi più caldi della pandemia, tra poteri concorrenti nella gestione della crisi sanitaria, ma anche sociale, è stata massima. Caos, inefficienza, corruzione, ridondanza tra potere locale e potere statale hanno fornito uno spettacolo che abbiamo ancora negli occhi. Ma c’è un rischio maggiore che tocca l’equilibrio costituzionale tra i diversi poteri dello Stato, anche aldilà della vicenda pandemica. Quello che si è intravisto, in questa vertigine autonomistica, è stata una deriva regional-sovranista che profila una sorta di rifeudalizzazione a base regionale.
Quando un presidente di regione – penso a quello della Campania, ma qualcosa del genere era già accaduta in Veneto – progetta di restare al potere più di quindici anni, modificando lo statuto a vantaggio non del successore, ma di se stesso, siamo a un passaggio rischioso che rischia di rompere l’equilibrio tra i poteri: un presidente della Repubblica per sette anni, un presidente del consiglio per cinque, un sindaco per cinque e un presidente di regione per quindici? Chi, quale contrappeso istituzionale, riuscirà più a bilanciare il suo potere? Ormai la conferenza Stato-regioni è diventata di fatto una terza camera, un Senato aggiunto, senza che si sia eliminato quello esistente. Il tutto senza che sia mai stato approvato un progetto autenticamente federalista, che a sua volta andrebbe bilanciato da un potere centrale più forte. E invece nulla di tutto ciò. La confusione regna sovrana. Con una costituzione materiale in bilico tra semi-presidenzialismo e semi-federalismo, entrambi non dichiarati. Schiavone e Galli della Loggia arrivano a proporre la sospensione, in casi particolari, dei poteri regionali, in analogia con lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa. Personalmente, se ne condivido l’esigenza, l’attuazione mi pare un po’ complicata. Anche se limitata alle materie di sanità, scuola, urbanistica e beni culturali, tale procedura finirebbe per rendere normale una procedura eccezionale. Meglio, mi parrebbe, una nuova legge ordinaria che riordini il rapporto tra Stato e regioni, accentuando i poteri del primo e diminuendo quello dei secondi.
Terza ed ultima questione – quella del rapporto tra antropologia e cultura. È forse quella più importante perché sottende l’intero libro, smantellando una miriade di luoghi comuni ‘politicamente corretti’, in realtà paralizzanti rispetto all’urgenza di rompere la gabbia che va chiudendosi intorno al sud, minacciando di separarlo definitivamente dal resto d’Italia. Parlare di carattere meridionale, in senso socio-culturale, vale a dire storicamente determinato, non vuol dire in nessun modo nutrire un pregiudizio negativo nei confronti del sud e tantomeno essere razzisti. Al contrario significa amare il sud al punto di rischiare di inimicarsi i suoi difensori di ufficio. Per aiutare il sud – i suoi abitanti – è necessario non nascondere le loro responsabilità.
Poi si può dire che esso sia stato svantaggiato, trascurato, rinnegato. Ma non che non sia in larga parte responsabile dei suoi problemi. La mentalità, l’abitudine, l’attitudine a non rispettare le regole sono elementi quasi naturalizzati in chi vive nel mezzogiorno, anche in chi, come me, non è un delinquente comune. Quasi naturalizzati – tutto sta in quel ‘quasi’, che rende ancora reversibili le cose. E dunque lo Stato deve intervenire con la massima energia, nei limiti delle sue prerogative. Il problema è la formazione dell’autocoscienza dei cittadini. Dunque un problema di carattere generale, di contesto sociale, ma anche individuale. Ovviamente serve anche un forte impegno della classe dirigente. Io ricordo perfettamente che alla prima sindacatura di Bassolino ci fu un sussulto di dignità e quasi una nuova fierezza a Napoli. Poi tutto è regredito perché, tra i numerosi meriti di Bassolino, per il quale ho votato anche nelle ultime elezioni, non c’è stato quello di formare una classe dirigente alla sua altezza. Oggi, dopo l’ultima elezione, siamo lontani da aver ritrovato lo slancio di allora.
C’è un riflusso perdurante che investe l’intera società civile. Una rassegnazione all’illegalità, al degrado, alla disoccupazione giovanile – io ho tre figli, uno a Londra, una a Berlino e un altro nelle Marche. Lo sanno tutti: a Napoli non si trova lavoro o si trova solo lavoro nero. Un giovane laureato in legge a Napoli – una volta una buona Facoltà –, se è fortunato, va a fare fotocopie gratis in uno studio di avvocato o si occupa di falsi incidenti automobilistici.
Questo deriva da cause generali, nazionali, ma anche da un’attitudine locale ad accettare anche l’inaccettabile. Solo se questi due vettori – statale e locale, impersonale e personale – cominceranno a funzionare contemporaneamente si potrà avere una svolta. Come scrivono Schiavone e Galli della Loggia, la mancanza di lavoro al sud è grave quanto quella di Stato – perché Stato e lavoro sono i due passaggi decisivi alla modernità compiuta. Solo per il fatto che dice queste cose senza mezzi termini, senza ossequio ai luoghi comuni, alle frasi fatte, alle convenzioni politiche e culturali, questo libro dà una mano a rompere questa gabbia di inerzia e indifferenza. Schiavone tempo fa scrisse un libro dal titolo suggestivo Storia e destino (Einaudi, 2007). Ecco, il sud deve scegliere il primo termine. Scrollarsi di dosso il destino e assumersi la responsabilità della propria storia.
Una domanda infine. Roma – la Roma di oggi, non quella antica – è citata poche volte, forse mai, nel libro. L’impressione è che ciò nasca dalla sua difficile collocazione – né a nord né a sud, anche se in qualche modo più a sud che a nord. Ma questa mancata collocazione politico-culturale di Roma è una questione non secondaria. Intanto perché la presenza di una Roma ‘terza’, non settentrionale né meridionale, di per sé complica il quadro. Ma soprattutto lo complica perché è la capitale. La domanda è: Roma – nella sua posizione di terzietà – è ciò che congiunge il paese o ciò che lo spezza in due? Come rendere la capitale funzionale al progetto di unificazione italiana? Come fare di questa ‘estranea’, di questa città liminare, un centro propulsore? Mi sembra che senza almeno porre questa questione, non si possa chiudere il discorso, che resti, come dire, una falla, o una casella vuota da riempire.