Giulio Cesare: Shakespeare e Wilcock
Scriveva Italo Calvino, presentando ai lettori dei primi anni Cinquanta le nuove traduzioni shakespeariane di Cesare Vico Ludovici per la Piccola Biblioteca Scientifico-Letteraria Einaudi, che Giulio Cesare è «una tragedia che ha un posto tutto suo nell’opera di Shakespeare, una tragedia che unisce l’andatura d’antica cronaca dei suoi drammi storici all’intensità di passioni delle sue grandi tragedie familiari; in queste ultime è l’anima umana al centro dell’azione, mentre qui è la politica, la sorte di Roma e del mondo; l’uomo pubblico, non la psicologia individuale».
Ora Adelphi propone, nella Piccola Biblioteca, la versione che di quella tragedia dette lo scrittore argentino Juan Rodolfo Wilcock, che proprio dagli anni Cinquanta, insofferente del peronismo e forte delle sue origini inglesi e italiane, si lasciò adottare dalla cultura europea (di cui era fortemente imbevuto) decidendo di trasferirsi prima a Roma, poi a Velletri, infine a Lubriano, dove sarebbe improvvisamente morto nel marzo del 1978, nel giorno del rapimento di Aldo Moro, circondato da un silenzio inevitabile, pur essendo divenuto uno dei più efficaci attori della lingua italiana.
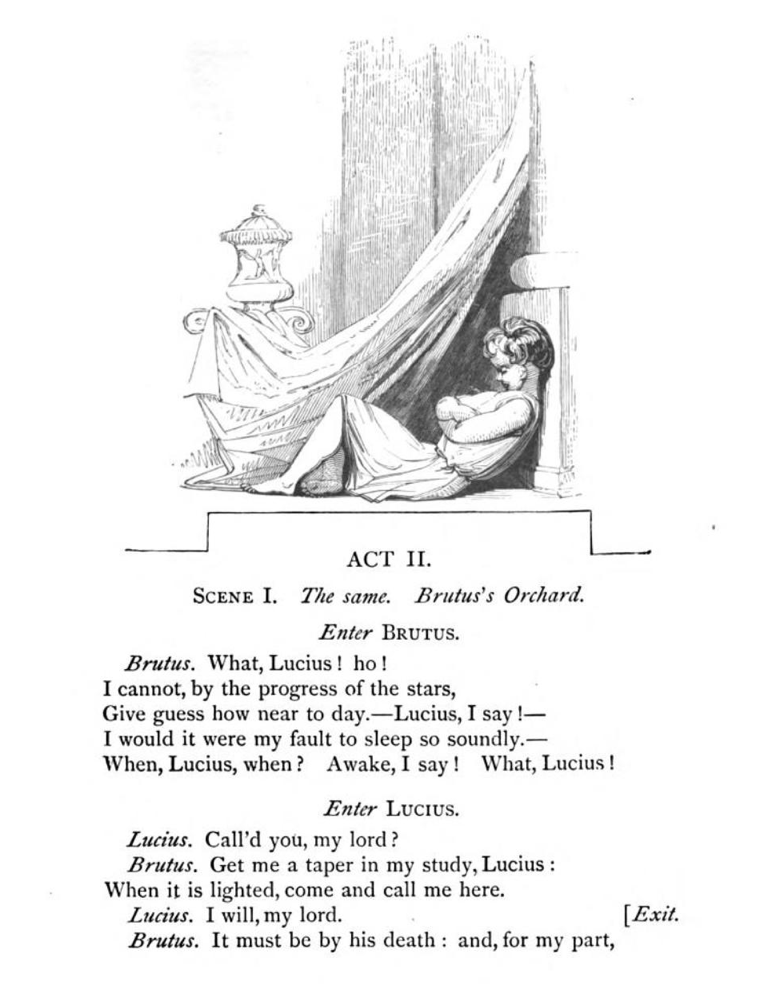
Questa edizione non ci consegna notizie sul testo: non ci viene detto in quali anni Wilcock lavorò a questa traduzione, né se fu oggetto di qualche rappresentazione o di una precisa commissione. È però accompagnata da un celebre intervento di W.H. Auden, ripreso dal volume Lectures on Shakespeare: un breve saggio che sembra fare eco alle osservazioni di Calvino, spostando tutto il focus dalla personalità dei singoli caratteri a ciò che il poeta definisce accuratamente «folla». Non «società» e neppure «comunità», «una folla è qualcosa a cui mi aggiungo»; come riporta la didascalia d’apertura, la tragedia ha infatti inizio in una strada dell’urbe, senz’altra specifica. E ogni incipit, ricorda Auden, riveste per il Bardo una speciale significazione. Una folla, di per sé, non ha alcuna funzione, eppure qui si pone come protagonista. Si sviluppa, come tale e nel ruolo che Shakespeare le affida, in due casi: quando non c’è società sufficiente e l’individuo sconta il proprio senso di impotenza o marginalità; quando, infine, assistiamo alla scomparsa delle comunità, e allora, per Auden «gli individui smettono di amare qualche cosa in particolare e non sono più in grado di operare una scelta tra amori diversi». Entrambe le condizioni sembrano attraversare il difficile tempo del Giulio Cesare; quando non sussistono più i presupposti di un’appartenenza o di un’unione, a una società e a una comunità, la folla si espande rischiando di lasciarsi trasformare in «massa sediziosa», la cui sola funzione è quella di «distruggere».
A smuovere la folla e a farne massa sono le due individualità forti di quest’opera: sul piano storico, però, poiché su quello della resa drammaturgica e della rappresentazione non tardiamo ad accorgerci che in realtà anch’esse sono due funzioni che si svolgono in rapporto alla passività della folla, su scale diverse. Parla Bruto, osserva Auden, e la folla plaude. E Calvino: «Bruto è uomo di moralità e di riflessione: lo sdoppiamento di pensiero e azione, che avrà la sua piena espressione poetica in Amleto, è già presente ed esplicito in Bruto». Ma il principe di Elsinore sconta una psiche fantasmatica, che ne disegna il dilemma fino al tragico finale; Bruto è fin da subito presente a sé stesso e alla prassi. A coinvolgerlo nella congiura non è l’apparizione di uno spettro dai recessi di una mente affatto incline alla determinazione, ma l’azione concreta di Cassio, dell’uomo ispirato dalla necessità storica. Poi parla Antonio, il personaggio che per Calvino risulta moralmente più equivoco: «La politica per lui è pura abilità, cinismo, senza punti d’onore né pietà. Il suo discorso davanti al cadavere di Cesare è un capolavoro di tecnica oratoria, che rovescia la situazione». Alle sue parole, non resta a Auden che riportare la reazione della folla-massa, che Shakespeare sintetizza mirabilmente in tre sequenze verbali: «Lo ascolteremo, lo seguiremo, moriremo con lui».
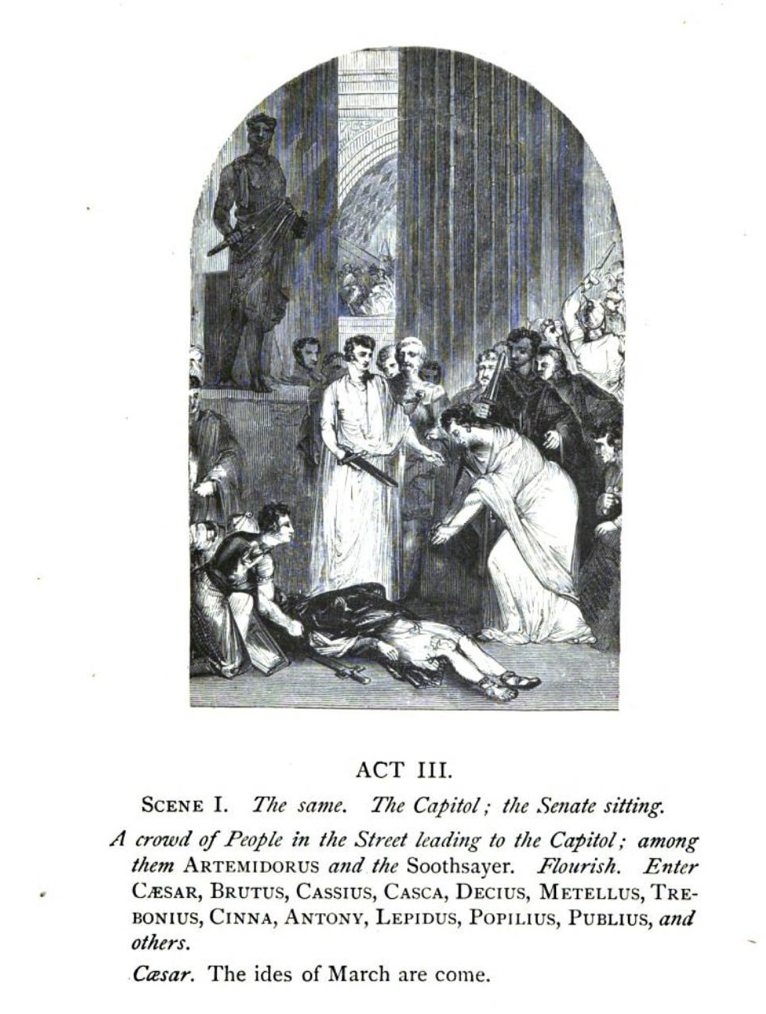
Notevole il rilievo di questo interprete d’eccezione, che partendo dal confronto con analoga scena nell’Enrico VI non può fare a meno di notare non solo «la misura dell’evoluzione drammaturgica», quanto il cambiamento di opinione della folla a ciascun intervento. La reazione ad Antonio, invece, attesta il netto crescendo di adesione da una parte, dall’altra la sapienza persuasiva, la profonda conoscenza delle passioni su cui il personaggio agisce abilmente. È anche vero, come osserva Calvino, che la storia sta già lavorando in favore di Antonio e che in quella Roma di intrighi e crescenti interessi economici i fili dovranno inevitabilmente essere tenuti da un solo potere, incarnato nel singolo; ed è proprio Antonio il grande demiurgo, colui sul quale Shakespeare può proiettare quelle indubbie doti di teatralità che ne fanno un leader forte e vincente.
Quanto alla traduzione di Wilcock, in assenza di informazioni, possiamo procedere per ipotesi, supposizioni, richiamandoci a quanto lui stesso si fosse dedicato al teatro elisabettiano. Che uno scrittore di quella tempra, votato al grottesco, al mostruoso, a improbabili gallerie di personaggi immaginari, sulla scia di Borges, tra il comico e l’inquietante, si accostasse allo Shakespeare più altamente tragico potrebbe sorprendere il lettore, se non ricorressimo a una mediazione fondamentale: quella di Marlowe, il cui teatro quasi interamente tragico, storico e politico porta sulla scena proprio la rappresentazione di quelle passioni, di quella sete di potere e di conoscenza che un altro lettore d’eccezione come Praz definiva addirittura iperbolica. Il carattere dominante dei suoi protagonisti viene sempre spinto all’eccesso e all’estremo ed è forse questo il tratto che può aver irretito la sensibilità di Wilcock, essendo l’eccesso e l’estremo aspetti ed elementi deformanti a cui spesso lo scrittore ha fatto ricorso nell’invenzione delle sue stravaganti figure. Se rileggiamo i suoi libri più noti, come Lo stereoscopio dei solitari, La sinagoga degli iconoclasti e Il libro dei mostri, tutti nel catalogo Adelphi, ma anche romanzi meno noti e poco indagati come L’ingegnere, Il tempio etrusco, I due allegri indiani ci troveremmo ad apertura di pagina in quel clima di «caos» – termine che riassume il modello culturale ben raccontato da Wilcock, sebbene attraverso la sua lente anamorfica – in cui ogni personaggio non può fare a meno di dare espressione e forma a eccessi comportamentali ed estremi che potremmo definire fisiognomici, come se l’intera realtà possa ridursi a un immenso, iperbolico Cottolengo di menti ardite dai propositi folli e irrealizzabili, o figure della pazzia e della crudeltà, mostruose nel loro aspetto come nei loro progetti. E difatti, si conosce di Wilcock la traduzione del Riccardo III, che fu messo in scena da Luca Ronconi per lo Stabile di Torino nella stagione 1967/68.
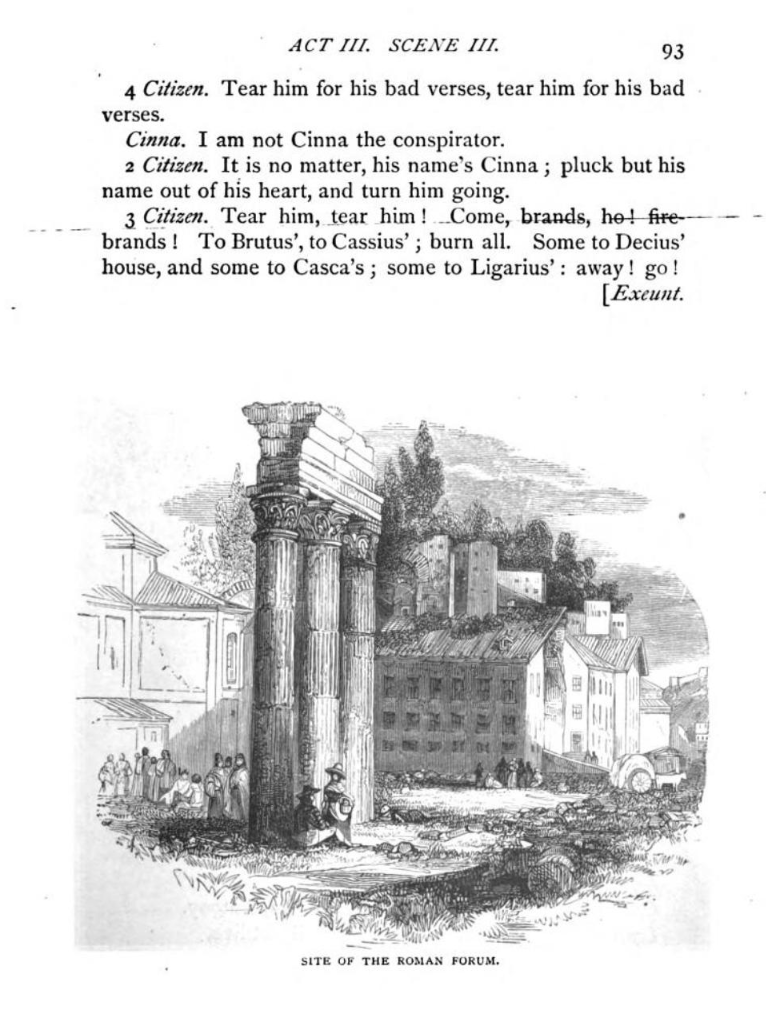
Se questa è una delle possibili strade che conducono Wilcock in direzione di Shakespeare – o meglio, di questo Shakespeare – resterebbe comunque da scoprire se tra le sue carte vi siano ulteriori prove di traduzione da altre opere; mentre il lavoro sul teatro completo di Marlowe è pienamente attestato da una prima, lontana edizione presso Adelphi già nel 1966, il Giulio Cesare di Wilcock è in ogni caso una sorpresa su cui avremmo voluto più informazioni. Quel che sappiamo, invece, è che il teatro del Bardo – ma anche i suoi sonetti – furono da sempre nell’orbita di questo formidabile traduttore. Se i sonetti, con tutto il gioco criptico delle identità, divennero oggetto di una parodia serrata, di una vera e propria reinvenzione, più che di una riscrittura, che comunque lascia intendere una forza attrattiva non comune, palesata qua e là nelle poesie di Wilcock e in particolare nell’Italienische Liederbuch, le pièce shakespeariane catturarono invece il critico, o più semplicemente un lettore empatico.
Possiamo in effetti tentare un’altra strada, avulsa dallo psicologismo, anche quando questo va a tradursi in una efferata morfologia delle passioni. Di cosa sono fatti i personaggi di Shakespeare se non di parole? Ciò che li tiene in vita e – al contrario di quelli di Wilcock – li rende credibili è anzitutto l’inesausta energia verbale, la corrente discorsiva che agitano e che nello stesso tempo li investe. Esseri linguistici, enti che si manifestano a noi in virtù delle parole che qualcuno ha scelto per loro, essi sono, a tutti gli effetti, dramatis personae. Vivono nello spazio del testo: sono parole in sequenza, ritmo che va a caricarsi di significato per restituirci, a ogni lettura, a ogni messa in scena, la forma di un’emozione. Anche quella di un’epoca, evidentemente. È a quella forma viva che Wilcock guardava, ma la sua attrazione per il teatro elisabettiano non gli impedì di accostarsi ad autori problematici, come Beckett, Brecht, Ionesco o Genet. Per molti aspetti, siamo indotti a considerare il suo stesso teatro come la più alta esperienza in lingua italiana dell’assurdo, di quell’assurdo che già nutre molti dei suoi personaggi narrativi. Ma è questo, in fondo, il grande segreto di Wilcock: l’aver percorso più generi e linguaggi in modo tangenziale, finendo così per abolire steccati ben noti ma ormai fragili. Non a caso anche molta della sua scrittura drammaturgica è in versi, rivelando una consapevolezza della plasticità creativa della parola ancor prima che della sua maieutica. Nella fitta retorica di Shakespeare si mostrano così, nella lingua alta, colta eppure viva del traduttore, il movimento della passione, la brama del potere e il tranello del discorso. Come passata al setaccio di Wittgenstein, la parola di Shakespeare ci viene mostrata da Wilcock in tutta la sua efficace nudità.
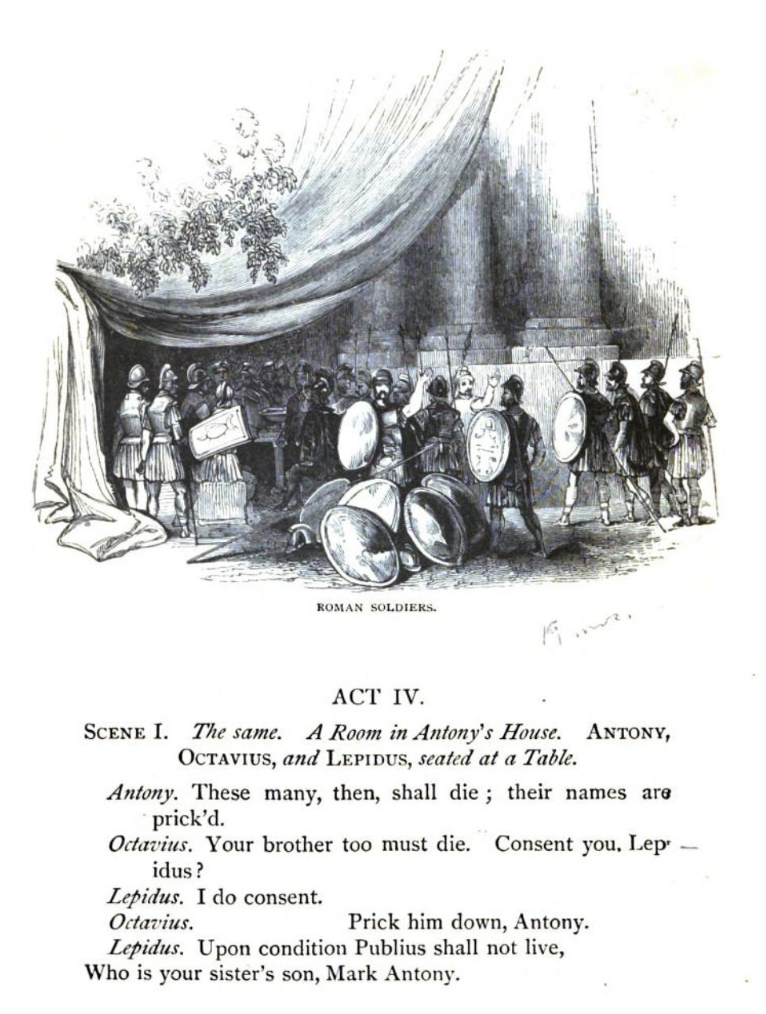
Leggi anche:
Gabriele Gimmelli, Tutti i mostri di Wilcock
Gabriele Gimmelli, Wilcock, iconoclasta solitario







