I racconti di Felisberto Hernández
Fino a pochi anni fa, in Italia, dell’uruguaiano Felisberto Hernández (1902-1964) avevamo letto soltanto la raccolta di racconti Nessuno accendeva le lampade, tradotta per Einaudi nel 1974 da Umberto Bonetti e rapidamente scomparsa dagli scaffali delle librerie. Dopo un lungo periodo in cui l’autore è stato relegato all’angustia delle attenzioni specialistiche degli amanti inveterati delle lettere rioplatensi, Hernández conquista nuovo spazio e (si spera) nuovo pubblico grazie all’editore romano La Nuova Frontiera che, negli ultimi tre anni, ha proposto una nuova edizione di Nessuno accendeva le lampade (2012, stesso titolo ma diversa composizione del volume Einaudi del 1974, in cui apparivano anche racconti che non fanno parte originariamente del libro) e due nuove raccolte di narrative brevi sparse nel tempo, Le Ortensie (2014) e il recentissimo Terre della memoria (2015), tutte per la traduzione di Francesca Lazzarato (d’ora in avanti NAL, O e TM).
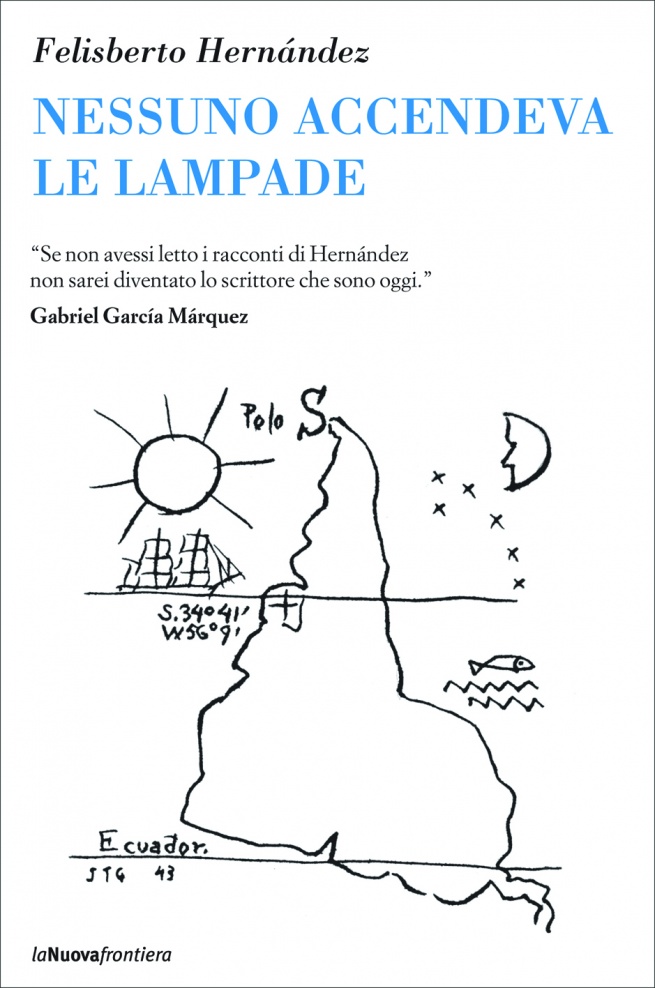
Pianista viaggiatore non troppo facoltoso, costretto spesso a suonare in bettole di provincia, collezionista di matrimoni e uomo a suo modo marginale, Hernández ha avuto una vita priva di soddisfazioni e riconoscimenti (sia musicali che letterari) conclusasi con una morte per leucemia di cui si racconta spesso un aneddoto esemplare: il corpo sessantaduenne del pianista narratore, condannato da vivo all’obesità, una volta rigido e freddo venne calato in strada da una finestra perché troppo ingombrante per passare dalla porta. Questo aneddoto è forse da rubricare nel novero della leggenda prima ancora che in quello del “gossip”: a suffragio di questa conclusione c’è infatti un testo di Ricardo Piglia, Arlt: un cadaver sobre la ciudad, in cui si parla del cadavere di un altro uomo, di un altro scrittore rioplatense, a cui toccò la medesima sorte (in Formas breves, Anagrama 2000). Nel suo essere o meno veridico, l’aneddoto è comunque utile per inquadrare la fase finale di una parabola biografico-letteraria che sembra aver fatto della solitudine uno dei principali motori delle proprie narrazioni. Quando si legge di Hernández, infatti, ci s’imbatte spesso in una pletora di corrispondenze che mettono in relazione la carta e la vita, come se i racconti dell’autore uruguaiano non fossero altro che capitoli di un malinconico (e tuttavia garbatamente ironico) diario disseminato nel tempo, autobiografia dell’isolamento immensa e mascherata, il cui tono evidentemente allegorico nasconderebbe in filigrana la disposizione soggettiva dell’autore nel suo vivere il mondo.
Che i personaggi di Hernández siano talvolta proiezioni dell’autore è una conclusione abbastanza condivisa, suffragata dalla semplice e forse banale osservazione che spesso è un pianista sfortunato a ricoprire il ruolo di protagonista e narratore. Altrettanto condiviso è il fatto che il mondo liminale che tali personaggi vivono, così come l’autore che li ha mossi e creati, è un territorio straniante e opaco, saturo di quelli che con Borges si potrebbero chiamare «tenui ed eterni interstizi di assurdo» (Metamorfosi della tartaruga, in Altre inquisizioni, trad. it. di Francesco Tentori Montaldo, Feltrinelli 1982, p. 114). Questo mondo, preso com’è senza riserve da chi lo vive e lo racconta, nelle pagine in cui si anima non viene mai spiegato al lettore, proprio perché sono i protagonisti stessi a non problematizzarlo, a viverlo tale com’è: sovente amaro sullo sfondo e descritto tramite un’umbratile e indecifrabile topografia i cui parametri fuggevoli condividono il metodo del sogno, nell’indecisione tra il rappresentare le regioni del realismo oppure quelle del fantastico, posto con le dovute riserve che si debba fare alternativamente l’una o l’altra cosa (come d’altronde sottolinea Jaime Alazraki in Felisberto Hernández o i sogni come territorio del fantastico, in Storia della civiltà letteraria ispanoamericana, Utet 2000, vol. II, pp. 574-575).
È in questo grande quadro che la metafora, strategia retorica per eccellenza nella panoplia letteraria di Hernández, si cristallizza in personificazioni di cose o viceversa in reificazioni di persone, in un gioco di confusione vettoriale che mescola il tramite autoriale di circostanze coerenti eppure instabili distribuendolo senza preferenze tra persone-burattino, corpi ribelli e indipendenti dalle menti che dovrebbero muoverli, oggetti vivi e manufatti equipaggiati d’anima. Chiunque, nel mondo di Hernández, convive con i propri simili e dissimili immerso in un universo tiepido di smisurata solitudine in cui sembra che valgano le regole di una parodia della gettatezza heideggeriana portata docilmente all’esasperazione. Questa solitudine, a sua volta, diventa cifra di genere: non quello letterario del fantastico, bensì quello biologico dell’essere umano.

In tal senso, le narrazioni di Hernández possono essere lette come remote soggettive nascoste in cui l’io (quello minuscolo) procede tastoni nell’oscurità, cercando con la mediazione sensoriale i contorni dell’ambiente e un codice grazie al quale dare una misura leggibile alle cose, come accade per esempio in Tranne Julia (NAL), racconto tattile in cui il protagonista è chiamato a riconoscere oggetti e persone in un tunnel atro del quale noi lettori sappiamo soltanto che esiste e che è sede di un gioco forse un po’ infantile; oppure come avviene in La sala da pranzo buia (NAL), in cui un pianista squattrinato viene chiamato a suonare una volta alla settimana nella casa in densa penombra dove vivono Muñeca (bambola, in spagnolo), una donna piuttosto bizzarra incline all’alcol e all’evasività, e Dolly (ancora bambola, ma stavolta in inglese), la sua governante. Lo stesso si può dire del racconto “Le Ortensie” (O), in cui un collezionista piuttosto stravagante si fa costruire da un artigiano specializzato delle bambole dalla statura umana (o meglio, leggermente più grandi), vascolarizzate grazie a un sistema circolatorio che trasporta acqua calda, con cui mettere in scena vere e proprie rappresentazioni teatrali in casa propria, fino a provocare la violenta gelosia della moglie Hortensia, omonima della prediletta tra le bambole.
L’oscurità (intesa non solo nella concretezza dell’orizzonte paesaggistico) è l’ecosistema in cui si muovono i personaggi di Hernández, spesso abitatori isolati di riposti ambienti domestici che sono prigioni elette a dimora via negationis: perché molto probabilmente altrove non si può stare. Ed è proprio questo tema portante a mettere in connessione gli ambienti del movimento con quelli della riflessione e della percezione, come per esempio avviene anche in Ai tempi di Clemente Calling (TM), Nessuno accendeva le lampade (NAC) e Il balcone (NAC).
Ciò che di straordinario accade nella narrativa di Hernández riguarda infatti proprio il modo in cui i suoi personaggi, e in prima battuta il narratore, vivono il mondo a partire dai primi livelli spaziali che li ospitano e che interagiscono per conflitti: il corpo e la casa, serragli concorrenti eppure a modo loro ospitali, forse semplicemente perché necessari.
Il tramite fatto di carne e nervi che dialoga con l’ambiente fisico per codificarlo risulta in Hernández inadeguato, spesso dissidente, senza che tuttavia tale ribellione corporale porti allo scoramento, all’interrogazione perturbante di chi lo abita. Sovente, infatti, nel gioco di indipendente ed ecumenica animazione cui partecipano esseri e oggetti, capita che il corpo guadagni primazia su chi lo muove, o dovrebbe muoverlo, e da ospite diventa totalità. Il corpo, nelle narrazioni di Hernández, è un attore principale, riottoso nei confronti del padrone (come d’altronde capita nei sogni) e frammentato nell’indipendenza delle sue varie parti: ne Il coccodrillo (O), per esempio, si legge di un pianista che decide di piangere per muovere interesse e compassione in committenti e ascoltatori, essendo poi incapace di dare termine alle lacrime proditorie che continuano incessantemente a scorrergli dagli occhi.
Ecco, per concludere, cosa scrive Hernández del corpo, per bocca del protagonista di Terre della memoria: «Non ho mai avuto confidenza con il mio corpo; e neppure l’ho mai conosciuto bene. Mantenevo con lui una relazione fatta di chiaroscuri. […] Quelli della mia famiglia lo conoscevano meglio. In casa lo avevano allevato come un animaletto, gli erano affezionati e lo trattavano con premura. E quando mi mettevo in viaggio mi raccomandavano di averne cura. […] Lontano da casa il mio corpo poteva gettarsi in un abisso e io con lui: l’ho sempre sentito vivere al di sotto dei miei pensieri. […] Credo che in tutto il corpo abitino dei pensieri, anche se non tutti arrivano fino alla testa e si vestono di parole. So che per il corpo vagano pensieri scalzi. Quando gli occhi sembrano assenti perché lo sguardo è sperduto e l’intelligenza si è ritirata per qualche istante e li ha lasciati vuoti, e mentre i pensieri della testa deliberano a porte chiuse, i pensieri scalzi salgono lungo il copro e si installano negli occhi. Da lì cercano un oggetto su cui fissare lo sguardo e sembrano serpenti che ipnotizzano gli uccelli. Ipnotizzano anche i pensieri che sono in riunione e che devono interrompere le loro deliberazioni» (TM, pp. 134-135).
Attraverso l’allegoria e il sogno, dunque, la metafora sussiste in Hernández attraversando la carne in più direzioni e dando contemporaneamente vita a una sorta di realtà indipendente la cui sovranità spetta soltanto alla narrazione, e solo successivamente al lettore, qualora questi voglia adeguarsi senza condizioni a tale mondo. Cosa che, in tutta franchezza, si consiglia vivamente.







