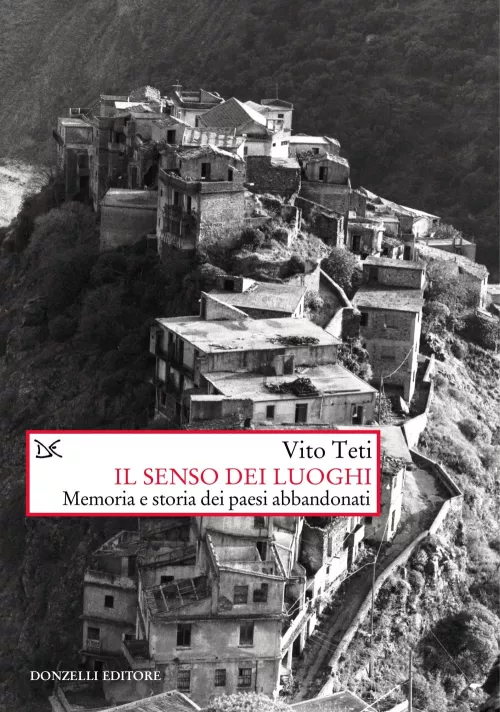Il senso dei luoghi abbandonati
Rileggendo quel libro straordinario che è Il senso dei luoghi. Memoria e storia dei paesi abbandonati di Vito Teti (di cui esce ora dopo quasi vent’anni una nuova edizione sempre da Donzelli) ho pensato a quanto potente sia la lezione dell’antropologia meridionalista, e in particolare la sua, per contrastare quella diffusa violenta sensazione di “crisi dell’esperienza dei luoghi” di cui parla il sociologo, non a caso americano, Richard Sennet e con la quale per altro conviviamo credo in molti. Perché, è vero, i luoghi non muoiono, anche quando sono abbandonati, se si rivolge loro uno sguardo nuovo, che rifiuti la tradizionale gerarchia, ricalcata sul modello urbano (come fa notare Carmine Donzelli nell’introduzione) orientato non dal centro ma dai margini stessi.
Borghi dimenticati, vuoti, in Calabria ma non solo. È lo stesso Teti a scavare dietro quel preliminare “sentimento di un’assenza che si dilata tra le cose” nei luoghi di abbandono per avventurarsi poi dentro il silenzio “se possibile a placarlo” cercando persone e storie, trovandosi immerso in un sistema di segni solo in parte prevedibile: così l’assenza, il vuoto, si rivelano pieni di tracce, di indicazioni, di voci, di memorie, scritte in un alfabeto strano di cui ogni giorno, a ogni passo, a ogni incontro, si impara a cogliere il senso. Perché le cose in rovina – ci spiega – perturbanti nel senso freudiano del termine, familiari e sconosciute, diventano tali nel momento in cui viene coinvolta la nostra affettività così da interrogare (il passaggio è cruciale) noi stessi. Come racconta l’autore in occasione di una lontana visita negli anni Ottanta all’antichissima città siciliana di Noto:
“Eravamo seduti sui gradini del Duomo – confida – quando qualcuno ci parlò della Noto antica, centro siculo poi ellenizzato, che ebbe una vita prospera in età romana e ancora nel medioevo, interamente distrutto dal terremoto del 1693. Da lì giunsero le persone che fondarono poi la splendida città, anch’essa in parte in rovina e in abbandono per lungo tempo, che tutti conosciamo. Ricordo i resti, bassi, minuti, fatta eccezione per quelli del castello, della porta reale, di un gymnasium del III secolo a.C., nascosti e confusi nella vegetazione. All’imbrunire la luce fioca era delicata e dolce, di quelle che rapiscono. Rimasi affascinato, incantato, quasi turbato”.
E poi la rivelazione, l’incontro con il sé che si genera in quei luoghi antichi:
“Avvertivo delle strane «presenze» aggirarsi tra quei ruderi. Piano piano ebbi come la sensazione di una sorta di svelamento, di un invito a prendere consapevolezza di quello che stavo già facendo da tempo. Non stavo forse fissando, già da tanti anni, volti e storie di persone che avevano vissuto la fine di un mondo? Non stavo ascoltando racconti di fame e di miseria appena passate, mentre intorno c’era l’aria di un mondo nuovo, che non aveva contorni precisi e che a volte si dissolveva prima di nascere o restava incompiuto quasi come le tante case non finite, i pilastri grigi, le rovine moderne che segnano il territorio?”
Vivere la fine del proprio mondo che le rovine, certo, i muri diroccati mostrano con maggiore veemenza, può avvenire comunque, se ci si interroga dal profondo, intuisce Vito Teti alludendo alle rovine moderne, agli incompiuti che segnano, e non solo, il territorio calabrese. Io ad esempio l’ho vissuta con la fine delle città fordiste one company town l’Ivrea di Olivetti e la Torino della Fiat, con gli stabilimenti diventati inerti o le fabbriche dismesse in macerie. Dove le macerie del 900, a differenza delle rovine, sono materie mute, non “racconti ancora in piedi”, ci insegna Marc Augé. E dove non a caso l’abbandono più radicale per uno strano paradosso, osserva Teti, produce anche nuove forme di vita: quelli che restano. È vero infatti che ogni restanza si configura sempre, implicitamente, come il nucleo fondativo di progetti, aspirazioni, sogni. Questo è restare: “è muoversi, è camminare sulle strade di casa e, contemporaneamente, viaggiare nel proprio mondo interiore, nella propria storia individuale, familiare e della comunità d’origine”.
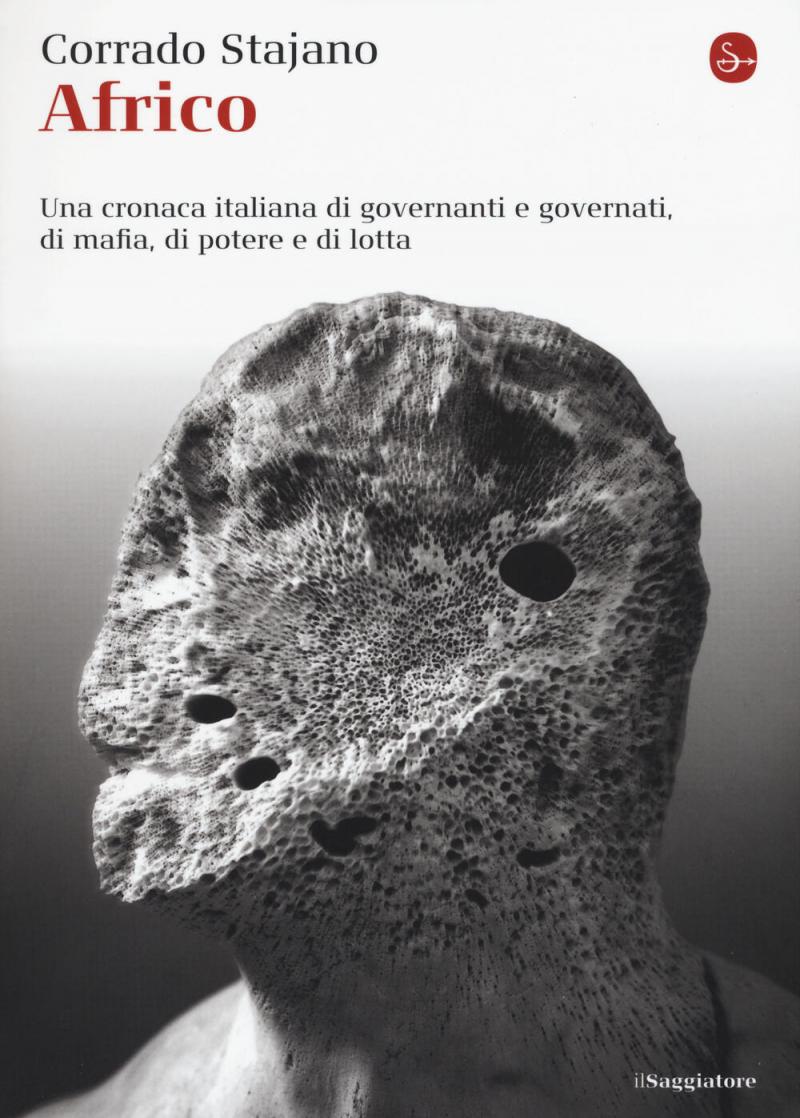
Restare si può in tanti modi anche con le processioni e i riti che commemorano il santo patrono di un luogo abbandonato. Come ad Africo, in uno dei capitoli-racconto a mio parere più coinvolgenti del libro Il senso dei luoghi che spazia tra Pentedattilo, come vedremo, e Nicastrello, Roghudi, Brancaleone e Badolato, fino Cerenza e Laino. Africo – che deriva dal greco apricos o dal latino apricus – dovrebbe indicare un luogo aprico, aperto, luminoso, esposto al sole, al contrario del paese che si raggiunge molto faticosamente oggi, situato a quasi 700 metri di altezza, sul pendio di una collina dell’Aspromonte orientale. Privo di strade di collegamento – per giungere a piedi a Bova si impiegavano circa sei ore, e più lunga e difficile era la strada che conduceva a Brancaleone – è circondato, come ricorda il meridionalista Zanotti Bianco, da “valli simili a enormi cavalloni di un oceano” che “si seguono fino all’orizzonte”. Anche l’etimologia dei luoghi si inasprisce giungendo sulle acque del torrente Apòscipo – da aposkepos, luogo celato, non protetto – che si getta nella fiumara La Verde.
Alle spalle montagne brulle e i dirupi. Un paese sospeso, out of joint (fuori dai cardini, come lo definì ancora Zanotti Bianco). Fuori, ai margini dei margini, separato, lontano da ogni asse stradale, lo è davvero Africo, con la sua fama di paese maledetto dalla miseria e di antica patria del drittismo e della ‘ndrangheta (raccontato dal libro, un classico ormai, Africo. Una cronaca italiana, di Corrado Stajano). E che fu abbandonato in seguito a una violentissima alluvione nell’ottobre del 1951. Certo a questa esperienza di «fine del mondo» bisogna riferirsi, osserva Vito Teti, se si vogliono comprendere meglio le dispersioni, le frantumazioni, i contrasti, le insicurezze, le indecisioni della gente negli anni e nei decenni successivi. Solo dopo anni si insediarono infatti nella marina dentro i confini del Comune di Bianco.
È però con il pellegrinaggio in onore di San Leo che la popolazione rinsalda ogni anno, a maggio, il legame forte di Africo nuovo col paese vecchio. Alla processione partecipano – racconta Teti – sacerdoti, gruppi organizzati di fedeli e contadini che lungo la via si uniscono al corteo. Le persone giungono da Africo nuovo, ma anche da numerosi centri della provincia di Reggio in cui si sono trasferiti, da Reggio, da Vercelli, dai luoghi dell’emigrazione. In Chiesa le donne cantano la raziuni di San Leo e pregano. “Molti, tornati da lontano, si salutano con grande calore – quasi si ricostituisse anche se per qualche ora la comunità di paese – Fuori attendono, sotto gli alberi, uomini, giovani e bambini. Molti parlano degli antichi tempi, riportano ricordi e racconti ascoltati altrove”.
La ricordo anch’io quella processione, era il 2011 al seguito di Vito Teti e degli amici dell’Università della Calabria. Lo scenario umano è in parte inatteso, perché moltissimi dei partecipanti alla processione sono giovani. Sentiamo le voci fresche dei canti di devozione, squillanti, vivaci, le parole per me incomprensibili, in dialetto. Tante donne, ragazze. Ho ancora in mente i volti radiosi, compresi, delle ragazzine nel canto che non esitano tuttavia ad esibire, quasi un cortocircuito spazio-temporale, i gadget Hello Kitty di qualsiasi adolescente metropolitana.
Ancora una processione riunisce periodicamente il paese abbandonato di Pentedattilo, frazione di Melito Porto Salvo, con il Comune di appartenenza sulla costa. Pentedattilo è sormontato da una montagna in forma di mano (di qui il nome in greco “cinque dita”). Una mano di pietra sovraccarica di intenzioni quella che incombe sul paese e che, nell’immaginario popolare, è calata sui suoi abitanti in una drammatica Pasqua del 1686, sterminando per opera del barone di Montebello, la famiglia intera dei marchesi di Pentedattilo, gli Alberti. La scintilla che avrebbe provocato l’eccidio – racconta Teti – l’amore di Bernardino Abenavoli, barone del contiguo Montebello per Antonia Alberti osteggiato dal fratello di lei Lorenzo.
Un gesto estremo che pesò sulla storia del paese come una maledizione, incrociandosi con le vicende assai complesse dell’Italia spagnola tra cinque e seicento. A scongiurare castighi (e pestilenze) gli abitanti di Pentedattilo istituirono nei tempi antichi una processione per trasferire il quadro/reliquia della Madonna che fu abbandonato dai pericolosi (allora) Turchi da Pentedattilo (dove viene custodito per un mese all’anno) a Melito Porto Salvo. Nell’intenso racconto di Vito Teti, testimone d’eccezione, i portantini, con un foulard chiaro legato al collo, “ballano la vara”, rivolta in direzione della vecchia Pentedattilo, tra una grande folla rumorosa e pressante. L’immagine del paese antico, ora inerte, viene riflessa sul vetro che protegge il dipinto di Maria. Il paese “catturato” balla, si alza, si abbassa con la vara. È come se i portantini, aggiunge, volessero portare con sé, dentro di sé, il paese ora perduto. Contese fra paesi o forse si tratta, ancor più, di conflitti interni alla memoria e di periodiche riconciliazioni.
Ogni luogo – ci insegna l’autore in conclusione di questo viaggio tra le profondità della Calabria – non è solo articolazione spaziale ma anche dimensione della mente, organizzazione simbolica di tempo, memoria e oblio: luogo “antropologico” in senso lato in quanto abitato, umanizzato, riconosciuto, periodicamente rifondato, dalle persone che se ne sentono parte. E che nell’essere comunque parte di una storia che ha a che fare con noi stessi ci interroga ancora tutti, restanti, ritornanti, partiti.