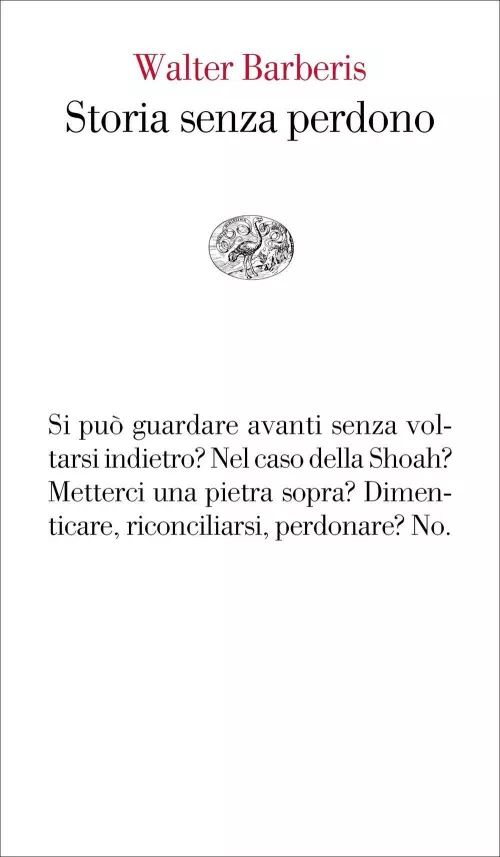Testimonianze / Il superstite, lo storico, il giudice
La posizione del testimone, soprattutto dell’“ultimo”, cioè del reduce dallo sterminio o dalle gravissime vessazioni subite che sta consumando ora l’ultima parte della vita, è una questione ultimamente molto dibattuta. Walter Barberis, nel suo recente Storia senza perdono (Einaudi, Torino, 2019) di cui ha già parlato su doppiozero David Bidussa, tra i molti temi affrontati ha approfondito la ‘qualità’ della memoria di quella persona rispetto alle spaventose nefandezze subite e la cedevolezza dei ricordi di fronte alle esigenze della ricostruzione storica. Non a caso l’autore esordisce citando la consapevole considerazione di Primo Levi secondo cui la ‘memoria è uno strumento meraviglioso ma fallace”.
Quel particolare testimone suscita un altro motivo di interesse: la sua posizione quale attore in un processo penale, chiamato a ricostruire il passato che lo ha travolto contribuendo con la macchina processuale però a sancire eventuali responsabilità altrui. Egli in questa occasione trova un interlocutore diverso dallo storico: si imbatte nel giudice.
Con quali conseguenze? Innanzitutto giudice e storico sono soggetti che svolgono, banalmente ma non troppo, attività differenti e con divergenze profonde. Alcune riguardano il metodo, le sue regole e i suoi limiti. Lo strumento penale è rigido, costellato da barriere imposte dalle parti sui temi da esaminare e dai codici sul come trattare le prove. Lo strumento storico è invece fluido, non preoccupato di superare confini. Altre divergenze incidono sulla freccia del tempo: mentre per lo storico la revisione delle acquisizioni ottenute è sempre possibile, per il giurista esiste la barriera invalicabile del giudicato, cioè della decisione definitiva che ha scavalcato i vari gradi di giudizio. Altre divergenze toccano l’obiettivo: mentre quello del giurista è l’accertamento delle responsabilità individuali, quello dello storico è la riflessione sui fenomeni. Infine la divergenza sul prodotto finale delle indagini: la verità processuale diverge dalla quella storica per le modalità diverse di accertamento, come di recente ancora è stato ribadito da Paolo Borgna, in “Verità storica e verità processuale”.
Esistono nel contempo alcuni intrecci anomali, come nei processi per negazionismo dove il giudice diventa ‘certificatore delle verità”, cioè sanziona se il fenomeno retrostante alla negazione è esistito o meno. Il problema è aperto ed irrisolto, tanto da giungere ad introdurre lo storico nelle aule giudiziarie quale perito perché ricostruisca le fasi storiche in cui i delitti sono maturati. Per converso talora, e non di rado, anche il lavoro dello storico si amalgama con quello del giudice nell’utilizzare le fonti giudiziarie come spaccato rievocativo. E viceversa il giudice impegnato in delitti maturati in un determinato periodo, a volte ne ricostruisce anche la storia come scrittore e docente. Esistono peraltro convergenze. Entrambe le discipline si basano su fatti preesistenti e irripetibili, li ricompongono con impegno imparziale usando per questo scopo due strumenti, il documento e la testimonianza.
E sulla testimonianza ci si intende soffermare. Essa si impone con un ruolo ‘ teoretico’, fondante perché costruisce nuove conoscenze, nasce come “percezione” e si trasforma in “narrazione”, momenti non sovrapponibili perché il dato risolutivo è quanto emerge dalla narrazione, e cioè cosa il testimone dice e come lo dice. Trattandosi di prodotto umano, essa risente di plurimi fattori quali la sofferenza, lo stress, il trauma, e tanto più sono accentuati tanto maggiore deve essere la cautela, come osservava già nel 1930 Cesare Musatti. Ed ancora gioca un ruolo condizionante l’influenza del processo e delle sue regole, l’interferenza del pubblico e dei mass-media in quella come in altre sedi, la ricerca di empatia e di sostegno da parte dell’uditorio, in generale la suggestionabilità.
I problemi di duttibilità soggettiva si alimentano con la fragilità della memoria, ondeggiante tra rimozione, confusione involontaria, convinzione della giustezza del proprio dire cioè putatività. Esistono poi i falsi ricordi, talora indotti da traumi ma talaltra truffaldini, approfonditi anche sul versante degli stermini come quelli in Bosnia. In sostanza ogni memoria è parziale, individuale e soggettiva. Per questo Barberis si fida poco della testimonianza in generale. Ed ha ragione, concordando con chi se ne serve con attenta cautela.
Altro profilo è la grammatica valutativa, cioè quando e come credere al testimone. Per il giudice esistono accettate regole quali la coerenza, la costanza, l’immediatezza, la soggettività intrinseca, la verosimiglianza, l’assenza d’interesse di parte. E nel rapporto con il tempo essa può essere fredda cioè dilazionata, o calda cioè immediata, quest’ultima più accreditabile perché non corrosa. Ad esempio, secondo la nostra procedura la parola non basta, ma deve essere corroborata da altri elementi. Solo in casi particolari essa è sufficiente, ma non senza aver subito un vaglio severo, talora attraverso il filtro di psicologi e senza pubblico, come nelle vicende di abusi sessuali e minorili.
Ma come si comporta il tribunale con i testimoni vittime sopravvissute di sterminio, dei crimini di guerra, di eccidi quando si presentano a deporre in aula? Quei soggetti sono uguali ad ogni altro testimone in un qualsiasi altro processo in qualsiasi momento storico e per qualsiasi reato? I criteri per valutare le loro parole sono identici per tutti? Se la testimonianza come modalità rievocativa è già di per sé strutturalmente fragile come conferma correttamente Barberis, come è considerata quella di un testimone così particolare quale il sopravvissuto alla Shoa nelle aule del tribunale?
In realtà si assiste ad un ribaltamento di prospettiva. La premessa è che i processi sull’Olocausto hanno avuto una loro peculiarità per l’unicità della materia trattata. Sono stati ‘speciali’ nel senso di ‘extraordinem’, cioè al di fuori delle regole tradizionali. E sono stati “politici” a causa dell’urgenza nel dopoguerra di costruire una memoria pubblica su quanto accaduto (Pier Paolo Portinaro, I conti con il passato, Feltrinelli, 2011; Danilo Zolo, La giustizia dei vincitori, Laterza, 2012).
In quella fase del dopoguerra la giustizia e la politica diventarono comunicanti. “La questione se la punizione dei crimini di guerra commessi dal nemico sia vantaggiosa e praticabile è un problema della politica, non del diritto”, osservò Hersch Lauterpacht, l’elaboratore delle nozioni di ‘genocidio e crimini contro l’umanità’ in vista del processo di Norimberga. Di qui l’inestirpabile contraddizione del processo come quello di Norimberga, in quanto secondo molti fondare il diritto internazionale su una forma di giustizia politica ne avrebbe viziato il processo di legittimazione. E così, con effetti ancora permanenti pur in altri momenti storici, la contaminazione tra giustizia e politica si afferma come inevitabile. Il tentativo di regolare i conflitti si traduce molto spesso nella giuridicizzazione della politica, il cui rovescio, anch’ esso oggi percepito, è un processo di politicizzazione della giustizia. Quei processi sono ‘speciali’ anche sotto un altro profilo: esisteva la necessità di rifarsi alle leggi dell’umanità, ad esigenze morali che superassero rigidi formalismi come sottolineò senza esitazioni il giurista Piero Calamandrei (Le leggi di Antigone, Sansoni 2004). Quei crimini, in altri termini, si collocano in una sfera diversa e altra rispetto a quella giuridica.

Lo scarto con le testimonianze nei processi ordinari è netto. Come possono essere neutrali e disinteressate le testimonianze di fronte a quelle esperienze abissali e squassanti? Come argomenta Nicla Vassallo, non si può applicare ai sopravvissuti l’epistemologia tradizionale della testimonianza, e cioè il canone dell’attendibilità fondato su attenzione, coerenza, competenza, lucidità, posatezza del dire. Il sopravvissuto che testimonia l’orrore del lager si rivolge al cuore e non alla ragione, si espone nudo al giudizio altrui, paga un debito verso i sommersi, stipula un patto di ‘ compassione’ in chi l’ascolta, chiede di convertire il racconto sul passato in prove processuali che lo renda costruttore di memoria accettata. La conseguenza è che i testimoni sopravvissuti seguono un rituale ‘extraordinem’, con una narrazione ‘indicibile’ perché indicibile è quanto sono chiamati a descrivere, perché è assurdo farli giurare perché dicano il vero in quanto la verità trascende il loro dire e si legge nella loro persona. E quindi è limitante utilizzare i ritmi del codice penale per gli orrori dell’Olocausto (Karl Jaspers, La questione della colpa, Raffaello Cortina, 1966) in quanto i testimoni escono dal ruolo di attori della giustizia dal momento che la giustizia diviene ausiliaria della memoria.
Con queste affermazioni si introduce un paradigma specifico e stravolgente per questi soggetti. Il sopravvissuto diviene “supertest”, il superstite che ‘ sussiste al di là’ di un evento che lo ha annientato e che racconta, similmente al ‘ testimone morale’ di cui parla Avishai Margalit nel suo L’etica della memoria (Il mulino, 2006). Il “testis” è invece chi è presente e vede, chi assiste come terzo a una questione a lui esterna, tra altri soggetti. In questa cornice si colloca la reazione scandalizzata di fronte alla conclusione del processo svoltosi ad Amburgo nel 1972 a carico del nazista Becker, imputato di circa 300 morti nel ghetto di Wierzbnick. La procedura terminò con l’assoluzione dell’imputato principalmente, anche se non esclusivamente, perché ‘i testi oculari erano non affidabili… perché passati 29 anni… perché non indifferenti… perché discordanti tra loro’ (Christopher Browning, Lo storico e il testimone, Laterza, 2011). Nella sostanza quel tribunale, forse non limpido in alcuni componenti, usò le categorie tradizionali per saggiare la credibilità dei testimoni, mentre l’orientamento corale convergeva per l’impossibile loro utilizzo in questi eventi.
Ecco il rovesciamento: la debolezza indiscutibile e congenita della testimonianza, supportata dalla fragilità della memoria, diviene invece forza rievocativa ‘extraordinem’ quando il sopravvissuto si presenta come testimone in tribunale.
E ancora: salta un altro paradigma classico del giusto processo che lo vuole indenne e protetto da rimbombi esterni. Quei processi del dopoguerra sono gigantesche rappresentazioni pubbliche delegate a fondare un nuovo ordine politico dopo un conflitto di immani proporzioni. Si esalta il valore simbolico dei dibattimenti penali perché hanno facilitato la costruzione storica di una verità attraverso la “memoria delle vittime”. Il processo assume le forme di uno strumento di riconciliazione e pacificazione, la ‘spettacolarizzazione della tragedia’ sedimenta nell’opinione pubblica la memoria di quanto avvenuto. Il diritto, in questi processi, è al servizio della vittima, le categorie giuridiche sono subordinate al ‘dovere di memoria’. Di qui il lamentato rischio di sospendere i principi processuali consolidati, quali ad esempio il principio del giudice naturale, il contraddittorio sulle prove assunte in dibattimento, la presunzione di non colpevolezza,
Sono stati celebrati altri processi nella peculiare fase di trapasso del secondo dopoguerra chiamata “Giustizia di Transizione”, con però diverse imputazioni e diverse esigenze. Talora ancora per crimini di guerra (ad esempio il processo militare del 2007 per l’eccidio di Sant’Anna di Strazzema o quello francese a Barbie nel 1987), talora per reati comuni pur gravi (processi militari a Kappler nel 1948-1952, a Priekpe nel 1995), talaltra per i crimini commessi ad Auschwitz (processi a Francoforte attivati da Fritz Bauer nel 1965, regolato per la prima volta dalla legge tedesca mentre il precedente, forse il primo inerente al lager, tenutosi a Cracovia nel 1947 fu regolato dalle norme applicate a Norimberga). Ma in queste procedure lo strappo legale è stato meno forte, pur sempre sorretto dall’uso politico della giustizia.
Superata la fase traumatica se ne è aperta un’altra, ancora centrata su crimini di guerra, genocidi, delitti contro l’umanità nello sforzo di tutelare le popolazioni civili offese. Si tratta della costituzione, talora sotto l’egida dell’ONU, del Tribunale Penale per la ex Jugoslavia nel 1993, della Corte Penale Internazionale dell’Aja nel 1998, della Corte Speciale della Sierra Leone nel 2002, della Corte per i crimini avvenuti in Cambogia nel 2006. Il lavoro per queste istituzioni purtroppo non manca, con l’impegno da alterne fortune, i processi sono stati e sono lunghi e tormentati, arrestano, sentono testimoni, condannano gli imputati. Nei loro statuti fondativi però non compaiono trattamenti specifici per i testimoni che sono stati vittime di quelle barbarie, ed anche per essi valgono le regole tradizionali del processo. Quei testimoni, con il corredo di regole e criteri interpretativi codificati, rientrano nella dimensione ordinaria. Ritorna il diritto con i suoi rituali e paradigmi accettati dalla storia, ricalibrato sui gravissimi reati ma sempre ordinario nel giudicare sofferenze. Sofferenze anche queste. Per tutti coloro che le hanno subite.
Per saperne di più
Sulla presenza dello storico nelle aule giudiziarie si veda G. Resta e V. Zeno Zencovich, “La storia ‘giuridificata”’, in Riparare risarcire ricordare Editoriale Scientifica, 2012. Sul passaggio da percezione a narrazione nella testimonianza, è importante Paul Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio, Raffaello Cortina, 2003. Il libro di Cesare Musatti Elementi di psicologia della testimonianza, e stato riproposto da Liviana editrice nel 1989. Per i falsi ricordi nelle vicende della Bosnia, si veda Elizabeth Loftus, The myth of repressed memory del 1996 rievocata da Piergiorgio Strata, “Le false memorie”, in Diritto penale e uomo, 2019. La citazione di Hersch Lauterpacht è riportata da Fabrizio Marrella, Diritto Internazionale, Giuffrè 2016. L’attribuzione dei crimini di guerra e degni etnocidi a una sfera extragiuridica è affrontat, tra i molti, da Maria Grazia Carnevale, Testimoniare. La vita e le forme della memoria, ISLL Papers, 2015, 199, e Ernesto De Cristofaro, Gradi di memoria, I giuristi italiani e i processi ai criminali nazisti, Laboratoire italien, 2011,1. Di Nicla Vassallo si veda “Applicazioni dell’epistemologia della testimonianza al caso dell’Olocausto”, Rivista di estetica, 45,3, 139. Sul “testis” si veda Émile Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, Einaudi, 1976. Nicoletta Policek, “Vittime di genocidio e i dilemmi delle promesse di giustizia”, Rivista di criminologia e vittimologia, 2012,3,14. Sui processi di Francoforte e di Cracovia sui crimini commessi ad Auschwitz, scrive Nicoletta Policek, “Vittime di genocidio e i dilemmi delle promesse di giustizia”, Rivista di criminologia e vittimologia, 2012,3,14.