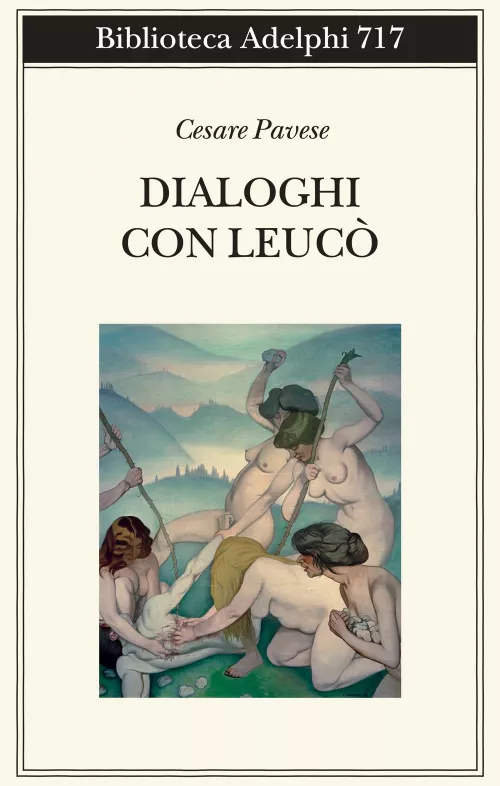La religio mortis di Cesare Pavese
Nel breve articolo del 1964, intitolato Cesare Pavese, il mito e la scienza del mito,[1]Jesi collocò il poeta piemontese con il romanziere Thomas Mann e Károly Kerényi, sotto il vessillo di quella religio mortis nichilista che avrebbe influenzato tutti gli intellettuali post-romantici di scuola tedesca.
In queste teorie mitiche si presupponeva l’esistenza autonoma del “mito che afferra” come alterità demonica radicale all’Uomo; del mito veniva caratterizzata negativamente e paradossalmente la sostanza (“qualcosa e insieme nulla”) rinunciando implicitamente alla possibilità di una storicizzazione; infine si teorizzava, la necessità della subordinazione dialettica a questa alterità negativa. Erano queste le tre fondamenta teoriche che definivano nichilisticamente il pensiero dei tre mitologi al di là delle posizioni e delle auto-esegesi ufficialmente (e genericamente) umaniste. Queste ultime, piuttosto, sarebbero state solo il tentativo estremo di mistificare la fascinazione mitica: una “mascheratura”, appunto, di quei “pensieri segreti” della cultura borghese tedesca ed europea.
Se le osservazioni di Jesi possono essere estremamente utili ad illuminare i “pensieri segreti” della cultura nichilista occidentale e i suoi influssi genetici su tutto l’umanesimo borghese europeo, paiono invece considerazioni forzate nel momento in cui tentano di sistemare personalità complesse, ambigue e contraddittorie come quella di Pavese, schierandole nella teorìa di adepti al culto infero della religio mortis.
Il saggio di Jesi, cercando di dimostrare quanto la teoria mitica di Pavese sia intrinsecamente permeata dal pensiero nichilista tedesco, ne vuole condannare tutta una ideologia sottesa, all’interno della quale il gesto estremo dello scrittore sarebbe stato soltanto una coerente e logica conseguenza.
Certo non si può attraversare questo argomento senza affrontare il nodo spinoso del cosiddetto Taccuino segreto. Una serie di annotazioni pubblicate da Lorenzo Mondo su “La Stampa” l’8 agosto 1990, “distribuite su 29 foglietti di bloc-notes che misurano 12 centimetri per 15, a carta quadrettata”, simili in tutto e per tutto a quelle che andranno a comporre Il mestiere di vivere.Sono riflessioni scritte per lo più a matita, che mostrano il volto inedito di un Pavese che non solo rivaluta, ma a tratti pare quasi consapevolmente affascinato dalla cultura più volgare della destra internazionale. Un volto poi censurato dallo stesso Pavese, che escluse personalmente quei fogli dalle carte del diario privato. Un volto che Jesi non poteva certamente conoscere all’epoca della stesura del suo saggio, ma che sembra confermare esplicitamente quei “pensieri segreti” riconosciuti dallo stesso Pavese nella sua voglia inconscia di mettersi a studiare il tedesco: “Boden und blut– si dice così? Questa gente ha saputo trovare la vera espressione. Perché nel ‘40 ti sei messo a studiare il tedesco? Quella voglia ti pareva solo commerciale, era l’impulso del subcosciente a entrare in una nuova realtà del destino. Amor fati”. Un certo superomismo epico lo porta addirittura a rivalutare fatalmente non solo la figura del Duce, ma anche quella di Hitler e Franco. Lo stesso fatalismo storico viene utilizzato per minimizzare grossolanamente le eventuali atrocità nazista: “che cosa sono di diverso dalle storie sulla rivoluzione franc., che pure ebbe la ragione dalla sua? Se anche fossero vere, la storia non va con i guanti. Forse il difetto di noi italiani è che non sappiamo essere atroci”. Viene anche messo in campo un inaspettato nazionalismo interventista miscelato con l’onnipresente senso di colpa, proiettato questa volta, causa l’asma, sull’incapacità di servire la patria sul campo di battaglia. Se fu pudore o vergogna, paura o consapevole abiura ciò che spinse Pavese a rinnegare questo taccuino non lo sapremo mai con certezza. Se questa adesione ideale fu genuina e meditata, o piuttosto figlia uno sfogo momentaneo: una provocazione nata del desiderio impulsivo di “sgrupparsi” da parte di un intellettuale assolutamente anticonformista che comunque frequentava l’ambiente antifascista torinese – nel quale pure annoverava gli amici più cari – anche questo lo possiamo soltanto supporre. In un’intervista del febbraio 1946 a chi gli chiedeva in che modo la guerra avesse influito sulla vita e l’opera dello scrittore, Pavese risponde: “Come sempre il troppo ordine, la troppa gerarchia, producevano anarchismo, e io lo confesso: nelle cose pubbliche ero anarchico, luciferesco, autosufficiente” (intervista rilasciata presso la RAI per la rubrica “scrittori al microfono”, poi pubblicata con il titolo Ragioni di Pavese, in C. Pavese, La letteratura americana e altri saggi, Torino, Einaudi 1990, pp. 264-266). Dichiarazione che, letta con il senno di poi, assume i connotati di un intimo mea culpa per le considerazioni politiche che, seppur mai esternate in maniera ufficiale, erano venute prendendo forma negli anni della guerra. Da parte nostra possiamo soltanto rilevare nell’incipit di quel pensiero: “Boden und Blut – si dice così?” – l’ironia dell’interrogazione retorica (Pavese, nella stessa nota, affermava di aver deciso di studiare il tedesco da almeno due anni) che, anche se non può attenuare la “responsabilità della citazione”, sembra smantellare l’affidabilità delle affermazioni seguenti, svelandone la strategia provocatoria cui il lettore abituale del diario di Pavese è uso; tecnica attraverso la quale l’immagine dell’oggetto tabùviene rivendicata perché tecnicamente in grado di scatenare, nella rappresentazione dell’Io, una puntuale strategia della colpa e del rimorso. Inoltre siamo convinti che seguire la traccia extravagante del pensiero dell’uomo può essere interessante e necessario, quanto futile, se si perde di vista l’opera del poeta; e libri come Il compagno, Prima che il gallo canti, La luna e i falò, in tutta la loro complessità storica, politica ed esistenziale, sono la testimonianza che Pavese ha voluto consegnare alla memoria e alla storia della letteratura.
Le prime pagine del saggio Cesare Pavese, il mito e la scienza del mito vengono spese da Furio Jesi per dimostrare la discendenza diretta della scuola etnologica tedesca dalle speculazioni simboliche che dai primi romantici tedeschi avevano condotto (attraverso Creuzer, Klages e l’esoterismo di George) a Rainer Maria Rilke e Leo Frobenius (quest’ultimo vero e proprio anello di congiunzione tra la disciplina estetica tedesca e la scuola etnologica mitteleuropea). Pavese si sarebbe imbattuto e riconosciuto in questa tradizione proprio attraverso l’opera etnologica di autori come Frobenius, gli studi mitologici di Károly Kerényi, quelli psicanalitici di Carl Jung e i romanzi di Thomas Mann senza riuscire a decifrare esaurientemente le connotazioni ideologiche e le pesanti ascendenze culturali.
L’incontro con gli etnologi tedeschi, certo, fu determinante. Ma se quell’incontro fu fruttuoso lo si deve alla storia ben più complessa della formazione culturale di Pavese, che quell’incontro precede e determina. Storia che Furio Jesi censura completamente perché sfumerebbe la figura appena abbozzata di un Cesare Pavese seguace inconsapevole e nemmeno troppo originale di quella corrente culturale sotterranea, esoterica e irrazionale, definita con i versi di Stefan George, “das geheimes Deutschland”, “la Germania Segreta”.
Sappiamo che una certa concezione “demonica” del reale era già consapevolmente presente nella riflessione di Pavese fin dall’inizio degli anni Quaranta. La frequentazione dei romanzi di Herman Melville aveva spinto Pavese verso una poesia e una scrittura che sotto la scorza realista e oggettiva nutriva una fortissima vocazione ermetica. Molto significative in questo senso, sono le introduzioni scritte per la traduzione di Benito Cereno nel 1940 e per la seconda edizione Frassinelli di Moby Dicknel 1941. Se nel secondo estratto si parla del “senso del mito di Achab”, nell’introduzione a Benito Cereno Pavese scrive che “il mare è assai più che un ambiente[...], il mare è qui la sola forma sensibile che agli occhi di Melville possa degnamente incarnare il cupo e ironico nòcciolo demoniaco dell’universo.”[2]
Ancora prima di Melville, però, deve essere stato l’incontro con il trascendentalismo americano a dare nuova linfa alle esigenze mistiche dell’ingenuo dannunzianesimo di maniera dell’età adolescenziale spogliandolo, grazie al vitalismo di Walt Whitman, di tutta l’Arcadia, dello psicologismo sentimentale e dell’aura decadente che permeava i primi esperimenti letterari. La concezione demonica – mitica – del reale, dunque, non è semplicemente figlia di un episodico incontro con autori come Withman e Melville: Pavese diviene presto consapevole di come tutta la letteratura anglo-americana possa essere spiegata alla luce della ricerca ironica di una misteriosa “realtà cosmica” sottesa alle parole e alle cose. È ancora d’oltreoceano che venne sicuramente mutuato anche l’argomento più meditato, forse il tema di Pavese per eccellenza: la wilderness, il selvatico.
Se pensiamo inoltre che la prima definizione di simbolico viene fornita da Pavese nel 1940 (nel saggio A proposito di certe poesie non ancora scritte) sulla scorta del testo dantesco e che la prima volta che la parola “mito” viene citata nell’accezione che poi ritroveremo nei saggi (nella lettera alla Pivano del 1942) è ispirata dalla letturadelle Georgiche di Virgilio, la “Germania segreta” appare soltanto una parte del paesaggio composito delle influenze pavesiane.
In un suo noto articolo, Italo Calvino sostenne che la preoccupazione ossessiva, il tema nascosto di ogni opera di Cesare Pavese altro non fosse che quello dei “sacrifici umani”[3]. Anche Furio Jesi a sua volta sostiene che la ricerca antropologica del poeta torinese era giustificata dal ritrovare “in ogni volume – seppure in diversa misura – ‘sangue e lussuria sacrali’”.[4]
Ma Sacrificio e suicidio, per Pavese, non possono essere semplicemente considerati unicamente come gli atti tramite i quali si possa far divenire la morte “un simbolo della realtà dell’essere”[5] o come l’unico accesso consentito dalla contemporaneità allo spazio mitico. O meglio, nel mito dell’aretè pavesiana si possono trovare morte e colpa, ma paradossalmente (e tragicamente), anche lo scatto estremo, il moto di rivolta attraverso il quale l’individuo riuscirebbe a liberarsi dalla coazione a ripetere e dalle cadenze mitiche del destino per sfuggire al “selvaggio” e a ribellarsi a quella che,con parole di René Girard, potremmo definire “logica sacrificale.
Tra coloro che hanno scelto nel paradosso della morte una ribellione alle cadenze mitiche del destino, possiamo trovare tanto l’esperienza orfica di Corònide, mitica madre di Asclepio, di cui Chirone nel dialogo Le cavalle dice: “se non altro ha trovato se stessa morendo”,[6] quanto la rivolta muta dell’orgogliosa Saffo, che nel dialogo Schiuma d’onda dice: “Non invidio nessuno. Io ho voluto morire. Essere un’altra non mi basta. Se non posso essere Saffo preferisco essere nulla”.[7]
In una lettera del gennaio del 1950, in ringraziamento ad Arrigo Cajumi, che aveva dedicato un saggio alla nuova “giovane generazione” di scrittori italiani, Pavese scrive: “La mia persona ne esce addirittura brilla, e quell’accenno ai greci ne è il colpo di grazia (ma non crede che proprio stoicismo si debba chiamare, d’accordo con questa grecità d’occhio, l’apparente cinismo o nichilismo mio o degli altri?)”.[8]
Se davvero era la Logica Sacrificale il “cupo e irònico nocciolo” dell’universo fantastico ed esistenziale pavesiano, costruire una strategia del perdono che si fondasse – come scriverà Paul Ricoeur molti anni dopo[9]– su di un “oblio responsabile” e su un “perdono difficile” dell’esperienza della colpa di tutto ciò che vive, deve essere sembrato a Cesare Pavese qualcosa di molto simile a una sconfitta o a una rinuncia. Furio Jesi definisce il suicidio di Pavese come l’esperienza dell’“ultimo mito sopravvissuto genuino ai suoi occhi: il mito del sacrificio alla legge, alla legge oscura che impone la morale, il dovere, la morte”.[10]Lo stesso atto crediamo che possaessere letto e compreso all’interno di un più assurdo mito della rivolta. Il suicidio, laddove la letteratura fallisca, può diventare la difesa estrema e la rivalsa contro la violenza della vita. Questa violenza, auto-imposta, esce dalla sfera passiva dell’offesa subita per rientrare nella sfera etica dell’intenzione, del giudizio e della volontà. La rivolta estrema dell’“ultimo scatto” che permette a Pavese di dimorare finalmente nello spazio della redenzione: “Perdono tutti e a tutti chiedo perdono”.
La letteratura è una difesa contro le offese della vita. Le dice “tu non mi fai fesso: so come ti comporti, ti seguo e ti prevedo, godo anzi a vederti fare, e ti rubo il segreto componendoti in scaltrite costruzioni che arrestano il tuo flusso”.
A parte questo gioco, l’altra difesa contro le cose è il silenzio raccolto per lo scatto, ma bisogna imporselo, non lasciarselo imporre. Nemmeno dalla morte. Scegliere noi magari un male è l’unica difesa contro questo male.Questo significa l’accettazione della sofferenza. Non rassegnazione ma scatto. Digerire il male di colpo. Hanno vantaggio quelli che per indole sanno soffrire in modo irruento e totalitario: così si disarma la sofferenza, la si fa nostra creazione, elezione, rassegnazione. Giustificazione del suicidio.
Qui non ha luogo la Carità. O non è forse la vera carità questo getto violento di sé?[11]
[1] F. Jesi, Cesare Pavese, il mito e la scienza del mito, in “Sigma”, i (1964), 3-4, pp. 95-120, ora in Id., Letteratura e mito, Torino, Einaudi 2002, pp. 131-160.
[2] C. Pavese, Prefazione aH. Melville,Benito Cereno, cit., pp. 92-93.
[3] I. Calvino, Pavese e i sacrifici umani, in “Revue des études italiennes”, xii (1966), 2, pp. 107-110, poi in Id., Perché leggere i classici, Milano, Mondadori 1991, pp. 324-328.
[4] F. Jesi, Lettere di Pavese: una confessione dei peccati, in “Uomini e idee”, viii (1966), 5-6, pp. 131-138, ora in Id., Letteratura e mito, cit., p. 183.
[5] F. Jesi, Introduzione a C. Pavese, La bella estate,Torino, Einaudi 1966, pp. vii-xxi,poi con il titolo Cesare Pavese dal mito della festa al mito del sacrificio, in F. Jesi, Letteratura e mito, cit., p. 175.
[6] C. Pavese, Le cavalle, in Id., Dialoghi con Leucò, cit., p. 29.
[7] Id., Schiuma d’onda, in Id., Dialoghi con Leucò, cit., p. 49.
[8] Dalla lettera di Pavese ad Arrigo Cajumi, in Id., Lettere 1924-1950, a cura di I. Calvino e L. Mondo, Torino, Einaudi 1966, vol. ii, p. 472.
[9] P. Ricoeur, Ricordare, dimenticare, perdonare. L’enigma del passato, a cura di N. Salomon, Bologna, il Mulino 2004.
[10] F. Jesi, Cesare Pavese: una confessione dei peccati, cit., p. 186.
[11] C. Pavese, Il mestiere di vivere…, cit., p. 125 (11 novembre 1938).