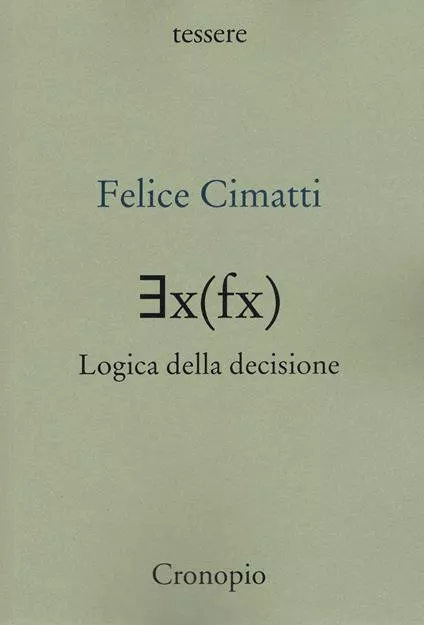La violenza del linguaggio
Abituati da una veneranda tradizione a considerare il logos come la caratteristica propria dell’essere umano, quella che meglio ne coglie l’irriducibile specificità, non si può che restare sorpresi dalla frequenza con cui, nell’ultimo libro di Felice Cimatti (∃x(fx) Logica della decisione, Cronopio 2024), l’aggettivo “inumano” viene adoperato in riferimento al linguaggio (p. 28, 30, 34, etc). L’incipit del libro, d’altra parte, non è meno spiazzante. Vi si legge, infatti, dopo un riferimento in esergo alla natura fascista della lingua tratto da Roland Barthes, la seguente affermazione: «La violenza del linguaggio non è quella contenuta in alcune particolari espressioni (ad esempio il cosiddetto hate speech), come se in linea di principio potesse esistere un modo di parlare non violento e neutrale; la violenza è insita nello stesso dispositivo linguistico, nella ‘sua’ decisione di dire il mondo in un certo modo anziché un altro» (p. 7). Alla fine di un serrato percorso argomentativo, il lettore scoprirà non solo che la violenza del linguaggio è propriamente quella che esso esercita nei confronti della vita, ma anche, e non meno sorprendentemente, che il libro, un libro di filosofia del linguaggio a tutto tondo, cela al suo interno un ‘problematico’ nucleo etico-politico. Ma procediamo con ordine. A che cosa serve il linguaggio? Per comunicare, è la risposta intuitiva che molti darebbero e che, del resto, circola largamente anche nella letteratura specialistica. Niente di più sbagliato. Appoggiandosi alla riflessione dei due ‘giganti’ del pensiero linguistico novecentesco, Ferdinand de Saussure e Noam Chomsky, Cimatti mostra che il funzionamento del linguaggio prescinde completamente dalla psicologia dei parlanti e dalle loro presunte intenzioni comunicative. Che lo si consideri come un dispositivo di natura essenzialmente sintattico-ricorsiva alla maniera di Chomsky, o come un fait social, secondo quanto affermava Saussure, il linguaggio sembra godere di un’esistenza autonoma rispetto alla quale il ruolo dei parlanti risulta, nella migliore delle ipotesi, irrilevante. «Una lingua, per Chomsky, funziona non grazie ai ‘suoi’ parlanti, bensì nonostante loro.
Perché una lingua, di per sé, è una sorta di meccanismo perfetto che appunto non ha bisogno di chi la parli. Si tratta di un punto fondamentale per comprendere l’intrinseca potenza inumana della facoltà di linguaggio […]» (pp. 27-28). La principale conseguenza che deriva da questa prospettiva – una conseguenza a prima vista controintuitiva (p. 79) – è che, considerato nel suo nucleo costitutivo, il linguaggio non ha bisogno di fare riferimento a qualcosa di esterno a sé. Esso si esaurisce in una dimensione che si potrebbe definire interamente ‘orizzontale’ di cui Chomsky e Saussure forniscono due descrizioni che, pur radicalmente differenti, finiscono per risultare in certo qual modo complementari.
Mentre, infatti, per l’uno (Chomsky) questa dimensione si riduce a una sola operazione fondamentale, quella che ricorsivamente ‘FONDE’ (merge) due oggetti già costruiti, due atomi concettuali, la cui origine rimane peraltro misteriosa, per l’altro (Saussure), essa è caratterizzata dalla relazione, appunto orizzontale, che collega ogni segno ad altri segni cosicché, come recita una delle affermazioni più note del Cours, «nella lingua non ci sono che differenze. Di più: una differenza suppone in generale dei termini positivi tra i quali essa si stabilisce; ma nella lingua non vi sono che differenze senza termini positivi» (citata alle pp. 80-81).
La lingua, dunque, vivendo di questo continuo gioco di rimandi, all’interno del quale un segno non fa che rinviare a un altro segno, non ‘incontra’ mai il mondo esterno, poiché non c’è alcuna relazione ‘verticale’ che colleghi un segno al suo (presunto) riferimento. Da questo punto di vista, la ricerca che a lungo impegnò Saussure sugli anagrammi, senza peraltro approdare a una conclusione, si rivela particolarmente istruttiva, poiché attraverso di essa «Saussure ha scoperto che il linguaggio c’è, e che procede indipendentemente dalla volontà (la performance) del parlante»; nella lingua, appunto, «tutto si tocca, e non si sa dove fermarsi». Non è il parlante che usa l’anagramma per ottenere un certo effetto poetico, al contrario, è la lingua a non essere altro che questo «implacabile» «movimento anagrammatico […] Il cosiddetto soggetto psicologico non è che un transito fra un significante e un altro significante, fra un anagramma e un altro anagramma» (p.86). Come spiegare allora il fatto che con il linguaggio facciamo continuamente (o pensiamo di fare?) riferimento al mondo, ovvero alla realtà in tutte le sue più svariate articolazioni?

La risposta che Cimatti fornisce a tale interrogativo discende del tutto naturalmente dalle premesse delineate. Il linguaggio o, per meglio dire, le lingue storico-naturali certamente ‘pretendono’ di fare riferimento al mondo, ma in realtà, questa pretesa non è nient’altro che il tentativo «di strappare un senso a ciò che, invece, non ne ha nessuno» (p.87). Si rivela in questo modo «l’intrinseca potenza istituente della parola» (p. 13), una potenza che precede la stessa distinzione tra linguaggio e mondo e in virtù della quale la parola umana sempre istituisce sia ciò di cui si parla, il suo essere qualcosa, sia la sua esistenza. A differenza di autori che, come ad esempio Searle, hanno lungamente insistito sulla distinzione tra ‘fatti istituzionali’ e ‘fatti bruti’, nella prospettiva delineata da Cimatti non c’è spazio per questa distinzione, «poiché ogni ente del mondo umano è, in grado maggiore o minore, un ‘fatto istituzionale’, cioè un fatto che è istituito mediante una procedura collettiva il cui caso più semplice è quello di ‘c’era una volta un re’» (p.44).
Va, naturalmente, subito sgombrato il campo da un’obiezione che appare tanto ovvia quanto fuorviante. Sopprimere la distinzione tra essere ed esistere non significa in alcun modo sostenere che non esistano oggetti, tantomeno che il reale sia una ‘invenzione’ delle lingue (p.15). Significa, invece, riconoscere che il linguaggio coincide con la volontà di nominare il mondo, un mondo che è certamente esterno al soggetto («ogni nome nasce dall’urto con qualcosa che non è l’io», con le parole che Cimatti, a p. 16, ricava da un saggio di un grande filologo e storico delle religioni di fine ‘800, Hermann Usener, da lui riletto sub specie linguistica), ma di cui il soggetto può fare esperienza, anche da un punto di vista percettivo, laddove si pensa di incontrare la realtà nella maniera più diretta possibile (i fatti bruti), solo attraverso la mediazione del linguaggio.
Diventano a questo punto chiari tanto il significato, quanto, soprattutto, le implicazioni teoriche del titolo scelto per il volume. La formula logica elementare, ∃x(fx), si rivela metafisicamente interessante poiché, attraverso il quantificatore esistenziale, stabilisce in anticipo, prima ancora di attribuirgli una determinata caratteristica (f), che qualcosa esiste. In questo modo, essa racchiude nella forma più limpida la logica che governa la relazione del linguaggio con il mondo, una relazione che sempre implica la decisione, preventiva, che il mondo sia in un modo piuttosto che in un altro. Il modello insuperato di questa logica può essere allora ravvisato nelle parole della Genesi: «Dixit Deus: ‘Fiat lux. Et facta est lux’», poiché «si tratta di un atto linguistico che istituisce l’esistenza di un particolare essere. Con questo gesto Dio propriamente decide che deve esserci la luce, e infatti la luce immediatamente c’è. Perché dev’esserci la luce? Semplicemente perché così Dio ha deciso che sia» (p. 46).
La violenza del linguaggio è, dunque, ineludibile, perché coincide con la violenza della decisione, di una qualunque decisione che stabilisce che il mondo sia in un modo piuttosto che in un altro. Del resto, come Cimatti opportunamente ricorda (p.137), l’etimologia della parola “decidere” rimanda all’azione del “tagliare”, anzi più precisamente del “tagliare via”, che è sempre implicitamente presupposta nel fatto di scegliere x piuttosto che una qualsiasi delle sue possibili alternative: «La violenza del linguaggio è nel comando che il linguaggio impone al mondo» (p. 46). Che ne è, allora, della vita del soggetto? Il libro suggerisce una duplice risposta a seconda che l’accento venga fatto cadere sull’uno o l’altro dei due termini. Da un lato, infatti, dal momento che il soggetto è il risultato del processo di “soggettivazione” messo in movimento dall’urto (di nuovo) del linguaggio con il corpo dell’animale umano (p. 33), il compito che gli si prospetta «è appunto provare a fare i conti con il dispositivo linguistico, che, come abbiamo compreso, persegue i ‘suoi’ fini, ammesso che siano fini espliciti, e non certo quelli dei suoi supposti utilizzatori» (p. 34).
Una forma di resistenza che nasce, innanzitutto, dalla consapevolezza di essere ‘prigioniero’ di quel dispositivo linguistico che pretende di controllare. Dall’altro, tuttavia, questa resistenza sembra inevitabilmente destinata al fallimento, data l’irriducibile alterità tra linguaggio e vita: «Il problema filosofico posto dalla vita è che la vita può esistere, in quanto fenomeno reale, solo finché non viene catturato da un qualche dispositivo categoriale, che lo classifica come un certo fenomeno vitale, animale o vegetale ad esempio. A questo punto l’indeterminato fenomeno vitale originario non c’è più» (p. 91). L’unica via di fuga consiste allora nel cercare «di sostare nello spazio indeciso che si apre ogni volta che una decisione si decide per un verso o per l’altro» (p. 137) oppure, con una formulazione ancora più significativa, nel provare a «‘galleggiare’, per così dire, fra le diverse nominazioni/decisioni» (p. 136). Che si resti convinti o meno della praticabilità di questa condizione oltre che dai modi scelti per ‘raffigurarla’ – il gatto né vivo né morto del famoso esperimento mentale di Schrödinger, il protagonista, Shrevek, di un noto romanzo di fantascienza, I reietti del pianeta, di Ursula Le Gun, percorso da venature ‘anarchiche’, passando per l’immanenza assoluta proposta da Deleuze – il libro solleva, con la radicalità delle sue tesi, un duplice interrogativo. Si tratta di una condizione meramente individuale? Ovvero, è possibile, e come, immaginarne una declinazione che tenga conto del fatto che l’uomo non solo è l’animale che parla ma anche, e non a caso, quello che vive nella polis?