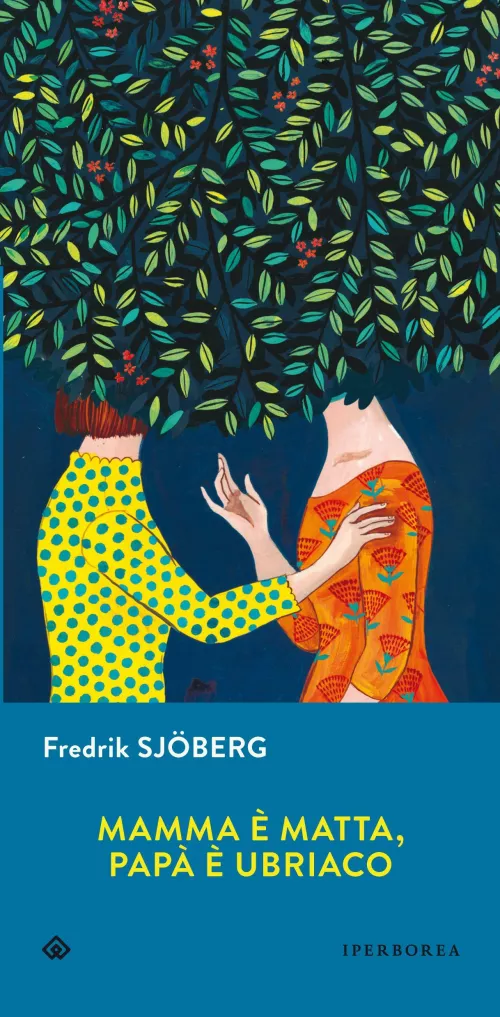Cosa rimane infine delle nostre vite? / Mamma è matta, papà è ubriaco
La gravosa domanda che mi sono posto, chiudendo l’ultima pagina di Mamma è matta, papà è ubriaco (Iperborea, traduzione dallo svedese di Andrea Berardini) di Fredrik Sjöberg, autore divenuto famoso qualche anno fa con L’arte di collezionare mosche, è: cosa rimane infine delle nostre vite?
Cosa rimane di tutto il tempo che viviamo e di tutte le cose che facciamo per riempire questo tempo? Cosa dell’immane sforzo che esercitiamo per tessere relazioni, affetti, per imparare un’arte o un mestiere? Cosa delle parole che abbiamo pronunciato e scritto, delle nostre ambizioni frustrate, dei nostri talenti e della nostra stupidità? E quali fattori determinanti condurranno tutta questa quantità sterminata di oggetti, luoghi, fatti, ricordi e dicerie legate al nostro nome a svanire nel nulla, a dissolversi nel tempo, a farci – da ultimo – dimenticare?
Credo che sia questa l’ambizione profonda che ha mosso Sjöberg nel voler ricostruire la vita dimenticata del pittore danese Anton Dich, nato a Copenaghen nel 1889, vissuto tra Göteborg, Parigi, la Costa Azzurra, Leopoli, e morto nel 1935 a Bordighera, nel cui cimitero è tuttora sepolto. Un pittore di cui, come si dice in questi casi, si sono perse le tracce. Eppure Dich era uno di quelli del giro giusto. Fu tra i bohémien di Montmartre negli anni della Belle Époque, amico di Modigliani, partecipò al Salone d’Autunno e a quelli degli Artisti Indipendenti a Parigi. Nulla di tutto questo però gli ha consentito di restare impresso nella memoria collettiva, neppure in posizione defilata. Anton Dich rappresenta un clamoroso caso di destituzione dal mondo dell’arte.
A interessare principalmente Sjöberg, tuttavia, non è solo la vita artistica di Dich, ma anche il suo privato, le relazioni, il matrimonio con Eva Adler, già moglie e vedova del famoso pittore Ivar Arosenius (lui sì una gloria della pittura svedese), ricostruire complicati alberi genealogici andando a ramificare la propria ricerca fino a perdersi in infiniti rivoli, tanti quante sono state le vite delle persone a lui vicine. In una parola, si direbbe, l’uomo-Dich, ossia il soffio smarrito della sua umanità, ciò che in fondo cattura sempre l’attenzione di uno scrittore in cerca di personaggi da raccontare.
Il tutto prende avvio da un’asta durante la quale Sjöberg si aggiudica un quadro firmato da Dich e risalente al 1921. Titolo: Hanna e Lillan. Il dipinto raffigura due adolescenti sedute en plein air, una mora e l’altra bionda. Sono cugine, e il paesaggio alle loro spalle è quello dei monti sopra Mentone, in Costa Azzurra. La bionda soprattutto, con un vestito bianco e le lunghe trecce che le scendono fin sotto le braccia, cattura l’attenzione dello spettatore per via dello sguardo acutamente intenso, al limite dell’ipnotico. Si tratta di Lillan Arosenius, figlia del pittore Arosenius, e considerata la bambina più ritratta della storia dell’arte svedese. La tela non se la passa bene, ha una grossa macchia d’umidità sul lato inferiore, il che fa sospettare che abbia trascorso la maggior parte del tempo nei recessi di una cantina, senza aver mai avuto l’onore minimo di una cornice e di una parete.
Per Sjöberg, Anton Dich appartiene alla razza degli eccentrici, è cioè quel che lui chiama un legno di deriva: “L’eccentrico è un tronco in mare che per anni viene trascinato dalle correnti per poi incagliarsi e finire arenato su una spiaggia”. Tra questi due movimenti, il trascinamento delle correnti e l’arenarsi sulla spiaggia, Sjöberg è però attratto in particolare dal momento di congiunzione, ossia dall’attimo in cui il legno è sul punto di essere trascinato via. Non tanto quindi dalla desolazione della fine, e neppure dalle cause che originano un fallimento. Quanto proprio da quella zona a metà, il vortice piccolo o grande che determina il naufragio. In altre parole, dalla circostanza che fa propendere per la fortuna o per l’oblio. In questo caso l’oblio.

“Certo, la guerra spiega parecchio […] ma il pittore Anton Dich è scomparso completamente, sparito senza lasciare tracce dalla storia dell’arte o da qualsiasi cosa ci si avvicini. E lo stesso vale per l’uomo. Può davvero essere un caso?”, si domanda Sjöberg. E poche pagine dopo dichiara apertamente cos’è, in questa complessiva rimozione, che lo colpisce tanto: li chiama “i meccanismi del disfacimento”, e dice di provare per essi attrazione e paura. Per un pittore come Dich, appartenuto a quell’epoca e a quel mondo, certi meccanismi si innescano solitamente con l’alcolismo e con la ricerca dell’ebbrezza. Quella cosa che Sjöberg definisce “l’anestesia creativa, in attesa del buio”.
Ma è ovvio che la direzione verso cui precipita Dich non è imputabile solo alla dipendenza dall’alcol. Sjöberg sostiene che al pittore danese mancava la qualità principale che contraddistingue gli artisti di successo: il coraggio. Il che resta tuttavia un argomento intimamente legato al tema dell’alcol. Cosa accade del resto al bevitore allo stadio iniziale? “L’audace si fa ancora più baldanzoso e impavido, l’umorista diverte ancora di più, l’aggressivo si fa violento, il credente diventa timoroso e così via”. E il vigliacco? Il vigliacco ristagna nei confusi pensieri sulla propria mediocrità. Quindi Dich era un vigliacco, aveva cioè impresso su di sé un marchio che il pubblico sa riconoscere da lontano. Ed è stato questo, forse, a condurlo all’oblio.
Più avanti, setacciandone la biografia in cerca del punto di caduta, Sjöberg ricorre a un’intensa metafora. Pare che due aquile che si sfidano afferrandosi per gli artigli perdano la capacità di volare. La loro caduta ricorda nella forma il movimento delle eliche in mogano che venivano montate sugli aerei da combattimento usati nelle due guerre mondiali. Le aquile precipitano avvinte l’una all’altra, finché, a pochi metri dal suolo, una delle due cede la presa e si rialza in volo. A volte però capita che nessuna delle due ceda. Racconta Sjöberg: “Diversi anni fa mi imbattei in due aquile morte nella parte settentrionale dell’isola. Erano a terra, vicinissime l’una all’altra […]. Si scoprì che non erano morte per un colpo di fucile. Forse erano un’elica caduta”. Così, il rapporto tra Anton e sua moglie Eva – ma anche, per estensione, tra Anton e la vita stessa –, ipotizza Sjöberg, dev’essere stato qualcosa di analogo.
Ed è qui che tocchiamo il cuore di questo libro, la zona a metà tra il trascinamento delle correnti e il naufragio, il vortice decisivo. Se ci lasciamo sedurre da questa metafora, non potremo fare a meno di guardare non solo alla storia privata di Dich, ma alla storia del mondo, come un cielo popolato di aquile-eliche avvinte l’una all’altra e in caduta libera, dove a decidere la sorte di ognuna è l’istinto che ne determina la sopravvivenza o la morte, quella pulsione che sta al limite tra coraggio e viltà, senza cedere all’idea che il coraggio determini la vita e la vigliaccheria la morte. Dopotutto chi è più coraggiosa, l’aquila che molla la presa a un metro dalla fine, o quella che non cede fino a morire schiantata?