Biennale Latella quarto atto / Nascondi(no): contro la censura della scena italiana
È verde acido, imponente, pressoché intrasportabile, più di 550 pagine di parole in due lingue. È stato uno dei cuori pulsanti della Biennale Teatro di Venezia firmata da Antonio Latella.
Il catalogo nella sua opulenza fa da specchio a una selezione dedicata all’Italia e al suo teatro, nel delicato momento che segue il lockdown, la chiusura e poi la timida riapertura degli spazi. Costituito di dialoghi tra il direttore e il suo drammaturgo Federico Bellini, oltre che di autopresentazioni degli artisti convocati, gioca anche graficamente col titolo dato a questo quarto e ultimo atto della direzione artistica del regista: Nascondi (no), scritto in un giallo quasi illeggibile. Dopo la selezione dedicata alle registe (2017), all’attore e alle sue trasformazioni in performer (2018), alle drammaturgie (2019), in questo 2020 si dichiara, anche con quell’espediente, che la proposta dedicata alla scena nazionale sarà ampia, ampissima, contro la censura e la rimozione che il sistema attua, emarginando molte esperienze, dando spazio ai soliti noti, trascurando e a volte lasciando morire una creatività diffusa.
Lo scrive anche, in altri termini, nella sua presentazione Mariangela Gualtieri, poetessa e attrice che ha inaugurato la rassegna il pomeriggio del 14 settembre con Voce che apre (quasi un rito), la dolcezza acuminata, a volte perfino ispida, di versi che vanno alla radice delle cose, delle relazioni, a disegnare un essere umano in cerca di armonie e sempre in pericolo di perdersi, di rovinare:
“Vorrei farmi porta aperta, disadorna porta sulla quale è scolpito un motto che dispone i visitatori all’attenzione, a una certa cautela nel passo: timore ebbrezza e tremore.
Ecco entriamo: è luogo di silenzio e di ascolto. Qui la voce umana intreccia i propri suoni evoluti con l’arcaico silenzio del mondo.
Qui – non saprei dire perché – sono presenti anche i morti.
Qui le attrici e gli attori si animano, da secoli, si consumano nel far dono di sé – per questo si sono a lungo preparati”.

Ultima latet, di Franco Visioli.
Questo scritto è la porta aperta di un catalogo e di un festival che vogliono riflettere sullo stato dell’arte teatrale in Italia, dopo tre edizioni principalmente puntate, con sguardo autoriale di Latella, a dipingere paesaggi stranieri poco conosciuti o del tutto incogniti. Possiamo chiamarlo un vero e proprio censimento affettivo, emozionale di forze emergenti o già emerse ma presto trascurate o costrette a sopravvivere ai margini. Il teatro dei 30-40enni (con qualche deroga), quello che ha subito i colpi più duri dal lockdown e che sembra reinventarsi perfino una lingua con una frontalità che rispetta il distanziamento spaziale, oltre e ribadire il fatto che non si tratta più di intrecci drammatici, dialogici, ma spesso di azioni monadiche proiettate su scenari dove molte singole lingue si giustappongono o si incrociano o in qualche momento si sovrappongono.
A scorrere le pagine del catalogo e la programmazione si leggono questi nomi: Alessio Maria Romano e Franco Visoli, cioè il Leone d’argento e il Leone d’oro, assegnati con coraggio a due artisti che lavorano per lo più dietro le quinte: a creare i movimenti di scena Romano, gli ambienti sonori Visioli, qui ognuno dei due con un debutto alla regia, altro atto di coraggio. Poi, elenco: Daniele Bartolini, Caroline Baglioni premiata dalla Biennale College Teatro 2018-2020 nella sezione autori under 40, Martina Badiluzzi, vincitrice della sezione College registi under 30, Giuseppe Stellato, Compagnia Biancofango, Astorritintinelliteatro, Teatro dei Gordi, Fabio Condemi, Filippo Ceredi, Alessandro Businaro, Giuliana Musso, Antonio Ianniello, Industria Indipendente, Pablo Solari, Unterwasser, Nina’s Drag Queens, Babilonia Teatri, Fabiana Iacozzilli. Giovanni Ortoleva, Leonardo Lidi, regista vincitore nel 2017-2018 del College, Leonardo Manzan, vincitore del College 2018-2019, Jacopo Gassmann, Francesco Manetti. Con l’ultimo atto, il 24 e il 25 settembre, dedicato alla finale dei registi del College 2020-21 (vinto da Paolo Costantini, con menzione speciale per Gianmaria Borzillo).

Automated Teller Machine, di Giuseppe Stellato.
Gilles Deleuze: far esistere, non giudicare
Molti sono i nomi nuovi, per un pubblico costituito principalmente di iscritti ai vari laboratori di formazione dei College, con un occhio forte alla necessità di ricambio delle leve del nostro teatro e al bisogno impellente di ripartire dopo il lungo blocco dei lavori. Domanda sottesa a tutto: come si fa a emergere o, viceversa, come più spesso la censura, delle scelte artistiche, del mercato, depauperano l’habitat della scena? Coerentemente sono “tutte prime assolute”, scrive Latella, “perché non ho scelto gli spettacoli”. Ha scelto gli artisti. E allora la domanda conseguente è se in questo caso la critica di merito non debba ritrarsi e non debba rinunciare a farsi tribunale. Scriveva Gilles Deleuze:
“Il giudizio impedisce l’avvento di qualsiasi nuovo modo di esistenza. Questo infatti si crea con le proprie forze, ossia con le forze che sa captare, e vale per sé stesso, nella misura in cui fa esistere la nuova combinazione. Forse è qui il segreto: far esistere, non giudicare. Se giudicare è così disgustoso, non è perché tutto si equivale, ma al contrario perché tutto quel che vale non può farsi e distinguersi se non sfidando il giudizio… Noi non dobbiamo giudicare gli altri esistenti, ma sentire se ci convengono o ci sconvengono, ossia se ci apportano delle forze oppure ci rimandano alle miserie della guerra, alle povertà del sogno, ai rigori dell’organizzazione. Come aveva detto Spinoza, è un problema di amore e di odio, non di giudizio” Gilles Deleuze, Critica e clinica (Raffaello Cortina editore, 1999).
Recuperare il giudizio, screditato negli anni intorno al ’68 e al ’77 e immediatamente successivi a favore della registrazione e analisi dei processi piuttosto che della disamina di prodotti, era diventata quasi un’urgenza di fronte al prosperare di una società, quella neo-televisiva e dei social media, che tende a essere orizzontale, mescolando ogni cosa in un’unica brodaglia indistinta. Ma i tempi cambiano rapidamente e oggi forse bisogna di nuovo saper cogliere i fiori che nascono in un panorama desertificato, e aiutarli a crescere. E comunque qui si richiama il problema di una responsabilità di sguardo profondo la critica, che spesso ha censurato, per essere poi essa stessa ridotta a marginalità inefficace.
Evitiamo quindi di sottolineare come certe drammaturgie siano deboli, non perfettamente all’altezza delle intenzioni; come certi riti risultino troppo esoterici per arrivare al pubblico; come può capitare ad alcuni spettacoli di impoverire le opere letterarie cui si ispirano. Si tratta, dicevamo, di prime rappresentazioni, che dal confronto con il festival e con gli spettatori trarranno probabilmente nuove spinte e definizioni. Qui è importante guardare, e cercare di riallacciare le condizioni per l’incontro. Non giudicare: far esistere, anche noi stessi come porte aperte sul nuovo, sulle possibilità, fuori dal già noto.

About Lolita, di Biancofango.
Di alcuni spettacoli
Provo allora a raccontare così le prime tre giornate, col rammarico di non aver potuto seguire interamente un festival che si pone anche come atto di scrittura unico, in una Venezia che appare semideserta, con pochi turisti a causa della pandemia, anch’essa da reinventare oltre il consumo del turismo usa e getta.
Alessio Maria Romano compone in Bye Bye un’opera lieve stilisticamente ma non senza note stridenti sulla condizione odierna, cantata con note calde di crooner e danzata. Illustra motti, stati dell’essere, presenze, doveri, voleri, verità vere e presunte, in tutti i loro strati di ambiguità, tra la parola proiettata (nelle canzoni, in didascalie video) e i corpi, spesso scatenati, in una coreografia-non coreografia del Leone d’argento che ha curato le azioni sceniche per famosi registi.
Franco Visioli in Ultima latet mette a confronto due attrici intorno a una rosa appassita, in un ambiente chiuso che rimanda alla Montagna incantata di Thomas Mann, in particolare alle polarità dei discorsi tra il progressista Settembrini e il gesuita Naphta, tra l’impegno e la sua inutilità, con l’apporto di Elisabetta Valgoi e Alice Torriani che fanno volare la prima regia del Leone d’oro in fitti, lunghi, statici scambi di battute.
Il distanziamento a teatro lo ritroviamo in Lampadario di Caroline Baglioni con la regia di Leonardo Lidi, una drammaturgia rievocante un momento del crollo del ponte Morandi di Genova, inerpicandosi come altre cose viste a confondere le piste, a aggrovigliarsi per cercare di rivelare altri panorami, non sempre a favore della comprensibilità e dell’immedesimazione nella storia, che pure assume nelle intenzioni un valore rilevante.
The Making of Anastasia della giovanissima Martina Badiluzzi gioca con la storia della donna che si presentò come Anastasia Romanov, l’erede degli zar, con l’intento, dichiarato nel plot, di fare un film sulla vicenda. Ne nasce uno sguardo in profondità allo show-biz, all’ansia di esibizione, alla presenza e all’intimità femminile, con squarci cinematografici e da talent show, in un’audizione a giovani attrici che mettono in scena quella storia, probabilmente di simulazione, e le proprie finzioni per conquistare la parte, per essere protagoniste, in un gioco spigliato di maschere e di piani incrociati, che fa i conti con la dissoluzione del corpo nella vecchiaia della presunta Romanov e con lo sgretolarsi del secolo, il novecento, e dei suoi miti.
Incisive sono l’azione di Giuseppe Stellato Automated Teller Machine e About Lolita di Biancofango. La prima è una performance facente parte di un ciclo che già avevamo avuto modo di apprezzare in un’edizione precedente della Biennale di Latella, lotte con macchine contemporanee. Qui la guerra è dichiarata da un bancomat, nel momento in cui il performer, che si presenta come addetto alle pulizie, prende i soldi e non ritira lo scontrino. La macchina, dopo averlo redarguito, inizia a vomitare un’infinita striscia di carta con tutti i movimenti economici e non solo della sua vita, invadendo il palcoscenico, tonando con voce che rivela le cose più intime, come i Big Data invadono e governano le nostre esistenze. L’uomo riesce a pulire lo schermo sporcato di nero durante questa deiezione di particolari personali: e appare un video gioco di tiro a segno contro gli irakeni di soldati americani, in loop.
About Lolita è mito e rito della nostalgia della giovinezza, di un’infanzia che diventa adolescenza aggredita da un quasi padre e da un suo amico su un campo da tennis. Manca qualcosa di importante del romanzo, in questa riduzione al quotidiano, in un neo iperrealismo che si impenna in scarti metaforici, magici. Lolita attraversa le attenzioni ambigue dei due uomini, senza farsene vittima, giocandoli con la sua purezza, con la sua forza, in un certo senso snudandoli nel bisogno di fuga dall’età adulta che inclina nella decadenza verso l’oro di un rimpianto. Molto bella la partita di tennis senza palla, segno di uno spettacolo che gioca a nascondino con la realtà e si proietta nel bisogno di altre dimensioni.
Astorri Tintinelli con Eh! Eh! Eh! Raccapriccio, ci propongono uno dei loro riti marginali, tra Beckett, Arrabal, l’ingenuità, la degradazione del nostro mondo, il sadismo capace di diventare tenero, ingenuo.

The Making of Anastasia, di Martina Badiluzzi.
Registriamo, quindi. Senza provare a nascondere i problemi che questi spettacoli avranno a farsi vedere in un sistema già precedentemente malato e ora al collasso. Annotiamo pure spinte modaiole, vecchie concezioni, abitudini espressive che marcano la minorità di un certo teatro che in certi casi si mantiene volontariamente inadeguato a misurarsi con lo spettacolo generale di un mondo indirizzato verso le semplificazioni delle fiction e i travolgenti ritmi delle serie televisive. A volte questi spettacoli sembrano innamorati di una metateatralità o di una letterarietà che mette le mani avanti, si fa vezzo, senza la forza di smontare davvero meccanismi avviluppanti né la capacità di rendersi a propria volta seduttivi. Segno di crisi che forse dobbiamo ancora compiutamente attraversare. Dalle quali è necessario riemergere, liberandosi da vecchie fole consolatorie come quella del teatro come comunità o come agorà (che poi l’agorà era un luogo che escludeva tutti i non cittadini, e non parliamo dei barbari), facendo i conti con la necessità di agire in un mondo ormai totalmente moltiplicato e disgregato.
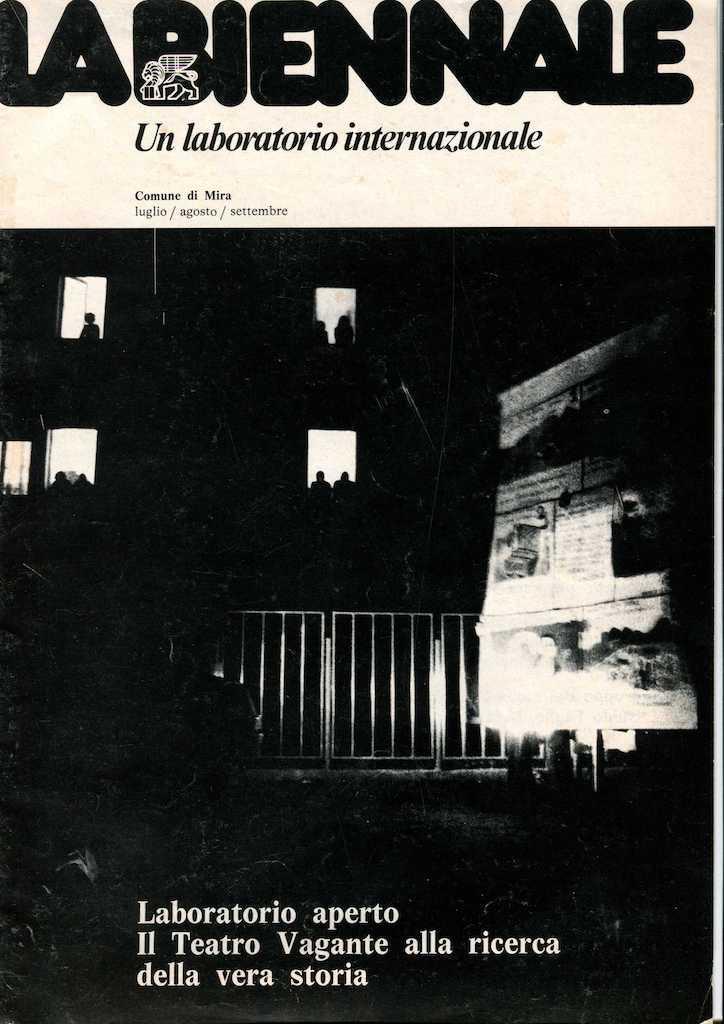
Pubblicazione della Biennale Teatro 1975.
Rimozione storiografica
Un ultimo caso di censura. Nel Padiglione Italia della Biennale ai Giardini di Castello si può vedere la bella mostra Le muse inquiete. La Biennale di Venezia di fronte alla storia. Sono evidenziati momenti in cui l’Ente, nelle sue varie branche, si è incrociato con tensioni politiche o sociali, dalla “fascistizzazione” degli anni trenta agli scontri del ’68, dalla censura al Berliner Ensemble negli anni cinquanta alle Biennali post golpe in Cile alla disseminazione della sezione teatro di Ronconi in laboratori e iniziative nel territorio. Bene, proprio in questo caso manca qualsiasi riferimento a una delle esperienze più significative, Il Teatro Vagante alla ricerca della vera storia di Mira, laboratorio aperto teatrale di Giuliano Scabia nella zona del Petrolchimico di Porto Marghera, azione di teatro dilatato e ricerca “antropologica” condivisa di storia orale, attraversamento di vissuti. Si parla di Grotowski, del Living Theatre, di teatro politico nelle fabbriche, ma non si annota un lavoro non incasellabile in nessuno dei generi noti - drammaturgia, ricerca, teatro d’attore, teatro del corpo, teatro politico, laboratorio… – un percorso aperto alla ricerca, alla relazione, al tentativo di reinventare e moltiplicare una poesia dell’incontro, della memoria, della progettazione di modelli di vita e di ambiente differenti.
L’ultima immagine raffigura il momento finale dello spettacolo di apertura di Mariangela Gualtieri; come le altre fotografie degli spettacoli è pubblicata per gentile concessione della Biennale di Venezia ©Andrea Avezzù.







