La condivisione difficile / Nostra sorella solitudine
Sembra sia stata la “svolta linguistica” a mandare in crisi la corrispondenza tra le parole e le cose. A un certo momento, collocabile più o meno tra la fine del diciannovesimo e l’inizio del ventesimo secolo, la macchina della certezza del pensiero positivo è andata in crisi con le conseguenze dissolutive note. Si è prodotta anche da lì una nuova solitudine. Abbiamo scoperto che diciamo sempre quasi la stessa cosa, noi animali di parole, e non smettiamo di restare almeno in parte soli mentre continuiamo a cercare di approssimarci, a tentare forme diverse di condivisione.
Condivisione, che da un punto di vista morale si carica immediatamente di significati positivi, mentre fa i conti con il massimo dell’unicità indivisibile che quella comunanza dovrebbe esprimere: l’individuo, l’indivisibile, appunto. Dovremmo riconoscerci come “dividui” portatori di “diventità”, come da diverse fonti di ricerca pare sempre più sostenibile. Approfondire la contraddizione tra individualità e condivisione vuol dire cercare di comprendere il rapporto tra intersoggettività e indifferenza, tra conflitto e cooperazione, tra ospitalità e ostilità, tra conformismo e innovazione. Nella condivisione intervengono, pertanto, la lealtà e la voce, la solitudine e la fiducia e l’analisi delle molteplici polarità contraddittorie può evidenziarne la funzione nella socialità umana e nella crisi del legame sociale, oggi. A pensarci bene parlare di condivisione oggi vuol dire considerare, tra l’altro, la polarità tra il gesto di chinarsi per aiutare uno che ha bisogno per sollevarsi, e un “like” di Facebook, che pure si propone come una delle pratiche di condivisione del nostro tempo. Due situazioni estreme che segnano però le trasformazioni in corso.
Come ci suggerisce un grande scrittore: “C’è stato un tempo in cui credevamo di saperlo. Credevamo che quando il testo diceva: ‘Sul tavolo c’era un bicchiere d’acqua’, ci fosse davvero un tavolo e sopra il tavolo un bicchiere d’acqua, e ci bastava guardare nello specchio di parole del testo per vederli. Ma tutto questo è̀ finito. Lo specchio di parole s’è̀ infranto irreparabilmente, a quanto pare” [J. M. Coetzee, Elizabeth Costello, Einaudi, Torino 2005].

Era stato Hofmannhstal a cogliere tra i primi quanto stava accadendo e si sarebbe confermato come un codice del tempo in cui viviamo: “In un primo tempo mi divenne gradualmente impossibile trattare temi sia elevati sia comuni e formulare quelle parole, di cui ognuno suole servirsi correntemente senza stare a pensarci. Provavo un inspiegabile disagio solo a pronunciare le parole ‘spirito’, ‘anima’ o ‘corpo’. Trovavo impossibile, nel mio intimo, esprimere un giudizio sulle questioni della corte, i fatti del parlamento, o quel che vogliate. E ciò non per qualche sorta di prudenza, e difatti conoscete la mia franchezza che giunge a sconfinare con la leggerezza: ma le parole astratte, di cui la lingua, secondo natura, si deve pur valere per recare a giorno un qualsiasi giudizio, mi si sfacevano nella bocca come funghi ammuffiti” [H. de Hofmannhstal, Lettera di Lord Chandos].
Un’eco di tutto questo la troviamo anche in Lewis Carrol, che in Alice nel paese delle meraviglie mostra la relatività dei significati delle parole:
“Quando io uso una parola”, Ovorondo disse in tono piuttosto sprezzante, “significa esattamente ciò che voglio io…né più né meno”.
“La questione è”, disse Alice, “se lei può dare alle parole dei significati tanto diversi.”
“La questione è”, disse Ovorondo, “chi è il padrone… ecco tutto”.
Ad aiutarci a mettere a fuoco al meglio la questione è come sempre la poesia. Anna Achmatova, sul limite fatale di ogni relazione, limite che è la condizione della possibilità di quella relazione, scrive:
“C’è nel contatto umano un limite fatale,
non lo varca né amore né passione,
pur se in muto spavento si fondono le labbra
e il cuore si dilacera d’amore.
Perfino l’amicizia vi è impotente,
e anni d’alta, fiammeggiante gioia,
quando libera è l’anima ed estranea
allo struggersi lento del piacere.
Chi cerca di raggiungerlo è folle,
se lo tocca soffre una sorda pena…
ora hai compreso perché il mio cuore
non batte sotto la tua mano”.

La solitudine è una questione relazionale e pubblica. Eppure viene letta principalmente come se fosse un problema individuale, privato. Anche se un fenomeno pubblico la solitudine lo è sempre stato, non è difficile comprendere perché ci appare un fatto personale, riguardante i singoli. Chi è solo è solo, ma oggi sembra che si sia soli in modo diverso dal passato. Come ha intuito efficacemente Sherry Turkle, le nuove tecnologie alla base della comunicazione digitale contemporanea ci fanno credere di essere meno isolati perché sempre connessi. Si tratta però dell'illusione di una reale intimità: i nostri profili online esistono in funzione del numero dei contatti, oggetti inanimati e intercambiabili che acuiscono il senso di solitudine. Allo stesso tempo si sta completando il ventaglio dei rapporti possibili con i robot, dall'ipotesi di affidar loro i propri figli a quella di farne dei veri e propri partner. Mentre gli amici in rete sono in realtà presenze prive di sostanza, molti desiderano, talvolta disperatamente, attribuire emozioni umane ai robot. Siamo in una storia di dissociazione emotiva ma pure di speranza, perché anche dove la saturazione digitale è maggiore, molti, soprattutto fra i giovani, si interrogano su cosa sia davvero il rapporto umano, e chiedono un ritorno a forme più naturali di dialogo.
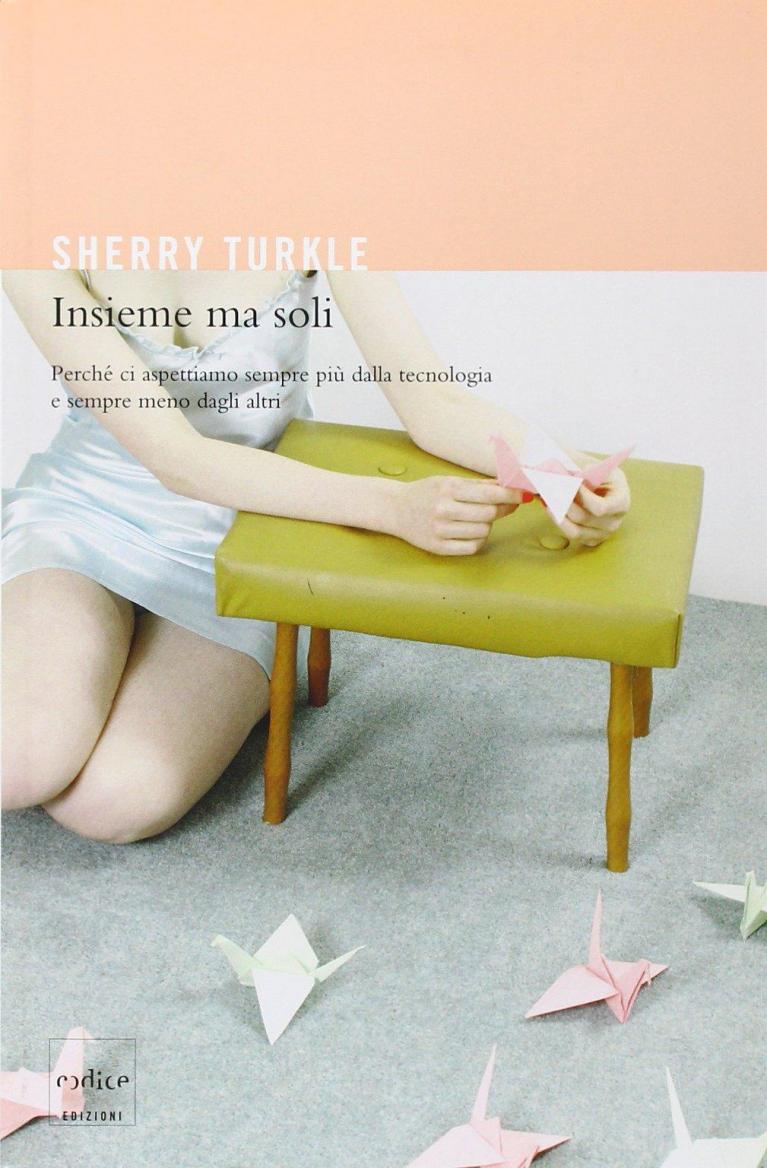
La solitudine contemporanea nasce, in buona misura, da quella interrogazione e dalla consapevolezza di questa profonda trasformazione. Ma quanti sono capaci di quell’interrogazione? E quanti invece abitano tacitamente il mondo delle nuove solitudini confondendole o con libertà e autonomia o con destini ineluttabili? A farci difetto, a mancarci, per restare dalle parti della ricerca di Sherry Turkle è la conversazione, quella particolare possibilità di versare in una direzione condivisa i nostri orientamenti, i nostri pensieri e la nostra continua approssimazione, quella disposizione ad avvicinarci originata dalla nostra naturale intersoggettività. È vero però che ci si può avvicinare per diversi motivi e con molteplici esiti: per condividere qualcosa; per abbracciarsi o prendersi cura l’uno dell’altro; per aggredirsi (“adgredior” in latino vuol dire avvicinarsi); per esprimere indifferenza; per dialogare. Sherry Turkle analizza l’importanza del dialogo e la sua profonda crisi in La conversazione necessaria, Einaudi, Torino 2016.

Stando alla pervasività delle nuove tecnologie alla base della comunicazione digitale contemporanea dovremmo essere meno isolati perché sempre connessi. Questo è il paradosso indagato da Sherry Turkle: mentre gli amici in rete sono in realtà presenze prive di sostanza, molti desiderano, talvolta disperatamente, attribuire emozioni umane ai robot, anche perché le tecnologie sono inevitabilmente frutto delle nostre proiezioni. "Insieme ma soli" è una storia di dissociazione emotiva ma anche di speranza, perché anche dove la saturazione digitale è maggiore, molti, soprattutto fra i giovani, si interrogano su cosa sia davvero il rapporto umano, e chiedono un ritorno a forme più naturali di dialogo. Secondo la Turkle, alla fine Facebook e l'iPhone ci spingono a ricordare chi siamo veramente: esseri umani con scopi umani.
La solitudine individuale, secondo Eriksen, si manifesta in un’età veloce e surriscaldata; contraddistinta da ineguaglianze e iniquità. È l'età dell'Antropocene, un’età in cui scopriamo che l’evoluzione possibile può essere principalmente culturale; ognuno rischia di sentirsi più solo mentre si interroga sul futuro dell'umanità sul pianeta. Nella sua discussione intorno alla modernità globalizzata, adottando l'approccio antropologico, Eriksen connette la solitudine a tre crisi interconnesse: quella ambientale, quella economica e quella identitaria. Se è vero che queste crisi sono globali per ampiezza, vengono però percepite e subite a livello locale, e sono moltissime le contraddizioni che sorgono tra le forze di standardizzazione dell'età dell'informazione del capitalismo globale e la natura socialmente stratificata delle vite individuali. Quelle contraddizioni si trasformano molto spesso in solitudine, anche e forse soprattutto quando si cerca di affermare una differenza individuale, magari controcorrente.
È stato ancora una volta Brodskij a cogliere uno dei principali problemi di sempre: “chiunque si dia da fare per creare dentro di sé un proprio mondo indipendente, è destinato prima o poi a diventare un corpo estraneo nella società e a essere soggetto a tutte le leggi fisiche della pressione, della compressione e dell’estrusione” (Conversazioni, Adelphi, Milano 2016; p. 39). La solitudine si colloca tra il bisogno di autonomia e l’intersoggettività che ci fonda. Non ci liberiamo mai degli altri, anche in loro assenza, provvisoria o definitiva. Avere un sé vuol dire contenere tanti altri, cioè essere uno, nessuno o centomila, come il genio di Pirandello aveva intuito. A quella stessa complessità allude forse l’affermazione: "Di sé, più che degli altri, non ci si libera mai" che Letizia Pezzali scrive, in Lealtà, Einaudi, Torino 2018 (p. 67). La solitudine con l’articolata difficoltà di condivisione attraversa la narrazione della Pezzali e percorre molteplici scene della nostra vita contemporanea, ponendo in tensione l’intersoggettività e il sentirsi soli come costo e come aspettativa.
Il fatto è che noi siamo esseri intersoggettivi, non individuali. La solitudine diventa un problema perché è una deprivazione di ciò che è costitutivo del nostro essere: la relazione. La solitudine è oggi una vera e propria piaga sociale, tanto che il Regno Unito ha istituito un ministero della solitudine. Secondo Eurostat, l'11,9% degli italiani sopra i 16 anni non ha nessuno con cui parlare dei propri problemi personali. Siamo tutti connessi ma molto soli. Le ragioni sono tante, ma almeno in parte riconducibili a tre categorie. Innanzitutto l'indifferenza è aumentata man mano che cresceva la nostra coscienza di soggetti planetari. Siamo diventati tutti abitanti del mondo, ma portiamo addosso un senso di distanza dai fenomeni che accadono. Un secondo aspetto è quello economico: l'iperliberismo economico ha esasperato l'individualismo. Abbiamo vissuto una crisi profonda di tutti i sistemi di intermediazione sociale e l'individualismo, cioè la concentrazione sul singolo come soggetto di riferimento dei consumi e come responsabile di se stesso e del proprio destino, ha prodotto molta solitudine. Il terzo fattore è la crisi dei legami sociali: le forme di vicinato, di convivenza, di socialità urbana ma anche la coscienza sindacale e sociale, oggi sono in grandissimo declino. Tutto questo ha comportato un forte ritiro nel privato e di conseguenza un effetto di solitudine molto potente. In questo contesto, ad esempio, l'interesse verso gli altri, in particolare gli anziani, rischia di essere solo un'illusione. Oggi c'è una grande industria intorno agli anziani, che rappresentano una delle più rilevanti fonti di business. Non c'è un piccolo paese che non abbia una casa di riposo e queste sono generalmente privatizzate. In generale, non sembra che nelle famiglie contemporanee vi sia un'effettiva forma di affettività solidaristica e quindi un riconoscimento del valore della presenza dei vecchi. C'è l'esibizione di una patina moralistica prevalentemente italiana, quella del mito dell'attenzione alla famiglia; però nella pratica le cose non sembrano funzionare così.
Basterebbe l’affermazione "Quanti anni ha?" di fronte a un anziano malato per avere un indicatore dello stato delle cose. Questo significa che se uno ha più di ottanta anni l'attenzione verso di lui cala e si comincia a fare un calcolo economico della speranza di vita. Ovviamente ci sono tante famiglie che si prendono cura amorevolmente dei propri anziani, ma in molte altre questo non accade.
Non è sempre stato così. Prima era diverso: fino agli anni '60 del secolo scorso vi era un valore riconosciuto nei cosiddetti anziani. Socialmente la loro era una funzione importante, di saggezza e di guida. Poi è subentrata una visione che relega la vita "che conta" nella fascia del tempo lavorativo. Su questa concezione ha influito anche l'allungamento esponenziale della vita media: il valore dell'età è diventato inversamente proporzionale all'età stessa. E questo è diventato un fatto scontato, normale. Si tratta di un autentico processo di emarginazione sociale, di cui è responsabile la nostra intera società. È la "cultura dello scarto" di cui ha parlato l’attuale papa. L'atteggiamento sociale, soprattutto verso gli anziani, è quello di marginalizzazione e di esclusione. Questo è diventato cultura e la cosa che fa paura è che lo diamo per scontato. Oggi c'è una problematica propensione giovanilistica nella nostra società: è una società di “adultescenti”, in cui chi ha una certa età fa di tutto per apparire più giovane. La parola “vecchio” e la parola “morte” sono state escluse dal nostro vocabolario e questo è molto grave perché una comunità così rischia di essere psicotica: negare queste due realtà presenta sintomi patologici. È importante chiedersi se questo dilagare della solitudine sia un fenomeno arrestabile. Perché fosse arrestabile richiederebbe una cultura nuova e un investimento pubblico che la sostenga. C'è bisogno di un riorientamento educativo della popolazione, che dev'essere incentivato. Non possiamo immaginare di lasciare un problema così importante alla buona volontà dei familiari. La salute è un bene pubblico non solo privato.
La nostra Costituzione recita: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana". La realizzazione individuale vale fino a quando uno è vivo, e non fino a quando uno ha quarant'anni. Ci sarebbe bisogno di una politica pubblica che non sia indirizzata solo dall'alto verso il basso, ma che alimenti le reti sociali orizzontali e le reti corte che portano all'impegno sociale distribuito. Si potrebbe anche combattere l'enorme disoccupazione giovanile con interventi civili nel campo dell'assistenza alle persone anziane. Del resto, oltre agli anziani, la criticità riguarda anche il rapporto tra giovani e solitudine. Il livello di solitudine profonda dei giovani all'interno di quella che sembra un'apparente socialità è molto più elevato di quanto si possa immaginare. È molto carente la solidarietà e la capacità di aggregarsi. Forse per evitare di assumersi responsabilità concrete si giunge alla creazione di un ministero per la solitudine, come è accaduto, appunto, nel Regno Unito. Sembra una trovata propagandistica orientata al consenso. È come se si creasse un ministero delle alluvioni invece di fare un ministero dell'Ambiente che tuteli e protegga le risorse. Il fatto che venga riconosciuto il problema è positivo, ma pare che il modo di affrontarlo sia discutibile, perché non si dovrebbe amministrare la solitudine ma prevenirla. Domandarsi perché, in ultima analisi, l'essere umano ha bisogno di non restare solo, può aiutare a comprendere alcuni aspetti della solitudine. Noi siamo degli esseri intersoggettivi, non individuali. L'individuo nasce da una relazione, che genera la soggettività. Per noi esseri umani la relazione è pre-intenzionale, pre-volontaria e pre-linguistica: siamo animali sociali. La solitudine diventa un problema perché è una deprivazione di ciò che è costitutivo del nostro essere: la relazione. Noi sentiamo quello che sente l'altro e sappiamo quello che l'altro sta provando in buona misura prima di chiederglielo. Avremmo perciò bisogno di spiegare come mai, pur essendo naturalmente intersoggettivi ed empatici, siamo capaci di negazione e indifferenza, finendo così frequentemente per vivere in solitudine.







