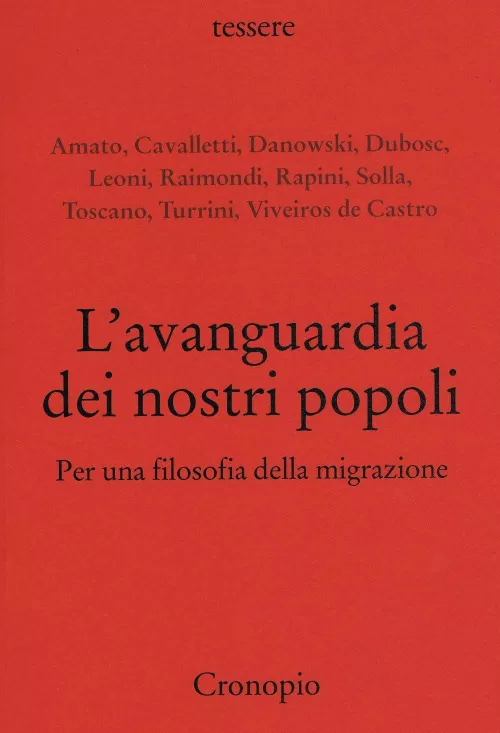Al di là dei confini delle nazioni / Per una filosofia delle migrazioni
Un’immemorabile tradizione teorica sembra aver reso la politica ostaggio di una strana pratica di divisione, segmentazione e personificazione arbitraria del suolo, tale per cui si è finito per identificare come naturale e indiscutibile qualcosa che invece si dà (o almeno si dava) per accordo, storia, talvolta contesa. Tale teoria ha fatto così tanti danni che ancora oggi, non di rado, capita di ritrovarsi a far coincidere la propria appartenenza comunitaria al ristretto lembo di terra in cui si è nati, riconoscendo come consimili solo coloro i quali, sulla base di un’iscrizione alla nascita garantita da corredo genetico, appartengono allo stesso circoscritto suolo.
Con innumerevoli sforzi, i teorici di questa maniera di pensare il mondo si sono spesi in forbite elucidazioni per mostrare come il gesto inaugurale della politica sia anche la sua linea di orientamento: ovvero quel solco tracciato a terra che, grazie alla distinzione tra il proprio e l’esterno, riesce ad attribuire a ciascuno il proprio ancoraggio terrestre come primo e fondamentale premio per il più antico concorso cui la civiltà umana ha partecipato: quella corsa all’accaparramento sulla proprietà della terra che fin dall’inizio stabilisce ciò che è mio e ciò che è tuo.
Questa origine della civiltà – così presente quanto così immemorabile – non ha inquinato soltanto le più comuni nozioni con cui pensiamo alla politica e al diritto, ma anche, ad esempio, la geografia che ha cominciato la sua opera di cartografia riducendo la terra a perimetro inerte da occupare e misurare, res nullius o terra incognita per gli esploratori e i cacciatori che davano inizio all’impresa coloniale, superficie (resa) liscia e vuota in attesa dei suoi futuri occupanti. Da questo punto di vista la storia dell’umanità può essere raccontata come la storia di un’infinita lotta tra i barbari e gli agrimensori: tra gli alacri sezionatori che suddividendo la terra in parti misurabili hanno costituito nel seno del mondo una ristretta comunità di simili, e i barbari, coloro che, balbuzienti, non si sono adattati alla lingua della sovranità del confine.
Stabilita la proprietà anche sull’ultimo straccio di terra, la vita degli agrimensori però – ce ne accorgiamo oggi nel momento in cui il loro dominio sembra volgere al termine – si è dimostrata in definitiva molto povera e triste: non solo perché continuamente minacciata dai risorgenti fantasmi dell’invasione o del furto della proprietà – quindi dello smarrimento della propria identità; ma anche perché costantemente traversata dallo spettro della scarsità: scarsità di spazio, scarsità di risorse, scarsità di popolazione. Il recinto infatti sembra essere sempre non abbastanza capiente per contenere l’aumento della popolazione, e anche le risorse, in primo luogo quelle ambientali, paiono troppo scarse e in diminuzione per poter soddisfare tutti. Da qui l’ansia che la popolazione cresca e non ci sia spazio sufficiente per tutti; la bramosia con cui si guarda al di là del proprio steccato la fiorente terra del vicino; la caccia al territorio limitrofo che diventa lo “spazio vitale” per il sostentamento della sua popolazione; la preoccupazione per le ondate migratorie che svilendosi sulle battigie potrebbero succhiargli via la terra sotto i piedi. L’agrimensore, difatti, non conosce altro modo di inventare nuovo spazio, conosce solo il modo di occuparlo e di impadronirsene: l’occupazione, o l’appropriazione indebita, sono il punto di inizio (ma anche il punto di collasso) della sua civiltà.
Presto, dunque, l’agrimensore inizia a stabilire ciò che all’interno del suo territorio risulta in eccesso, e dividendo la popolazione cerca di distribuire la parte in eccesso agli agrimensori vicini. Inizia così il miserabile calcolo delle quote che ogni agrimensore è disposto a ricevere; ognuno fa spallucce e cominciano le moine estive, quando i barbari si muovono in barchetta e sono aiutati dal vento. Quello che è rilevante notare è che, anche qui, il criterio per accettare una piccola parcella di quei barbari rimane sempre e solo il terreno: quanto è vasto, quante persone vi risiedono, quante risorse può avere. Tutta la distribuzione, e la politica successiva, riporteranno l’insieme di azioni a quel gesto iniziale: la misura della terra.
Siano dunque massimamente benvenuti coloro che, nelle più diverse forme, si impegnano a smontare questa storia che da secoli sembra andare avanti uguale, misera e gretta. C’è chi si impegna per mare, organizzando l’aiuto verso quei barbari che scartati di terra in terra flottano per arrivare in un posto che li accolga; chi si inventa comunità diverse da quelle che fanno della nascita su un determinato suolo nazionale l’imperitura segnatura di un’appartenenza; chi, infine, prova a scomporre quella matrice del confine a cui i nostri ordinamenti sembrano ancora ancorati. È a quest’ultima categoria che dobbiamo ascrivere lo sforzo intellettuale che Gianluca Solla e Andrea Cavalletti in L’avanguardia dei nostri popoli. Per una filosofia della migrazione (Cronopio, 2020) svolgono. Di fronte all’attuale proliferazione dei confini e alla spartizione della terra in rigide comunità nazionali, i due curatori mettono su un ensemble di pensatori che pone in questione il confine come dispositivo epistemologico, luogo di disvelamento dell’ordine della sovranità.

Lungo tutto il testo, gli autori convocati si alternano in una vasta topografia mobile dei nomi di quelli che l’ordine degli agrimensori ha definito barbari, ma che di volta in volta i nostri ordinamenti nazionali appellano populace, rifugiati, migranti economici, diversi. Ritracciando così il racconto delle migrazioni nel Novecento, attraverso la storia della revoca della cittadinanza degli “ebrei stranieri” durante il fascismo, la storia del sottoproletariato italiano migrante raccontata da Pasolini, come anche degli effetti che la pratica coloniale in Algeria ha avuto sugli intellettuali engagés in Francia, gli autori provano nel testo a identificare ed esibire i dispositivi di inclusione e di esclusione che hanno plasmato le nostre soggettività, definito il nostro habitus, stabilito i nostri modelli discorsivi e, soprattutto, costruito violentemente chi è meritevole di risiedere in uno Stato, chi no.
Si chiarisca però immediatamente una cosa. Quando nel testo si parla di dispositivo di inclusione o esclusione non ci si deve figurare l’alto muro di cui straparla Trump, meno che mai la Meloni a capo di una flottiglia in pieno Mediterraneo centrale. Il dispositivo che regola nei nostri giorni ogni forma di spostamento non produce tanto severe norme riguardanti le linee del confine, stabilisce piuttosto le condizioni di un loro attraversamento. Quando vociano di chiudere i porti, mica li bloccano davvero: alzano soltanto l’asticella per cui un porto diventa ora irraggiungibile.
Quando l’ottenimento della cittadinanza viene reso l’inestricabile selva di concessioni, permessi, visti temporanei, carte “gentilmente” concesse, non si vuol certo dire che l’attribuzione di cittadinanza risulti impossibile, si vuol invece prefigurare un percorso di ottenimento della cittadinanza come infinita corsa ad ostacoli, processo continuo, implicato in ogni istante di vita e in ogni atto dell’esistenza, a cui è difficile attribuire un inizio o una fine. Come dice Abdelmalek Sayad ricordato da Fabio Raimondi nel libro, l’integrazione nello stato deve diventare “la curva asintotica che possiamo tracciare all’infinito e che non toccherà mai l’ascissa”: una cittadinanza che si deve sempre meritare, con sempre nuovi sforzi, con il sudore e la fatica, con l’umiliazione e la genuflessione, con il ringraziamento e le ore di lavoro in nero – in una torsione della bio-politica per cui la morte diventa più probabile e vicina di quella vita resa ormai impossibile. Il dispositivo del confine, allora, non esclude semplicemente, piuttosto istituisce delle zone dell’indistinto: ovvero forma una situazione di soglia, di non-dentro e di non-fuori, che rimane incarnata nelle persone soggette ai dispositivi di confine: il migrante, potremmo dire, porterà sempre con sé all’interno dello Stato una sorta di alone d’estraneità personale.
Lo ricorda molto bene Alberto Toscano interrogandosi sui nomi, o meglio sull’assenza di nomi che i barbari nei nostri ordinamenti hanno: nomi indefiniti come ‘straniero’, ‘indigeno’ e, ovviamente, ‘migrante’, “nome dalla coloritura zoologica e, significativamente, mai impiegato per i bianchi”. Esistere – lo sappiamo fin dalla nascita – significa al contrario dotarsi di un nome, esistere attraverso un nome che diventa il primo vettore di eguaglianza, ciò che rende la vita possibile. Negli abissali fondali del Mediterraneo come negli abusi quotidiani, al contrario, la vita si nega proprio dimenticandone il nome. Così l’umanità, abbandonata nella morte priva anche del nome, viene ricordata e contata solo nella statistica.
Oggi lo scenario, lo sappiamo, è ulteriormente complicato dalle migrazioni dettate dai cambiamenti climatici e dalle trasformazioni geo-terrestri, che nel libro trovano spazio grazie agli illuminanti interventi di Fabrice Olivier Dubosc, Déborah Danowski ed Eduardo Viveiros de Castro. Proprio per questo, all’interno della catastrofe ecologica e umanitaria, gli autori sentono ancora più urgente la necessità di rilanciare la sfida di una politica le cui precondizioni siano la prossimità non voluta e la coabitazione non scelta con chi, perduta la propria terra, deve inventare una nuova comunità cui partecipare. Che sia il demos per gli antichi greci (spiegato da Gianluca Solla in quanto contrapposto all’ethnos) o il popolo a venire (di cui nel testo dicono Pierandrea Amato e Danowski-Viveiros de Castro), cruciale è per tutti gli autori immaginare nuove appartenenze comunitarie che riescano a smarcarsi dai legami biologici, di sangue, di stirpe e di famiglia che, dicevamo all’inizio, hanno finito per personificare un territorio e attribuire cittadinanza politica solo in dipendenza dalla nascita.
Prima chiamavamo piuttosto misera e sempre minacciata dalla scarsità la vita di quelli che fanno del territorio la precondizione e il punto d’arrivo della politica; questa resta tuttavia ancora il modo attraverso cui immaginiamo le nostre identità, legati come siamo a una narrazione dell’agrimensore che ancora ci affascina. Ecco perché sono tanto necessari e urgenti quegli sforzi teorici e immaginativi che scalzino quella storia dalla sua cosiddetta posizione fondativa. Solo resistendo al vortice di un’origine che comanda e ne detta i modi di funzionamento, la politica potrebbe essere finalmente pensata non più a partire da un territorio (lieu) ma come luogo di costruzione di ambienti comuni (milieu): come ciò che si costruisce insieme e che rimane sempre tra noi (mi-lieu), luogo inappropriabile per ogni agrimensore.
Ma appunto sta anche in questo la difficoltà di ogni sforzo teorico-politico che si voglia solidale, generativo, accogliente, poiché il lato tragico della narrazione del barbaro è proprio la sua inappropriabilità, la sua irrappresentabilità, per uscire dalla quale crediamo non basti semplicemente un’identificazione e un’esibizione del “funzionamento dei dispositivi” (del confine, dell’identità, della migrazione); o meglio, per citare infedelmente Marx, la coscienza di classe sembra non portarci automaticamente alla rivoluzione. Anzi, diciamo di più: forse l’impasse teorico-politica più grande nella quale siamo tutte e tutti, in primo luogo chi scrive, catturati sta proprio nel restare confinati e prigionieri di una iconoclastia, di un rifiuto di un dire assertivo, affermativo, propositivo sulla vita buona, che riusciamo a esprimere solo ex negativo, solo criticando il dispositivo.
L’approccio teorico del nostro tempo sembra così sentirsi più a proprio agio nell'esibire, sviscerare, aprire i dispositivi, che nell’immaginare nuove figurazioni del vivere collettivo; e lo sguardo critico, in questo modo, finisce per assumere il piglio indagatore di una lezione di anatomia dove il corpo sotto scrutinio non è però più salvabile. È così che invitiamo i lettori e le lettrici ad affrontare la lettura del libro come prima parte di un lavoro su una filosofia della migrazione che indaga tutta la povertà immaginativa cui una certa idea della politica ci ha lungamente costretto. Una volta chiuso il libro, però, lettori e lettrici sentiranno come l’orizzonte di senso cui la migrazione apre resta ancora tutto da inventare, scrivere e praticare.