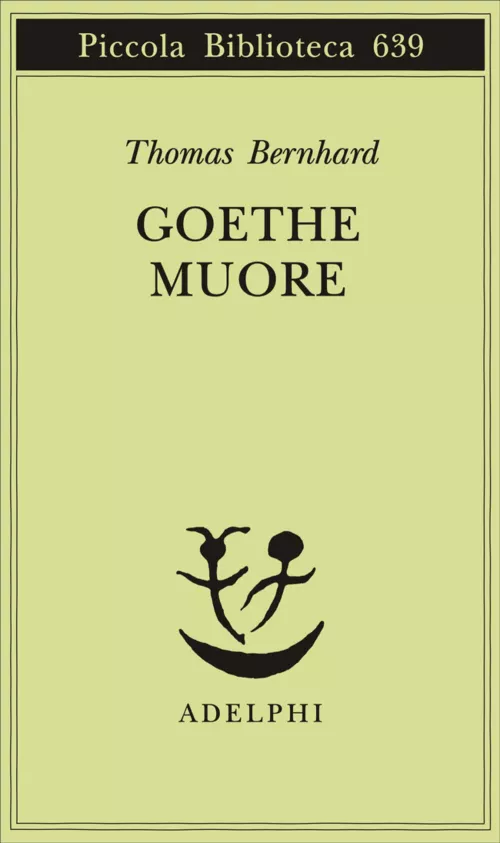Thomas Bernhard. Goethe muore
In fin dei conti perché piace Bernhard? Perché non annoia mai a dispetto delle somiglianze dei temi e una continuità che sfiora l’uniformità nel modo di narrare? Perché è implacabile. Feroce e insieme divertente. Una volta individuata la preda, la pedina, la insegue, la accerchia, la scruta da ogni angolo e nelle più diverse occorrenze, ne esamina ogni possibile effetto e soprattutto ogni causa fino a quando ha individuato la scaturigine, che a sua volta subisce lo stesso trattamento; e poi la agguanta, se ne trastulla tra le grinfie come un gatto, e infine la morde, la mastica lentamente, rigira in bocca il bolo per succhiarne ogni sostanza, e poi lo sputa, disgustato.
La preda appartiene a poche specie, imparentate tra di loro tanto da risultare spesso indistinguibili, il metodo è ricorrente, gli ambienti e i personaggi molto simili, eppure, una volta entrati nel gioco, non si riesce più a staccarsene fino a che non si è esalato, con l’ultima parola, l’ultimo respiro (che è anche il titolo di un suo libro autobiografico). Uso la parola apposta. Il respiro, il ritmo della respirazione guidato dalla sintassi, nella prosa di Bernhard, è tutto.
Io che ho sempre creduto che il pensiero non è distinguibile non solo dal linguaggio in generale, ma anche e soprattutto dalla sintassi, dal suo ritmo, dalle cesure e dalle differenti sorte di legami che istituisce, cosa posso dire di libri come quelli di Bernhard che dalla sintassi derivano gran parte della loro forza eppure mantengono il loro fascino (non so quanto intatto) nel passaggio dal tedesco (che ignoro) all’italiano? Mi devo ricredere? Devo pensare che sia tutto merito dei traduttori, che peraltro mi sembrano quasi sempre bravissimi, o sono invece le articolazioni della sintassi nella loro autonomia transnazionale, le loro strutture profonde (per dirla con Chomsky), che in qualche modo, al di là delle differenze anche speciose come quelle tra l’italiano e il tedesco, continuano ad agire producendo effetti analoghi? C’è qualcosa, nell’avvolgersi e diramarsi e dispiegarsi e interrompersi del discorso che ogni volta riprende e si rilancia, che sta agendo in modo del tutto indipendente da ogni cosa che venga scritta e detta (meglio: relativamente indipendente) e che la sintassi permette e veicola, ma non esaurisce? Quanto è simile il Bernhard in tedesco a quelli in italiano e in francese che ho potuto leggere e che tanto tra loro si assomigliano, ben oltre la loro parentela di lingue romanze? Mi viene come l’idea che ogni volta che la sintassi si distende, in qualsiasi lingua, scattino nel respiro del lettore, nelle scansioni della sua mente e nelle tensioni della sua attenzione, analoghe forme di adesione e di abbandono al flusso della lettura: come se tutti si respirasse all’unisono, o con ritmi e pause diverse ma che si armonizzano in una polifonia unitaria, in un canto composito che da lontano suona come un’unica melodia.
Nel grande scrittore austriaco il martellamento di una tematica abbastanza uniforme, la presenza di personaggi simili (tutta gente con un’ossessione) e l’assenza di un’azione vera e propria invece di nuocere favoriscono questi meccanismi. Non che argomenti e storie siano indifferenti: è proprio l’importanza dei soli attorno a cui gravitano o dei buchi neri al cui margine vorticano sempre più veloci prima di esserne inghiottiti, a rendere simili figure per altri aspetti assolutamente uniche. Il repertorio è quello, una costellazione di poche stelle, la cui immagine però si dà a vedere in modo sempre diverso a seconda delle angolature adottate.
Nei quattro racconti di Goethe muore c’è tutto il repertorio maggiore: l’esempio annichilente della perfezione (qui in Goethe, consapevole di se stessa e del proprio potere paralizzante, ma posta di fronte in una contemporaneità trans-storica, che è poi quella della cultura, all’unico successore che il totem della cultura tedesca ritiene alla propria altezza e che anzi crede che chiuderà, e forse seppellirà, la sua epoca, Wittgenstein, che egli desidera ardentemente quanto inutilmente incontrare perché muore senza riuscirci, e senza sapere che il filosofo viennese è già morto, prima di lui); i progetti impossibili mai portati a termine; le opere distrutte senza essere divulgate perché mancano sempre, magari di un soffio, l’assoluto e il complementare fallimento anche nel successo (perché al fallimento non si sfugge); l’odio generazionale: la crudeltà dei “genitori annientatori” nei confronti dei figli, e il rancore, e l’amore, di questi nei loro confronti: nei confronti dei padri, carnali e spirituali, e della patria. “I genitori si permettono il lusso di fare figli e poi li uccidono. Ogni coppia ha metodi diversissimi, quelli che meglio le si confanno.” E “noi diciamo pure di amare i nostri genitori, e in realtà li odiamo, perché non possiamo amare i nostri procreatori non essendo noi persone felici, la nostra infelicità non è immaginaria come lo è invece la nostra felicità, di cui ogni giorno cerchiamo di convincerci per trovare il coraggio di alzarci e lavarci, vestirci, bere il primo sorso, mandar giù il primo boccone.”
I salti logici, narrativi e temporali sono accettati dal lettore senza batter ciglio, anzi, il più delle volte non sono nemmeno avvertiti, come avviene del resto con la ripresa (di solito ogni due-tre pagine, ma in certe circostanze anche ogni diecio più) di una o poche espressioni che riportano al decorso narrativo soggiacente, o all’identità della voce narrante, perché tutto viene convogliato e trasportato, e direi quasi travolto dal flusso del discorso, ridotto a elemento che nulla distingue, quanto meno gerarchicamente, da ogni altro, e che al massimo emette una lucina di segnalazione subito spentao risucchiata dal veloce allontanamento, ovveroche sporge per un attimo il capo sulla superficie dell’acquasenza che al lettore-Münchausen, lui stesso trascinato dalla corrente, sia possibile sottrarsene, tirandosi fuori da solo per i capelli, o per la cuticagna (per i calvi: questione di giustizia).
Come se il discorso non avesse origine né fine, e alla lungale identità di destinatario e narratore si sovrapponessero in un unico flusso impersonale, un mormorio senza tempo che contiene nella sua unica voce tutte le voci: che espone tutte le versioni, assume su di sé tutte le parti in conflitto e tiene tutti i fili in un monologo che si avvolge su se stesso, da nessuna parte provenientee a nessuno rivoltoanche quando sembra direttoa qualcuno di preciso, un interlocutore che sembra lì davantima è sempre assente, o proiettato nel passato, cioè ancora all’interno del discorso (come il lettore che viene ad occupare di volta in volta il posto vuoto del destinatario).
Discorsi riportati all’interno di altri discorsi a loro volta citati in altri ancora (“avrebbe detto Goethe… così Riemer, al che Eckermann”), il cui autore o locutore (spesso inattendibile) viene periodicamente richiamato (rinominato) non solo per chiarirne l’identità, per ricondurre ciò che viene riportato alla responsabilità di colui che per primo l’avrebbe detto (senza che ci sia modo peraltro di stabilire la veridicità dell’asserzione, così come la correttezza della citazione del resto), ma soprattutto per scandire il ritmo del monologo all’apparenza dominante, come i riferimenti all’interlocutore (destinatorio-ascoltatore-lettore) o la frammentazione,ripresa un attimo prima dell’ultima interruzione dell’azione narrativa principale (soggiacente, e in fondo spesso indifferente: l’ingresso nella locanda e i pochissimi movimenti al suo interno in Il soccombente, per esempio).
Tutte le voci (la stessa voce che si rifrange in tanti personaggi) girano, scavano, costruiscono, abbattono, si allontanano e si riaccostano, fuggono e attraversano lo stesso nucleo, fatto di quei pochissimi elementi essenziali che si intrecciano, combinano e modificano in tutti i modi e in tutte le direzioni spazio-temporali, ma restano in fondo elementari, tanto che apparirebbero quanto mai insoddisfacenti e banali in qualsiasi forma venissero direttamente definiti. Vecchi tarli di esistenziali e metafisici. L’epitome del risaputo. E dell’inutile. Per cui ci esimeremo dal farlo noi.
Nell’esasperazione di questa tensione e di questi movimenti, che non può che essere totale, data la radicalità dei loro obiettivi (finalità) e il rifiuto di qualsiasi compensazione o consolazione sentimentale o trascendente, tutto e tutti diventano grotteschi: che è l’unica forma che sembra poter assumere, alla fine, il loro fondo tragico una volta passato al setaccio della lucidità. Di una lucidità assoluta, e quindi implacabile. Tanto da rivolgersi agli stessi assunti da cui aveva preso le mosse, alle certezze basilari che l’avevano chiamata in causa e resa necessaria.
A furia di applicarli e di metterli alla prova dei più diversi contesti, o anche solo di martellarli in ripetizioni a prima vista identiche fino allo “sfinimento cosmico”, ognuno di questi postulati, persino le evidenze più incontrovertibili, le affermazioni più apodittiche, i giudizi più perentori e le deduzioni e conclusioni più solide, perdono di peso, si smaterializzano, e si contraddicono e demoliscono da soli. Cioè diventano, appunto, grotteschi.
Dell’intransigenza resta la tensione feroce e vuota, la pura pretesa, alla fine innocua. Risibile per tutti, eccetto per chi ne soffre fino ad esserne distrutto.
La comicità di Bernhard è un effetto diretto della sua cupa intransigenza. Alcuni dei grandi scrittori del ‘900 nei quali la componente comica è molto rilevante (Kafka, Gadda, Beckett...) si muovevano sul filo della disperazione, o del disincanto, senza compromessi di sorta; ma grandi comici lo sono stati solo perché grandi scrittori. Tutti, senza eccezione, come si diceva una volta, stilisti intransigenti, implacabili. Gli altri, come tanti personaggi di Bernhard (mi spiace per loro: mi spiace per noi), fanno solo ridere.
Thomas Bernhard, Goethe muore, trad. it. di Elisabetta Dell’Anna Ciancia, ed. Adelphi, 2013, p. 110, E. 11.