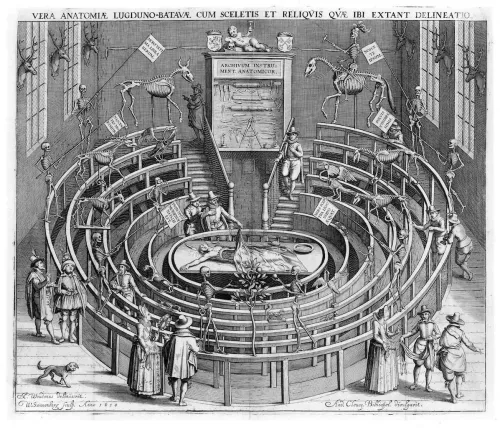In scena / Umani, vegetali, bestie, dèi alla ricerca del teatro
Ammettendo che sappiamo che cosa il teatro sia e che valga la pena di essere cercato (ma siamo ancora ben lungi dall’averlo dimostrato), viene comunque sollevata una domanda fondamentale. Quali esseri riescono a percepirlo e desiderano trovarlo/evocarlo? È forse il teatro un’arte «umana, troppo umana», ossia che è disponibile solo per noi? Oppure questa è una prospettiva troppo antropocentrica e, dunque, forse anche piante, animali, dèi (se esistono / fanno qualcosa) possono e vogliono avere esperienze teatrali? Detto in termini più generali e astratti: tutti i viventi hanno la capacità di entrare in relazione col teatro, oppure questa è una prerogativa esclusiva della nostra specie?
Cercare di dare una risposta anche sommaria a queste domande è di fatto impossibile, nello spazio di un breve articolo. La questione è resa poi più complicata dal fatto che, quando parliamo della nostra esperienza del teatro, facciamo spesso uso di espressioni che attingono al mondo animale, vegetale, divino. Di un apprezzabile attore o un’apprezzabile attrice diciamo, ad esempio, che è un «animale da palcoscenico». Se vogliamo riconoscere che l’artista ha fatto qualcosa di davvero buono, affermiamo che egli o ella “è sbocciato/a” o è “maturato/a”, quasi fosse un fiore che schiude finalmente, nella primavera della sua vita artistica, il suo frutto più succulento. (Alzando un po’ il livello, potremmo ricordare anche il «fiore meraviglioso», supremo grado della maestria dell’attore del teatro Nō secondo Zeami, e l’«albero di elettricità pura», teorizzato da Artaud in Per farla finita con il giudizio di dio). E infine, quando vogliamo parlare di interpreti eccezionali, li qualifichiamo come “divini”. Sembra, insomma, che chi raggiunge i vertici dell’arte del teatro diventa un essere disumano, dunque – forse – che noi umani diventiamo “teatrali” se ci trasformiamo in bestie, piante, dèi. Questo ragionamento implica, a sua volta, che solo queste tre specie viventi risultano capaci di avvertire la teatralità. Noi umani riusciamo a cogliere il teatro, infatti, laddove ci spogliamo della nostra povera umanità.

Bruegel, Paesaggio.
Si capisce, insomma, che la problematica è immensa e che risposte troppo nette rischiano di semplificarla troppo. In questa sede, vorrei affrontarla entrando in dialogo con due artisti che, più o meno direttamente, ne hanno fatto oggetto della loro ricerca e di cui ho avuto modo di vedere i più recenti lavori, all’interno dell’XI edizione del festival Nottenera (2017). Il primo è Rita Frongia con il suo Umanescenza: un incontro pubblico sull’«arte imperfetta della drammaturgia». L’altro è Andrea Fazzini e la compagnia Teatro Rebis da lui diretta, che mettono in scena da qualche tempo lo spettacolo Il papà di Dio, tratto dall’omonimo romanzo a fumetti di maicol&mirco. Le loro prospettive possono aiutare a mettere meglio a fuoco una serie di problemi sull’identità dei cercatori di teatro e di argomenti a favore o contro i suoi potenziali candidati. Mentre le mie modeste e provvisorie osservazioni costituiranno un omaggio al loro grande lavoro artistico, così come un modo di acquisire maggiore consapevolezza su una questione che, per me almeno, risulta essere oscura e difficile.
Il teatro segreto di piante e animali
Umanescenza di Frongia è un neologismo leggero e spiritoso, come la buona arte, ma anche dall’intento programmatico. Esaminato alla luce della questione da cui siamo partiti, esso suggerisce che il teatro sia un’attività del tutto umana. L’«umanescenza» rappresenta, infatti, il fine che drammaturghi e attori tentano di raggiungere. Si tratta dello «sprofondamento» negli abissi dell’umano, alla ricerca di tutti quei lati ancora ignoti della nostra personalità e della nostra essenza, che non emergono dalle azioni quotidiane che pratichiamo spesso per abitudine irriflessa. Se volessimo insomma provare a distinguere il concetto di “umanità” da quello più bello e sfidante di “umanescenza”, potremmo dire che l’uno raccoglie in una parola tutte quelle proprietà del nostro essere che già conosciamo (per esempio, che siamo mortali, dotati di parola e ragione, animati da determinate bisogni e desideri, ecc.), l’altro denota un’utopia, ossia la ricerca (spesso fallimentare) di ciò che risultava finora ignoto e inatteso, dunque che destabilizza le nostre certezze e ci induce a reinterpretarci di nuovo da zero, utilizzando le nuove conoscenze acquisite. Non esiste così teatro “umanistico”, dato che umanistica è appunto la vocazione a comprendere meglio quel che già sappiamo su noi stessi. Esso è piuttosto un’arte “umanescistica”, che brama – per citare il Woyzeck di Büchner – l’abisso in cui uomini e donne si perdono se lo fissano troppo intensamente.

Umanescenza.
Non è allora un caso che, entro tale prospettiva, l’incontro di Frongia sull’arte imperfetta della drammaturgia si confronti saltuariamente con il regno animale e vegetale, cercando di argomentare perché il teatro sia un nostro specifico. L’artista apre il suo discorso con un esempio, cioè un confronto con il ritmo mostrato dalle piantine di pomodoro, che attua un continuo cambio di direzione e di tempo. Se noi acceleriamo con un filmato il processo di crescita di queste piante, noteremo subito che esse sembrano svolgere una danza, che in genere sfugge alla nostra percezione, in quanto i movimenti più piccoli che compongono il moto di accrescimento complessivo non sono capaci di agire sui nostri organi di senso. Eppure, sostiene Frongia, queste piantine di pomodoro non danzano. I movimenti che esse attuano durante la loro crescita sono infatti utili, ripetibili e prevedibili, pertanto non sono assimilabili al teatro che drammaturghi e attori umani cercano di evocare per scoprire ciò che nella nostra personalità o essenza è volutamente inutile, irripetibile, inattesa, ignota. O almeno, se si può dire che le piantine danzano, dobbiamo riconoscere che siamo noi ad attribuire loro una danza, di cui esse non sono consapevoli. Secondo la teorizzazione famosa elaborata da Wilde ne Il critico come artista che Frongia riprende esplicitamente, la natura tende senza saperlo a farsi opera d’arte. Ma anche in questo caso, il tramite resta pur sempre l’umano. In assenza di uomini e donne che guardano con gioia o tristezza i movimenti delle piantine, queste non potrebbero danzare, e il loro moto non esprimerebbe qualità estetiche.
Se in negativo le piante sono escluse dall’ambito del teatro, o tutt’al più ricomprese al suo interno con il tramite dell’immaginazione umana, Frongia sembra essere in apparenza più aperta sul versante del regno animale. Il suo discorso accenna, infatti, a un paragone dell’attore con una «capretta ansiosa di precipizi», che è una versione più raffinata e in linea con la sua prospettiva “umanescistica” di uno dei modi di parlare ricordati all’inizio (= l’«animale da palcoscenico»). Potremmo dire che l’artista della scena manifesta, nella sua ricerca di «umanescenza», la stessa leggerezza che il cucciolo di capra mostra nel suo giocare tra le montagne, cercando i recessi profondi delle vallate montane che ancora non ha esplorato. Si tratta certo di una suggestione, che Frongia non sviluppa né riprende più oltre, il che è segno che non le riconosce eccessiva importanza. E benché gli argomenti e silentio siano sempre pericolosi, il fatto che l’artista non usi altri confronti con il mondo animale e non dica chiaramente che le bestie cercano il teatro costituisce un ulteriore indizio della sua convinzione che l’arte teatrale è prerogativa umana, tutta umana. Nemmeno la capretta, insomma, danza il teatro. O se lo danza, lo fa – di nuovo – perché siamo noi a riconoscerle con l’immaginazione questa attività.
La prospettiva presentata in Umanescenza di Frongia è commovente e profonda. Alcune delle cose dette potrebbero peraltro essere approfondite ancora di più, per dimostrarne la verità e arricchirne il significato. La distinzione ipotetica tra “umanità” e “umanescenza” potrebbe essere ricollegata, ad esempio, a quella tra “spettacolo” e “teatro” di Claudio Morganti. “Umanità” fa paio con “spettacolo”, perché entrambi trattengono attori e spettatori nel campo del già conosciuto. “Teatro” è invece parente di “umanescenza”, dato che ci porta un pochino fuori da questo territorio, grazie alla generosità e al coraggio degli artisti. Nello stesso tempo, però, non sarei così precipitoso nel negare con troppa forza che il teatro sia prerogativa unicamente umana, che porta con sé l’ulteriore tesi che esso e la danza siano cose innaturali, cioè non riscontrabili in natura. Proverò a sostenerlo, seguendo entrambe le ipotesi prospettate da Frongia.
Se vogliamo dire che le piantine e le caprette non danzano affatto, ovvero non cercano teatro, allora dobbiamo anche negare alla radice che esse non manifestano davvero quei movimenti consapevolmente inutili, irripetibili e inattesi che sono invece attuati dagli attori umani. Tuttavia, credo che tali moti siano rintracciabili, in realtà, nei regni animali e vegetali. Senza arrivare a derive irrazionalistiche e spiritualiste, come quelle prospettate ne La vita segreta delle piante di Tompkins e Bird, potremmo tentare di dire che le piantine di pomodoro che hanno raggiunto il massimo della loro cresciuta possono attuare dei micro-movimenti senza scopo. Il loro semplice stare e oscillare sul posto – per usare un caso facilmente controllabile da tutti – non mostra a tal riguardo alcuna tendenza utile a una produttiva preservazione della propria natura, né era in sé prevedibile e atteso. Questa oscillazione poteva anche non accadere, ma è accaduta . Sia pure in termini molto minimali, allora anche le piante sono artefici involontari di teatro, sia pure certo diverso da quello umano, che è volontario e orientato a destare una data reazione nel suo pubblico.
Quando poniamo attenzione all’inutile stare e oscillare dei pomodori, infatti, sprofondiamo in quella che potremmo chiamare “piantescenza”: la comprensione di un mistero che questo vegetale qui gode del suo micro-movimento senza fini. Analogo discorso potrebbe valere anche per il caso degli animali, che pure è complicato dal fatto che questi hanno facoltà superiori rispetto alle piante. La capretta che gioca per il puro piacere di conoscere una zona al di fuori del suo territorio è una condotta altrettanto inutile di quella dell’attore che vuole conoscere meglio se stesso. In bestie più evolute, come certi primati e volatili, possiamo persino constatare che essi imitano le nostre voci, o versi e movimenti di altri esseri animati, o fenomeni naturali come la pioggia, a volte anche al cospetto di un pubblico umano, forse persino per il desiderio gratuito di entrare in relazione con noi (si pensi al pappagallino che ripete il nostro nome, imitando il nostro linguaggio). Persino negli animali si potrebbe così parlare di “animalescenza”, poiché guardando i loro comportamenti inutili sprofondiamo in qualcosa che prima non ci era noto e che non ci aspettavamo da loro.

Alberto Giacometti, Cane.
Se di contro seguiamo l’ipotesi che le piantine e le caprette danzano, nel senso che siamo noi ad attribuire loro questo comportamento, in un certo senso ciò che Frongia stessa dice per negare a questi due enti il contatto con il teatro può essere ricalibrato nella direzione contraria. La tesi è, all’osso, che noi non riconosceremmo a questi viventi delle capacità danzanti, se non facessero dei movimenti che in se stessi assomigliano a quello che noi chiamiamo “danza”. Nessuno potrebbe sostenere, ad esempio, che un frigorifero o una scopa che stanno immobili nella stanza danzano, anche facendo uno sforzo immaginifico inaudito. (L’obiezione che un artista potrebbe far danzare questi oggetti, facendoli muovere in modi particolari nello spazio e nel tempo, non è cogente.
Poiché qui non parliamo della danza che il frigorifero e la scopa attuano per loro stessa virtù, ma di una impressa a questi due enti inanimati da un agente umano). In altri termini, l’attribuire un comportamento danzante a un animale e a una pianta dipende dal fatto che constatiamo in loro almeno qualcosa di simile alla danza – una “quasi-danza”, appunto. Altrimenti, l’attribuzione stessa risulterebbe impossibile. Questa premessa rende plausibile l’ipotesi che animali e piante potrebbero contribuire con i loro movimenti a una drammaturgia dell’inatteso, dunque alla ricerca teatrale. Noi umani che parliamo della danza di questi viventi entriamo in relazione con loro, e questi viventi – facendoci dono della loro danza o “quasi-danza” – ci mettono nelle condizioni di comprendere lati nascosti della loro natura, così come anche di noi stessi. Studiandoli, infatti, forse comprendiamo che tra animali, piante, uomini e donne non c’è tutta questa differenza, il che era un aspetto del nostro sé che prima risultava ignoto.
Vi sono così indizi – molto dubbi e controversi, a dir la verità – sull’ipotesi che esista anche “teatro segreto” nelle piante e negli animali, ovviamente molto diverso dal nostro. Magari anche più primitivo e sempliciotto, ma comunque di teatro. I cercatori teatrali potrebbero consistere, così, anche in agenti diversi da quelli umani, il che ridimensiona parecchio i nostri preconcetti di carattere antropocentrico.
Teatrali teologie
Vi è un grande assente nella prospettiva di Umanescenza: la divinità. Gli dèi sono morti nello sguardo di Frongia, semplicemente perché l’artista non ne ha bisogno per portare avanti il suo discorso bello e coerente. Da questo punto di vista, Il papà di Dio di maicol&mirco e Teatro Rebis costituisce una sorta di involontaria prosecuzione e integrazione del discorso di Umanescenza. Esso tematizza, del resto, tra le varie altre cose, il rapporto possibile di uno o più divinità con il teatro.
Il papà di Dio costruisce un’interessante e ironica ipotesi teologica. Vi è una precisa gerarchia divina che regola l’andamento del cosmo. All’apice troviamo il “papà-di-dio” dotato di perfezione assoluta e capace, pertanto, di produrre enti altrettanto perfetti. Per esempio, mondi in cui non ha luogo la morte e la fame, o viventi che a loro volta non patiscono queste due specie di corruzione. Satellite di questa divinità suprema è lo “zio-di-dio”, che di contro decide di rinunciare alla fatica della creazione per vivere ozioso, a cantare e ballare nell’universo con la sua chitarra, in una piacevole sterilità creativa. E infine, troviamo “dio” stesso: un figlio dal quoziente intellettivo sotto la norma, innocente, volenteroso e insicuro. Al contrario di suo zio, egli non si accontenta di divertirsi e perdere tempo, ma diversamente dal padre decide di creare enti senza aver studiato (ossia, senza aver appreso l’arte della cosmogonia nella sua perfezione), sicché produce dalla sua imperfezione solo mondi e individui imperfetti, che soffrono la morte e la fame e altri fenomeni di corruzione. Il dio è così l’origine prima del male. Non a caso, egli ha anche Satana quale suo doppio, che manifesta tutte le caratteristiche contrarie. Se dio è un maschio, un po’ tonto e arso da dubbi, il diavolo è una femmina, intelligentissima e sicura del suo agire.

Teatro Rebis, Il papà di Dio.
Ciascuna di queste entità divine si caratterizza, poi, per l’esercizio di una disciplina peculiare. Il “papà-di-dio” è padrone dell’architettura. Egli parte da un progetto chiaro, preciso, ripetibile di “mondo” e di “individuo”, pertanto non può mai fallire nel suo proposito. I suoi risultati saranno sempre impeccabili ed eccellenti. Lo “zio-di-dio” può forse essere detto il detentore della musica e della danza leggere o disimpegnate. Egli è un artista del piacere: sa come prolungare il godimento ed escludere ogni dolore, senza creare né distruggere qualcosa di altro da sé. Infine, dio e Satana praticano invece il teatro. Se del resto è solo nel nostro mondo imperfetto dominato dalla morte e dal dolore che l’arte teatrale trova spazio o senso, perché essa tenta in fondo di scongiurare la nostra paura di morire e le nostre sofferenze, allora solo divinità imperfette possono essere in un qualche modo all’origine di tale arte. Vi è di più, solo dio e Satana (e non il papa-di-dio, né lo zio-di-dio) risultano essere potenziali cercatori di teatro, intanto come registi del nostro cosmo, volendo anche come suoi attori. E se è così, anche loro provano a conoscere i lati più profondi della loro natura o essenza, andando oltre quanto già conoscono e tentando di creare qualcosa di diverso/innovativo. Come noi umani pratichiamo la «umanescenza», così dèi del genere praticano una sorta di “diviniscenza”.

Giorgio De Chirico, Visioni urbane.
Tale prospettiva porta con sé degli intelligenti paradossi, che mette in cortocircuito la gerarchia divina e fa cadere nel caos l’ordine apparente del cosmo. Partiamo, infatti, dalla premessa forse non controversa che è gesto migliore e più perfetto lo scoprire ogni volta qualcosa di nuovo, originale, inaspettato, invece di restare nella sicurezza del territorio già noto. Se applichiamo tale principio alla prospettiva teologica de Il papà di Dio, tutte le qualifiche che abbiamo usato finora vengono rovesciate. La perfezione del “papà-di-dio” risulterà essere, in realtà, una forma di imperfezione. Tale divinità si adagia su quanto conosce già e, alle lunghe, si annoia della sua glaciale eccellenza, desiderando produrre qualcosa di imperfetto. Una prova ulteriore è che, dalla sostanza solo in apparenza perfetta del papà-di-dio, è stato emanato un figlio imperfetto. Di contro, l’imperfezione di dio e di Satana costituisce una forma di perfezione. Giacché tali dèi tendono, al contrario, a un costante miglioramento di sé e si sottopongono sempre a sfide che li rendono più edotti delle proprie capacità nascoste, del potere inesauribile della loro immaginazione. E sebbene falliscano nell’ottenere risultati soddisfacenti, essi falliscono bene, falliscono ancora meglio, falliscono con crescita esponenziale, fino a far del loro atroce fallimento un capolavoro assoluto di bellezza.
Secondo maicol&mirco e Teatro Rebis, insomma, cercatori di teatro sono anche gli dèi, ma non tutti gli dèi. Sono tali solo le divinità imperfette che aspirano alla perfezione, non quelle perfette che col tempo crollano nell’imperfezione. In questo senso, gli attori e i registi del nostro mondo si assimilano al divino, quando coltivano con amore l’arte teatrale. La loro attività imperfetta costituisce, a sua volta, la pratica più importante o autentica che diventa accessibile a un essere umano.
Al pari di Umanescenza, anche Il papà di Dio solleva questioni acute e interessanti, su cui varrebbe la pena ragionare ancora lungo. Il limite intrinseco di questo spettacolo è, tuttavia, che basta mutare teologia per mettere in dubbio di nuovo dalle fondamenta tutte le idee espresse al suo interno. Al contrario che per gli animali e per le piante, i nostri discorsi sulla condotta estetica degli dèi non possono essere confermati empiricamente. Possiamo solo fidarci di ipotesi, racconti poetici, pure fantasticherie, ciascuna delle quali non ha però forza sufficiente per risultare più vera delle rivali. La mia sensibilità mi porta, ad esempio, a scommettere di più sulla plausibilità del modello teologico rappresentato dallo zio-di-dio. L’idea di una divinità che non è responsabile del bene e del male, non è né perfetta né imperfetta, che non fa nulla o che – se fa qualcosa – fa cose da cui ricava il suo privato godimento, mi risulta più logica e coerente di altre ipotesi. Se gli dèi ci sono, sono forse caratterizzati da impotenza assoluta, sicché non praticano nemmeno il teatro. Di tali divinità si può dire solo che stanno bene e sono estranee a ogni cosa. Il resto non si confà con la loro natura del tutto autosufficiente, indissolubile e beata.
Cercatori di teatro potrebbero così essere gli umani e forse gli animali / le piante, ma forse non gli esseri divini. Tuttavia, basta mutare teologia per ricomprendere in questo gruppo anche certe divinità, dotati di fragilità e desiderio di bellezza. Quale sia la prospettiva teologica corretta, forse davvero solo un dio può saperlo.
Dubbi, ancora, come conclusione
Sulla base di quanto sostenuto finora, come dovremmo rispondere al problema dell’identità del cercare di teatro? Ha forse ragione Frongia, a pensare che solo gli umani lo conoscono e lo desiderano? Può essere che siano nel giusto maicol&mirco Teatro Rebis, nel suppore che anche dio è un povero attore / regista scapestrato e inquieto, che crea il mondo con la sua storia per conoscersi e mettersi alla prova? O è sulla buona via il sottoscritto che, nel dialogo con questi due splendidi artisti, ha cercato una prospettiva più “ecumenica”, supponendo che uno degli aspetti che unisce o accomuna ogni vivente (divino escluso) è proprio la ricerca collettiva del teatro? Sinceramente, dato che tutte le tre concezioni appaiono ugualmente plausibili (o, a seconda del punto di vista, ugualmente difettose), la sospensione del giudizio sembra essere il modo più saggio per mettere da parte la controversia, in attesa di indagini più approfondite. Potremmo però forse constatare due risultati positivi sul piano metodologico.

Henri Matisse, Snow Flowers.
Il primo è che, nel discutere dell’identità del cercatore di teatro, occorre stare attenti a distinguere bene ciò che è l’esito di una nostra tendenza ad attribuire un comportamento “teatrale” a piante o animali o dèi da ciò che, forse, rappresenta una forma di teatro o danza diversa dalla nostra. Potrebbe essere tanto vero, infatti, che siamo sempre noi umani a descrivere la condotta di queste tre specie viventi, attingendo alla nostra psicologia e ai nostri concetti estetici, quanto che esse sono effettivamente capaci di fare arte, o una “quasi-arte”. Per non fermarsi alle impressioni del primo momento, si deve così cercare di individuare dei criteri che ci permettano di operare la distinzione tra ciò che diciamo o attribuiamo e ciò che appartiene davvero loro, tra ciò che è soggettivo e ciò che è oggettivo.
Il secondo risultato metodologico consiste, per converso, nella constatazione che bisogna essere altrettanto vigili nel reprimere la tentazione di porci al di sopra di tutti gli altri viventi, dicendo che siamo i soli ad apprezzare e amare il teatro. Sappiamo ancora troppo poco degli animali, delle piante e degli dèi (nel caso di questi ultimi, ancora non sappiamo se esistono e se sono o il fondamento di tutto, o distanti e indifferenti da tutto) per poter sia negare che affermare recisamente con sicurezza che essi non hanno un istinto estetico. Ad affrontare bene la questione, si dovrebbe essere al tempo stesso esperti almeno di botanica, etologia, teologia, drammaturgia e psicologia. Il fatto che nessun individuo o gruppo di studio domini un complesso così variegato di discipline dimostra che siamo ancora all’inizio della ricerca.
Di più non è possibile al momento sostenere. Nel frattempo, ci contentiamo della soddisfazione di aver indagato e riflettuto insieme.
[Post-scriptum: “dio” e “dèi” sono scritti consapevolmente in minuscolo, perché ne parlo come di entità astratte e non personali. La maiuscola vale, infatti, laddove si considera la divinità come una persona e la parola “Dio” come un nome proprio. Per altre ragioni sul perché vale la pena di parlare di dèi con la minuscola, rimando di nuovo a Per farla finita con il giudizio di dio di Artaud. L’unica eccezione è l’uso della maiuscola nel titolo Il papà di Dio, perché questa è stata la scelta linguistica di maicol&mirco prima, di Teatro Rebis poi].