Storia e geografia di realtà interiori / Un atlante delle emozioni
La vaporosa malinconia lasciata dalla partenza di un ospite gradito. La commozione nel veder trionfare chi parte svantaggiato. La nostalgia per un luogo in cui non si è mai stati. Ognuno e ognuna di noi probabilmente ha provato almeno una volta uno di questi stati d’animo. E magari ha fatto fatica a descriverli e a nominarli, ha pensato che non fossero condivisibili, ha tentato di scuotersi di dosso queste strane sensazioni. Non sapendo che invece queste emozioni esistono: sono culturalmente riconosciute, hanno dei nomi, una storia e una geografia. La tribù baining che vive sulle montagne della Papua Nuova Guinea chiama awumbuk la malinconia lasciata dalla partenza di un amico che si è ospitato, e dispone ciotole d’acqua negli angoli della casa per assorbire la foschia che l’ospite lascia dietro di sé. L’empatia verso un outsider, l’eccitazione per la vittoria di chi è destinato alla sconfitta, in Giappone si chiama ijirashi. Il finlandese definisce kaukokaipuu il desiderio di essere in un luogo lontano, diverso da quello in cui siamo e in cui forse non saremo mai.
L’esistenza di queste parole testimonia che in alcuni luoghi, per effetto di particolari configurazioni sociali, la materia impalpabile e le sfumature impercettibili di cui sono fatte le emozioni si sono condensate in modo da dare luogo a dei concetti, a delle realtà interiori riconoscibili, che hanno richiesto la legittimazione di un nome. A guidarci in queste e in molte altre scoperte di geografia emotiva è l’Atlante delle emozioni umane compilato da Tiffani Watt Smith, recentemente pubblicato da Utet nella traduzione di Violetta Bellocchio. Sottotitolo: 156 emozioni che hai provato, che non sai di aver provato, che non proverai mai.
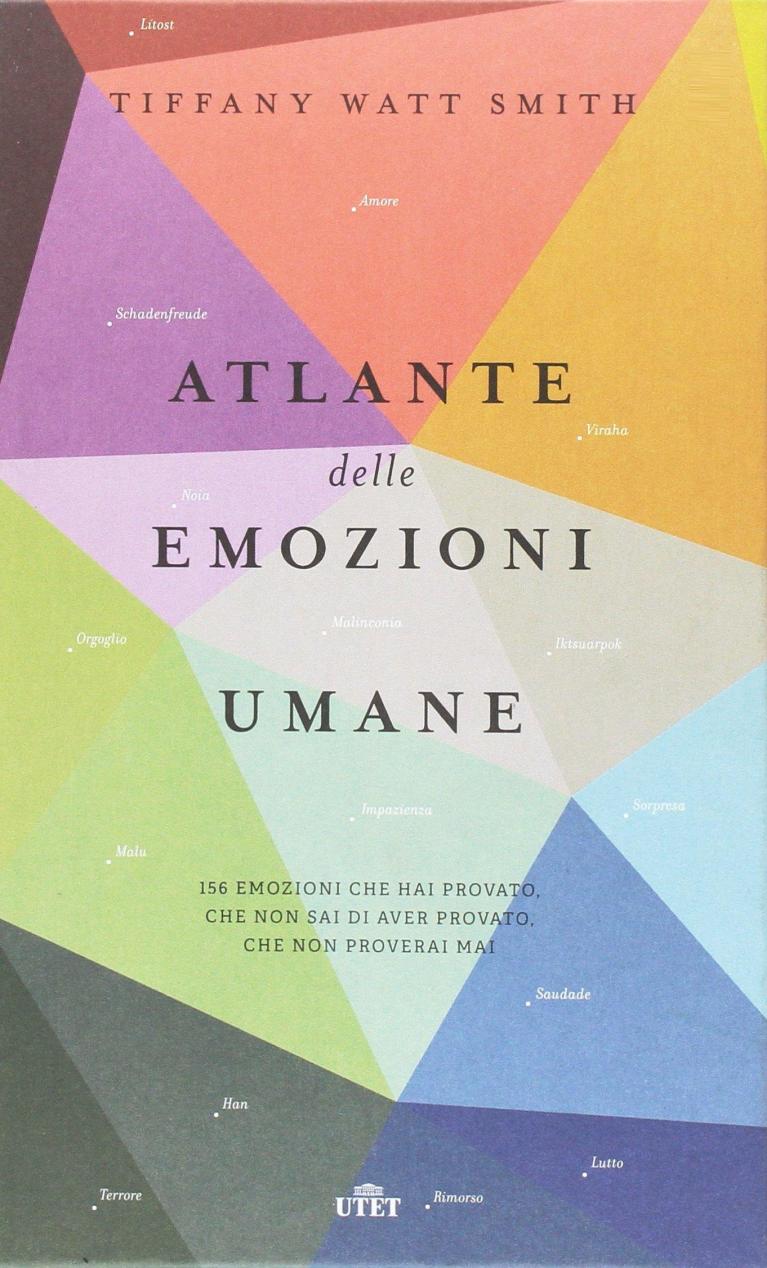
Un atlante delle emozioni potrebbe sembrare un libro quasi inevitabile oggi, coerente con l’epoca forse più emotivamente satura della storia, e necessario alla sua decifrazione. Enormi correnti emotive attraversano la vita pubblica e politica, reazioni emoticoniche determinano le interazioni sociali, un costante overload emotivo alimenta, quasi come una droga, l’immaginario mediatico, dalle sceneggiature dei talent show a quelle di Hollywood, dalle emozioni forti della narrativa seriale a quelle pruriginose del gossip. Perfino il discorso scientifico, per tacere delle pseudoscienze, ha scoperto le emozioni: lo studio del cervello ha permesso di situare i processi biologici che sottendono alle emozioni, e di mostrare che la vita emotiva è fortemente connessa ai processi cognitivi “superiori”, che la razionalità è venata di emotività, che il cuore ha delle ragioni che la ragione spesso sta ad ascoltare.
E mentre il diluvio emotivo sembra forzare le strutture stesse del pensiero e la sua agibilità sociale, travolgendo con drammatiche accelerazioni il tempo lento della logica e dell’argomentazione, c’è chi tenta di organizzare una resistenza, segnalando la necessità di arginare la prossimità emotiva rispetto ai fenomeni, per ristabilire la distanza critica necessaria alla comprensione. Paul Bloom, ricercatore a Yale, ha scritto un libro intitolato Against Empathy, contro l’empatia, tentando di decostruire il mito della più “positiva” delle emozioni. L’empatia, come molti altri eccessi emotivi, può innescare pericolosi stati di coinvolgimento e iperreattività, che deformano l’analisi della realtà, e condizionano in senso anti-razionale i processi decisionali, con conseguenze nefaste, alcune delle quali molto visibili oggi, soprattutto per la vita pubblica e per l’agire politico.
La sfera emotiva rappresenta dunque un campo di negoziazione dei significati del presente, intorno al quale si sono aperte vaste prospettive interdisciplinari di ricerca: già da diversi anni si parla di emotional turn tanto in antropologia, quanto nelle scienze sociali e nella ricerca storica. E se è vero che di queste “svolte” disciplinari, spesso più apparenti che sostanziali, è costellata la storia recente delle humanities, è innegabile che il tentativo di fare delle emozioni un oggetto di studio, definibile culturalmente e storicamente, può abilitare una nuova comprensione dei fenomeni del passato, e un’indagine genealogica sull’attuale assetto psichico ed emotivo della società. Di questa svolta, di questa apertura di prospettive, partecipa senza dubbio l’Atlante di Watt Smith, che ha il merito principale di portare all’attenzione di un pubblico di non specialisti il fatto apparentemente contro-intuitivo che le emozioni possano avere una storia, un’esistenza culturale stratificata e variabile. Il concetto stesso di emozione è storicamente tracciabile, ha un’origine precisa, e non è sempre esistito come noi lo conosciamo: secondo Thomas Dixon (From Passions to Emotions. The Creation of a Secular Psychological Category, 2003) è il frutto di una laicizzazione, avvenuta all’inizio dell’Ottocento, del discorso sulle passioni sviluppato nel corso dei secoli in ambito teologico. Mostrare le radici storiche e l’evoluzione semantica delle emozioni è un modo di interrogare l’alluvione emotiva del presente, di ancorarla a una riflessione, di dare una solo apparentemente paradossale profondità agli aspetti superficialmente emotivi dell’esistenza contemporanea.
Il lavoro archeologico dell’Atlante delle emozioni umane non si contrappone soltanto alla coazione al consumo di emozioni effimere, ma anche a una diffidenza radicata in ambito accademico e scientifico, dove le emozioni sono state a lungo percepite come parte di quel complesso di dati immediati, di fatti della vita che cadono al di fuori dei fenomeni interrogabili con gli strumenti della cultura e della scienza. Il movimento di storiografia delle emozioni entro il quale si inscrive l’Atlante tuttavia è interessante proprio nel suo tentativo di dare conto dell’esistenza delle emozioni reali, di creare una connessione tra le rappresentazioni e le concettualizzazioni delle emozioni, culturalmente variabili, e la loro profondità antropologica, la loro esistenza trans-culturale e metastorica, la loro persistenza e immutabilità percepite.
La storiografia delle emozioni, sviluppata da oltre un decennio in ambito anglosassone e solo marginalmente penetrata nel dibattito italiano, pone il problema a suo modo scandaloso dell’esistenza concreta delle emozioni, si interroga su ciò che le persone realmente provano, e lo confronta con ciò che è ipotizzabile abbiano realmente provato in passato. A partire dallo studio delle mediazioni e delle rappresentazioni culturali delle emozioni, si tenta di andare oltre le mediazioni, per capire a quale nucleo esperienziale le rappresentazioni danno forma. Questo movimento è perfettamente visibile nell’Atlante pubblicato da Utet, che nel dare conto della storia culturale delle emozioni segnala sempre il filo che le lega all’esistenza quotidiana, alla situazione contemporanea, accostando anche alle emozioni fondamentali alcune condizioni nuove, inconcepibili in altre epoche, come il tecnostress o la cybercondria (la compulsione alla ricerca in rete). Ogni emozione è introdotta dalla descrizione di una situazione possibile, da uno spunto narrativo, che suggerisce anche come ogni stato emotivo contenga in sé l’embrione di una storia.

Ph: Alamy.
In questo suo registro stilistico colloquiale il libro scherza anche con il linguaggio del manuale di autoaiuto o della guida alla vita emotiva, introducendo un aspetto che potrebbe far sollevare qualche sopracciglio. Ma nell’esibire familiarità con la vita emotiva corrente il libro viola, io credo con consapevolezza polemica, un autentico tabù degli studi storico-culturali, nei quali le teorie decostruzioniste e post-strutturaliste hanno agito in profondità (ma non solo queste: si tratta di un processo di ipostatizzazione del linguaggio e di astrazione delle pratiche simboliche che risale alle origini stesse della modernità), e hanno sedimentato l’idea che nelle interazioni umane tutto è cultura, rappresentazione, linguaggio, codice. Una diffidenza e un pudore profondamente radicati (e per molti aspetti giustificati), sorgono ogni volta che si devono maneggiare le nozioni di realtà, esistenza, vita, natura.
Al contrario, lo scarto introdotto dalla storiografia delle emozioni è il tentativo di partire dalle rappresentazioni, dalle articolazioni e variazioni culturali che interessano le emozioni, per bucarle, per arrivare a toccare qualcosa che fa parte delle nostre interazioni di base con l’ambiente, della nostra esistenza biologica. Non a caso, l’Atlante delle emozioni umane, così come gran parte delle ricerche affini, individua nel libro di Charles Darwin The Expression of the Emotions in Men and Animals, del 1872, lo sfondo antropologico sul quale si innesta la storia culturale delle emozioni. Darwin compila una sorta di catalogo di fossili emotivi, di espressioni delle emozioni primordiali, che costituiscono il sostrato animale della vita emotiva, al quale si applicano le trasposizioni e le traduzioni culturali (e stupisce che manchi del tutto, in Watt Smith come nella maggior parte degli studi dello stesso tipo, un riferimento a Warburg, il grande rabdomante delle “forme emotive” cristallizzate nell’arte, che pensava di organizzare proprio in un atlante figurativo le immagini che hanno stilizzato nel movimento delle figure, esperienze psichiche ed emotive antropologicamente radicate).
Il concetto di traduzione è centrale nelle teorie delle emozioni che sono comparse in ambito storico. William Reddy, nel suo libro The Navigation of Feeling, ha descritto le rappresentazioni culturali degli stati emotivi come traduzioni del nucleo duro, persistente, trans-culturale dell’esperienza emotiva, e come atti linguistici che nel dire le emozioni necessariamente le plasmano, le informano. Esistono degli oggetti, le emozioni, che hanno a che fare con la vita biologica dell’individuo e che i linguaggi umani traducono. Le emozioni prendono la forma del discorso e dei gesti che le rappresentano: sono performance verbo-motorie che riattivano secondo modalità culturalmente definite esperienze antropologiche profonde, stati psichici antichissimi.
Una teoria delle emozioni fondata sul concetto di traduzione e di performance consente di superare tanto il dualismo psicologico tra realtà oggettiva e soggetto che la conosce, quanto la pandiscorsività del post-strutturalismo che nega l’esistenza di una realtà esterna al linguaggio. Le emozioni sono esattamente questa realtà esterna al linguaggio, che la mente cerca di catturare, concettualizzandola e formalizzandola. Nel farlo, mette in contatto processi biologico-cognitivi e strumenti culturali, elaborazioni interiori e forme sociali: le indagini neuroscientifiche sull’elaborazione cerebrale delle emozioni vengono integrate in questa prospettiva di studio, ma con un approccio critico che segnala come non bastano le reazioni chimiche del cervello a determinare un’emozione, mentre servono sempre un corpo e una mente che la agiscono in un contesto culturale. Eppure è proprio contro questo sfondo di reazioni corporee e di legami chimici che si ritagliano le emozioni culturalmente conoscibili.

Elisabeth-Louise Vigée Le Brun, Autoritratto, 1787.
La storia delle emozioni si intreccia alla storia della scienza e della medicina: serve una nuova concezione e una nuova cura del volto e in particolare della bocca perché possa affiorare, nella Parigi della metà del Settecento, la smile revolution indagata in un libro di Colin Jones (The Smile Revolution in Eighteenth-Century Paris). In un’increspatura emotiva, in una smorfia si manifesta il vasto complesso di trasformazioni sociali e culturali che preparano la prima grande rivoluzione politica della storia. Ed è a partire dalla storia della fisiologia umana, e della sua culturalizzazione, che si possono indagare le manifestazioni del pianto nella società inglese, mostrando come la mitologia dello “stiff upper lip”, della assoluta continenza emotiva del popolo inglese, sia non solo il frutto di una costruzione culturale, ma anche di precise politiche delle emozioni (è ciò che ha fatto Thomas Dixon nel suo Weeping Britannia. Portrait of a Nation in Tears).
Pensare alla nostra esperienza delle emozioni come al frutto di una traduzione ci riporta all’Atlante delle emozioni, la cui edizione italiana ha dovuto affrontare problemi traduttologici molto significativi. Non solo perché si è trovata di fronte a emozioni intraducibili, come quelle che abbiamo citato all’inizio, ma anche perché ha dovuto dare conto delle diverse storie etimologiche relative ai nomi di alcune emozioni, che nell’adozione di radici diverse rivelano diverse sfumature di significato. La pesantezza che si nasconde nella tristezza è più evidente nell’inglese sadness, etimologicamente legato al concetto di sazietà (e al latino satis), così come alla presenza di un peso rimanda più visibilmente boredoom, la parola inglese per “noia”. Ed è più facile vedere lo splendore che illumina la contentezza nell’inglese gladsomeness, sostantivo che rimanda al campo semantico della luce.
Questi affascinanti percorsi semantici e lessicali dimostrano ulteriormente che le emozioni hanno una storia e una geografia, e che la loro nebulosità può condensarsi in modo diverso a seconda dei climi culturali e sociali: è l’autrice stessa a utilizzare nella sua introduzione la metafora della catalogazione della forma delle nuvole per alludere al lavoro di classificazione delle emozioni. Della natura sfuggente e refrattaria alle definizioni univoche delle emozioni è specchio anche la struttura del libro: organizzato come un dizionario, funziona attraverso una rete di rimandi interni che lo rendono un ipertesto, e che servono a segnalare la contiguità e la sovrapponibilità delle diverse situazioni emotive, le sfumature che le fanno scivolare una nell’altra, l’instabilità molecolare dei campi emozionali. Tanto che diventa difficile smettere di seguire le catene analogiche, difficile circoscrivere la definizione di un’idea emotiva a una sola voce, difficile rinunciare a percorrere la selva di incroci e rimandi reciproci per seguire una lettura lineare. Come si fa, del resto, a segnare con esattezza il confine tra frustrazione ed esasperazione? Provare per capire.







