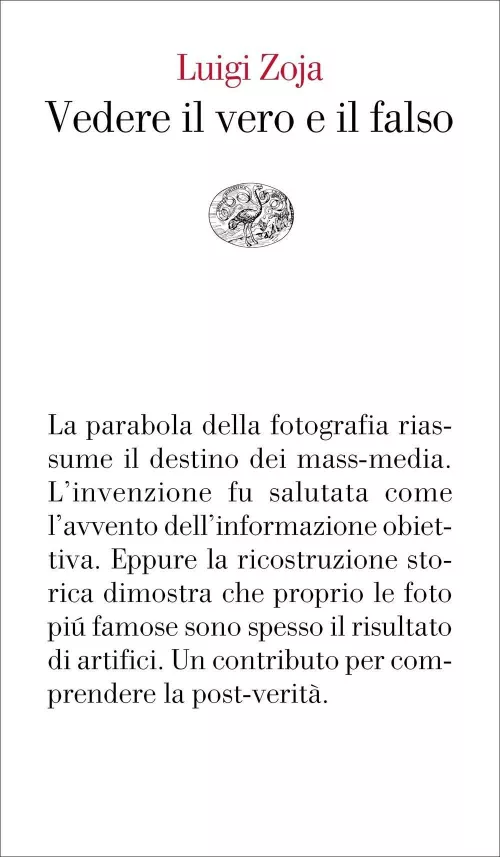Dario Mangano, Luigi Zoja / Vedere e esserci: due libri sulla fotografia
Una mano tiene fra due dita una fotografia. Si vede un albero molto grande, un prato su cui ognuno vorrebbe sdraiarsi e nuvole bianche nel cielo. La foto si sovrappone alla realtà. Il soggetto sta osservando l’immagine nel luogo dove l’ha scattata, anche se la realtà appare sfocata: le nuvole, il cielo e l’albero sono semplici macchie di colore. Sembra un paradosso. Cos’è più reale? L’immagine o il mondo in cui la stessa immagine e il soggetto sono immersi? È davvero possibile rispondere a questa domanda?
Per di più questa immagine costituisce la copertina di un libro, Che cos’è la semiotica della fotografia (Carocci Editore, Bussole, 2018), di Dario Mangano. Ulteriore vertigine semantica, anche se il titolo suona rassicurante e rievoca, attraverso questa ironica provocazione, la fiducia che fin dalla sua nascita la fotografia riscuote. Cosa che le accade in quanto sarebbe depositaria di una straordinaria aderenza alla realtà e di una completezza nella resa di ogni suo dettaglio, anche se oggi il realismo ingenuo è scomparso e nessuno si sognerebbe di definire la macchina fotografica uno specchio. L’intento è chiaro, Mangano traccia una sorta di mappa concettuale, una “Bussola”, come la collana dell’editore Carocci di cui fa parte, a disposizione di chi si avvicina alla fotografia, come campo problematico per la semiotica.
Sfiora dunque alcuni tra i temi più dibattuti intorno al medium. Il primo riguarda il rapporto tra la macchina e il fotografo. È il fotografo che fa la macchina, o la macchina, contro ogni illusione umanistica, dà forma a chi la usa e alla porzione di mondo che cattura? In seguito si sofferma su un altro interrogativo cruciale: cos’è la fotografia? Qual è la sua essenza?
Qui ricopre grande importanza la distinzione proposta da Philippe Dubois, che nel suo saggio L’atto fotografico (1983, ed. it. a cura di B. Valli, Quattroventi, 2000) si basa sulla logica ternaria (diversa da quella binaria degli studi linguistici e semiotici più noti, come la distinzione saussuriana tra significante e significato), impiegata da Charles Sanders Peirce, per distinguere fra tre diversi tipi di segni sulla base del loro rapporto con la cosa rappresentata, ovvero icona, simbolo e indice.
Nel terzo capitolo la nozione di testo viene affiancata a quella del linguaggio fotografico e infine vengono prese in considerazione differenti tipologie di immagini e le strategie impiegate per produrre precisi effetti di senso: la foto scioccante che ha vinto il World Press Photo nel 2017, scattata da un fotografo turco di nome Burhan Özbilici, che documenta l’omicidio dell’ambasciatore russo Andrej Karlov, avvenuto il 19 giugno del 2016 ad Ankara. O ancora l’ironia di Martin Parr, lo sguardo poetico di Mario Giacomelli nella serie di Scanno, la celebre foto del miliziano di Robert Capa, i nudi di Bill Brandt, la natura di Ansel Adams, le invenzioni di Andreas Gursky e le foto degli insetti antropomorfi di Alberto Ghizzi Panizza.

Una volta assimilate la terminologia e il metodo della semiotica come strumento di conoscenza e riflessione, si può compiere un altro passo in avanti. Ed è quello di seguire il percorso che rende problematico il tentativo di “leggere” le fotografie. E la risposta è che la semiotica può essere apprezzata mettendola alla prova, tendendo ai limiti la sua capacità di analisi. La camera chiara (1980, trad. it, R. Guidieri, Einaudi) di Roland Barthes ne è il testo guida.
Il semiologo considera infatti la fotografia come un “messaggio senza codice” sin dal suo saggio “Il messaggio fotografico” pubblicato nel 1961. Cosa significa? Che per passare dal reale alla sua fotografia “non è necessario scomporlo in unità e costituire queste unità in segni che differiscono dall’oggetto che essi offrono in lettura”; la fotografia non è il reale ma quantomeno il suo “analogon” perfetto, scrive Barthes, che nella Camera chiara lo definirà come “referente fotografico”, ovvero la “cosa necessariamente reale che è stata posta dinnanzi all’obiettivo”.
Se dunque non esiste un codice che si ponga come una mediazione tra l’oggetto e la sua rappresentazione in immagine, cosa rimane al lettore? Come si può capire il messaggio di una fotografia? Passando da una dimensione cognitiva a una patemica. La questione del senso di una foto si sposta sul soggetto, afferma Mangano, e questo significa affermare che essa trae origine dal suo modo di sentire e vivere l’immagine, dal sentimento, unico e personale, che essa è in grado di suscitare. Non è forse la foto della madre di Barthes, scattata in un giardino d’inverno, quando era solo una bambina, a sostituire il suo corpo e la sua essenza dinnanzi agli occhi del figlio?
C’è quindi un aspetto misterioso che si spinge oltre il senso referenziale di un’immagine, che è sì un indice, ma può rappresentare anche l’indice di una rottura, di una crisi, che mostra la rappresentazione nel suo punto critico, ovvero nel punto in cui si sottrae alla sua stessa interpretazione e genera un effetto di stupore. Una visione dominata dall’imprevisto e dal sensazionale, da ciò che coinvolge tutti i sensi, ma anche l'intelletto, poiché sensato è ciò che è dotato di senso.
Quindi, per quanto pensate con cura, le fotografie molto spesso sorprendono chi le ha realizzate, dando prova di possedere quello che potremmo definire un “eccedente visivo”. E di nuovo Mangano evoca un’idea di Roland Barthes, ciò che egli chiama “senso ottuso” alludendo a quanto va oltre il senso del simbolico, che egli definisce ovvio. Si tratta di un terzo livello di lettura “ostinato e nello stesso tempo sfuggente, liscio e inafferrabile”, un supplemento di visione, che conduce lo spettatore a guardare ciò che nell’immagine genera una sorta di stupore. Ed è questo che davvero ci seduce, ovvero la sua presenza come unità densa che sfugge a interpretazioni univoche e genera sviamenti, attimi di pura fascinazione per ciò che non stavamo cercando e che ci viene incontro quasi per caso, come un enigma o una istantanea apparizione.
E se la fotografia può essere considerata il confine tra due indicità, poiché l’obiettivo punta tanto verso l’interno, ovvero al fotografo che sta dietro l’apparecchio, quanto all’esterno, ovvero al mondo che sta davanti alla macchina, il libro di Luigi Zoja, Vedere il vero e il falso (Einaudi, 2018), suggerisce l’importanza delle circostanze in cui un’immagine viene diffusa e recepita.
La copertina del libro, a differenza di quello di Dario Mangano, non riporta alcuna immagine, ma una sorta di premessa teorica espressa attraverso la parola: “la ricostruzione storica dimostra che proprio le foto più famose sono spesso il risultato di artifici”. La domanda è dunque: quanto è vera un’immagine? La risposta è affidata ad alcune fotografie: quattro di guerra e quattro scattate a bambini in contesti bellici o drammatici. Tutte si lasciano dietro una sorta di inquietudine, come se qualcosa fosse rimasto in sospeso, o come se ci avessero comunicato una verità che si sporge e di cui non riusciamo a tracciare contorni netti.
La “Morte di un miliziano” di Robert Capa si pone come una sorta di foto-evento-origine quasi imprescindibile per chiunque affronti il valore testimoniale di un’immagine, o meglio il suo presunto impeto documentario. Questa foto, ma anche le altre su cui si sofferma, si chiede Zoja, è autentica o una messa in scena? Non è possibile rispondere immediatamente. Lo sguardo non è sufficiente. Zoja ci suggerisce che il contesto in cui la foto è stata scattata è importante quanto il soggetto ritratto. Testo, ipertesto, paratesto hanno la medesima importanza. La strategia è precisa: ricostruire la storia dentro e fuori la stessa immagine. Un esempio vale per tutti. Si tratta di uno fra gli scatti più celebri della Seconda Guerra Mondiale. Impossibile non ricordarla.
Viene scattata all’inizio del 1945 da Joe Rosenthal sul monte Suribachi, nell’isola giapponese di Iwo Jima, la cui occupazione costò all’esercito americano un enorme sacrificio di vite. Rosenthal fotografò sei soldati dell’esercito issare una bandiera degli Stati Uniti sulla cima della montagna, e la foto diventò rapidamente un simbolo della Seconda guerra mondiale, e successivamente una delle immagini più iconiche di tutto il Novecento.
Dopo la battaglia per Iwo Jima il passo successivo nella sconfitta del Giappone fu la conquista di Okinawa, isola ben più importante e popolata. Perché quindi la foto di Iwo Jima è così diffusa? Per due motivi: se la battaglia di Okinawa fu glorificata per ragioni abbastanza oggettive, quella di Iwo Jima, lo fu per offuscare i dubbi sull’utilità della conquista, fa notare Zoja.
Inoltre, ed è l’aspetto più importante, vi è una forte componente ideologica, alla base della sua messa in scena: “la verticalità dell’eroe solitario si associa a quella dei vicini saldandosi in una forte struttura orizzontale”, che sintetizza tre temi centrali nella storia politica americana: “egualitarismo, nazionalismo e quella forma particolare della civil religion chiamata civil republicanism, (repubblicanesimo civico o civile, curvatura leggermente sociale del primo)”, scrive Zoja, ricordando gli studi di Robert Hariman e John Louis Lucaites su questa immagine. Un discorso che fa riferimento tanto alle preferenze individuali quanto allo strato di psiche universale detto inconscio collettivo.
Qual è dunque l’insegnamento che possiamo trarre dal metodo di analisi proposto da Zoja? Come possiamo capire se un’immagine è vera o falsa? Come è possibile smascherare la sua opacità, il suo silenzio impenetrabile, la sua placida indifferenza? Ognuna delle immagini prese in considerazione diviene il punto di partenza per riflettere sulla possibilità che una foto, di per sé oggetto chiuso in se stesso, ha di essere manipolata. Non è dunque in discussione lo statuto più o meno complesso di un’immagine, ma il fatto che una fotografia possa essere usata per veicolare una precisa ideologia. Poiché se l’immagine è un messaggio senza codice, le rappresentazioni che produce possono essere fortemente codificate: stampa, arte, moda, porno, scienza. Paradossalmente la fotografia esercita un potere che non è mai il suo. Per quanto possa essere considerata inseparabile dalla sua situazione referenziale, la sua “verità” varia a seconda dei rapporti di potere da cui è investita, dipende dalle istituzioni e da chi se ne appropria, e garantisce l’autorità delle sue narrazioni.
Osservare una fotografia e collocarla in una precisa cornice storica, consente dunque di sottrarsi alle mistificazioni che qualsiasi istituzione o apparato intendono attribuirle. Zoja vuole dire che la storia narrata dall’immagine è importante quanto la storia da cui proviene. Per questo è fondamentale comprendere tanto la foto, quanto le pratiche di significazione messe in atto come oggetto che dissemina significati, nei più diversi contesti in cui si trova a vivere. La foto non è dunque un oggetto neutro che esibisce se stesso, ma grazie al nostro sguardo, può far emergere un senso al di là di quello che le viene attribuito.
Zoja le sceglie per sé e per il lettore, affinché questi, per quanto possibile, prenda la misura del capovolgimento di attitudine che tali immagini esigono. “Perché le immagini ci tocchino veramente, bisogna che non siano più quella rassicurante farmacia che la bellezza falsamente promette. Perché le immagini ci divorino, bisogna che noi le guardiamo come guarderemmo uno sciame di mosche che si avvicina: un ronzio visivo che circonda la nostra stessa vocazione a decomporci”, ricorda Georges Didi-Huberman. Scomporre un’immagine, significa anche scomporre il nostro sguardo e le nostre certezze.
Ecco che i libri di Mangano e di Zoja, con diversi strumenti insegnano a considerare un’immagine come un campo di forze, di tensioni, di frammenti, di sguardi, con cui entrare in relazione, con cui trovare, se vogliamo, anche il nostro posto nel mondo.