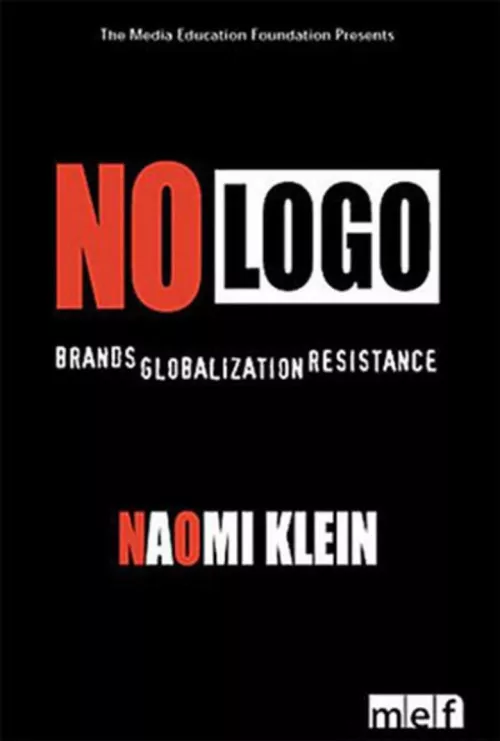Marche / Vent’anni da No Logo
Nel dicembre del 1999, la giornalista canadese Naomi Klein ha pubblicato nel suo paese il volume No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies. Un volume che all’inizio del 2000 è uscito negli Stati Uniti e in Inghilterra e, nell’aprile dell’anno successivo, anche in Italia, pubblicato dall’editore Baldini & Castoldi. In vent’anni, è stato tradotto in più di trenta lingue e ha venduto oltre un milione di copie. Probabilmente, ciò è accaduto perché No Logo ha posto per la prima volta all’attenzione generale il tema del ruolo sociale svolto dalle marche aziendali. Il che gli ha anche consentito di diventare una specie di “bibbia” per tutti coloro che avevano una posizione critica nei confronti del mondo delle imprese.
Vent’anni fa, il contesto culturale e sociale nel quale le marche aziendali operavano era molto differente da quello odierno. C’erano, infatti, dei movimenti sociali che erano apertamente schierati contro il mondo delle marche e la crescente invasione della società da parte del modello di consumo occidentale. Tali movimenti portavano dei vistosi attacchi durante importanti eventi internazionali come il vertice del WTO tenutosi a Seattle nel novembre del 1999. Successivamente c’è stata, nel luglio del 2001, la contestazione al raduno del G8 di Genova. E pochi mesi dopo, l’11 settembre 2001, è arrivata anche la drammatica strage delle Twin Towers a New York, che ha reso l’Occidente maggiormente consapevole delle difficoltà che il suo modello economico e sociale stava incontrando. Inoltre, il movimento raccoltosi attorno alla rivista canadese Adbusters aveva cominciato già da diversi anni a modificare gli annunci pubblicitari delle principali marche per cercare di smontare e indebolire i significati di promozione commerciale in essi contenuti.
Le marche, però, hanno saputo reagire a questa situazione e hanno ottenuto negli ultimi anni dei crescenti successi. Infatti, hanno cominciato progressivamente ad arricchirsi di significati, assumendo un’esistenza sempre più autonoma rispetto al prodotto, il quale oggi spesso per esistere e funzionare deve necessariamente farlo all’interno dei mondi comunicativi proposti dalle marche. E hanno, di conseguenza incrementato la loro importanza sia sul piano del marketing che su quello sociale. Addirittura, a volte, essendo alla ricerca di sempre maggiori profitti e dotate di una forza economica e finanziaria superiore a quella di molti Stati, hanno anche ignorato le leggi nazionali e i diritti dei loro dipendenti.
La crescita del peso sociale delle marche si è verificata anche perché negli ultimi decenni le società occidentali sono sempre più entrate nel modello della cosiddetta “economia della conoscenza”.
Un’economia dove sono soprattutto le marche a produrre il valore economico, così come nel capitalismo industriale a svolgere lo stesso compito era la fabbrica. Se quest’ultima aveva la necessità di controllare i processi di produzione interni ad essa e perciò la sua forza lavoro, le marche devono svolgere la stessa funzione rispetto alle relazioni che si sviluppano nella società, la quale diventa così una vera e propria “fabbrica sociale”. È dunque al loro esterno che le marche oggi riescono ad accumulare valore, sfruttando il lavoro che viene quotidianamente svolto da parte dei consumatori e della società in generale. Ed è qui che possiamo dire si svolgano i principali processi produttivi odierni. Ciò è possibile grazie all’instaurarsi di quel processo di intensa mediatizzazione della vita sociale e del consumo che caratterizza le società ipermoderne. Le marche non devono fare altro che tentare di operare in qualità di mezzi di comunicazione, cioè come strumenti relazionali, come ambienti autonomi dove i produttori e i consumatori possono stabilire una connessione reciproca. Allo scopo di trasformare in valore economico tutto quello che prende vita dentro la società, cioè quel surplus di innovazioni, idee e creatività che gli individui producono all’interno delle loro esperienze quotidiane.

Nelle società contemporanee, infatti, è in atto un processo di saturazione che riguarda tutti i canali comunicativi disponibili, mentre i prodotti offrono prestazioni simili e hanno radici culturali e geografiche sempre meno distinguibili. Dunque, sono sempre più uguali tra loro e sempre meno interessanti per i consumatori. Per le imprese pertanto non è più sufficiente produrre un prodotto e comunicare l’esistenza di tale prodotto o le informazioni rispetto a ciò che esso è in grado di offrire, ma è necessario imporsi comunicando una specifica identità di marca.
E ciò è particolarmente vero in una situazione come l’attuale di crescente globalizzazione dei mercati. In una situazione, cioè, nella quale la concorrenza esercitata da numerose imprese di altri paesi impone di dover ribadire con forza la propria diversità. Il che si ottiene solamente potenziando la propria identità di marca attraverso l’inserimento di contenuti specifici.
Va considerato inoltre che dietro il sempre maggiore ricorso delle imprese al ruolo della marca c’è una evidente ragione economica. Infatti, se efficacemente gestita, la marca riesce a evitare i danni dell’invecchiamento. Pertanto, come scriveva già vent’anni fa Klein nel suo No Logo, «le aziende non hanno nessuna convenienza a investire le proprie limitate risorse in fabbriche che avranno bisogno di manutenzione, in macchinari che diventeranno obsoleti, in dipendenti che inevitabilmente invecchieranno e moriranno» (2007, p. 248). Devono piuttosto cercare di concentrare i loro sforzi sulla costruzione e l’aggiornamento costante dell’identità di una marca.
L’enorme successo che è stato ottenuto negli ultimi vent’anni dalle marche è testimoniato anche dal fatto che nel contesto attuale nessuno, se vuole affermarsi sul piano sociale, può esimersi dall’adottare una precisa strategia di marca. Così, nell’attuale contesto sociale, è possibile vedere che anche uomini politici, calciatori, ospedali e università si “loghizzano” in maniera crescente. Perché soltanto in questo modo possono guadagnare attenzione e resistere nel tempo. Possono cioè seguire l’esempio di tutte quelle marche che dall’Ottocento sono arrivate con successo sino ai nostri giorni.
Oggi dunque, come già registrava Klein, le marche occupano in misura crescente gli spazi della nostra vita quotidiana: i luoghi pubblici delle città e i principali eventi culturali e sociali, ai quali legano strettamente il proprio nome attraverso delle azioni di sponsorizzazione o i cosiddetti “product placement”. Ma tendono anche a essere dei veri e propri creatori di contenuti mediatici, come Pepsi Max e Nike, ad esempio, che hanno dei propri canali televisivi su YouTube. Le marche, inoltre, riescono anche a mescolarsi con l’ambiente che le circonda. Addirittura, come sosteneva ancora Klein in No Logo, le marche tendono progressivamente a trasformarsi in virus che contaminano la cultura sociale. E, paradossalmente, si assumono anche il compito di esercitare delle forme di critica allo stesso sistema economico e sociale capitalistico in cui operano. Come ad esempio Dove, che si è schierata da tempo contro l’abuso del corpo femminile nei messaggi dei media, oppure Gillette, che negli Stati Uniti contesta i modelli negativi di mascolinità. Nike invece, da parte sua, promuove un atleta impegnato sul piano politico come il giocatore di football americano Colin Kaepernick, che in una partita si è rifiutato di alzarsi in piedi durante l’esecuzione dell’inno americano per protestare contro le politiche del Presidente Trump e la brutalità e il razzismo di alcuni poliziotti. Inoltre, si fa promotrice di valori femministi come nel recente spot pubblicitario Dream Crazier.
Insomma, in questi vent’anni quello che Klein affermava in No Logo è risultato sempre più evidente. Qualcosa di nuovo però c’è ed è quello che viene raccontato da Shoshana Zuboff nel libro da poco uscito anche in Italia Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri (Luiss University Press). Un libro che può essere considerato una specie di “nuovo No Logo”, perché vi si racconta come le marche oggi non si accontentino più di nutrirsi del mondo in cui viviamo, ma sfruttino le possibilità offerte dalle nuove tecnologie digitali per raccogliere e analizzare le informazioni che riguardano la nostra vita privata e dunque “mangiare” anche le nostre emozioni e le nostre esperienze più intime.