Il potere evocativo degli oggetti / Bollas: essere un carattere
La feticizzazione dell’oggetto, spiegava Marx, sta nella sua ingannevole promessa di trasferirci magicamente le sue proprietà intrinseche, mentre in realtà siamo noi che vi proiettiamo le nostre. La questione è nota ma forse, osserva Bollas, non ancora sufficientemente interrogata: “in che senso assegniamo alle cose i nostri stati psichici? Perché non si tratta solo di un’intenzione conscia, ma di un’istanza profondamente inconscia del Sé nel mondo degli oggetti”, che in qualche modo viene evocata, rivelata, al punto che “alcuni oggetti, come chiavi psichiche, aprono porte che conducono ad esperienze inconsce intense e ricche in cui articoliamo il Sé che noi siamo, mediante il carattere elaborativo della nostra relazione. Questa scelta costituisce la joussance del vero Sé, una beatitudine frutto della scoperta di oggetti specifici che liberano l’idioma nella sua articolazione” (Christopher Bollas, Essere un carattere, Raffaello Cortina editore, Milano, 2020, pp. 234, euro 22, p.4 e 7).
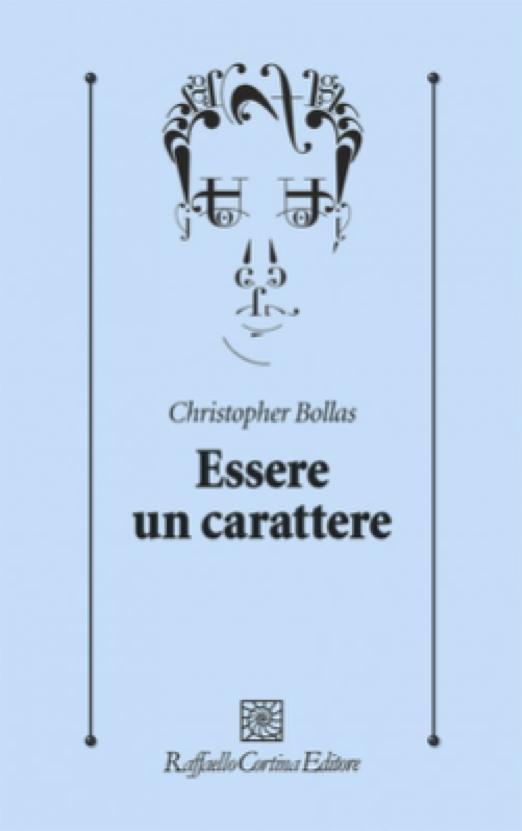
Si tratta di un passo denso, e forse inutilmente complicato, che vale la pena analizzare minuziosamente. Ciò che Bollas sta qui spiegando, ma che si può comprendere appieno solo avendo già letto, almeno, i suoi L’ombra dell’oggetto e Il pensiero orientale, è che se un oggetto si rivela capace di fungere da “vocabolario dell’esperienza del Sé” (p.18), ossia di farci accedere alla comprensione del funzionamento delle più peculiari dinamiche psichiche di ciascuno di noi, non è certo per un suo presunto “mana”, il misterioso potere spirituale intrinseco che gli attribuivano alcune popolazioni australiane rese celebri dagli studi di antropologia di Marcel Mauss e Claude Lévi-Strauss, ma in virtù della loro capacità di evocare in noi echi dell’originario holding materno, facendoci rivivere l’esperienza magica della trasformazione di uno stato d’animo, indotta dall’intervento di un “oggetto” esterno. È questa esperienza, spiega Bollas, che cerchiamo negli oggetti che ci affascinano e non il loro possesso: “[da bambini] la madre non è ancora identificata come altro, ma è vissuta come un processo di trasformazione, e questa caratteristica dell’inizio della vita rimane in certe forme di ricerca oggettuale nella vita dell’adulto, in cui io credo che l’oggetto sia cercato per la sua funzione di significante del processo di trasformazione.
Perciò nella vita dell’adulto, la ricerca non è orientata al possesso dell’oggetto: esso è cercato per arrendersi ad esso come un medium che altera il Sé” (C. Bollas, L’ombra dell’oggetto, Raffaello Cortina Editore, 1987, pp. 21-22). In questa dialettica con l’oggetto il bambino prima e l’adulto poi, sperimentano il potere trasformativo del proprio stato d’animo, in virtù dell’oggetto-madre che cercheranno di ricreare con altri oggetti transazionali in un processo che, tuttavia, non li vede soggetti passivi ma individui attivamente protagonisti nella scelta e nel processo di trasformazione legato all’oggetto. Un esempio può esserci d’aiuto: il dolore dovuto alla fame, o l’esperienza angosciante del vuoto del bambino vengono trasformate dal latte sunto dal seno materno in esperienza di sazietà, benessere e pienezza, in un processo del quale il bambino assumerà non soltanto i contenuti (il latte) ma soprattutto la forma: la relazione oggettuale che cura e trasforma.
Perché Bollas ne parla in termini di “liberazione dell’idioma”? La risposta si trova nel suo La mente orientale, nel quale lo psicoanalista americano riprende dal libro del collega Gordon Allport Divenire. Fondamenti di una psicologia della personalità, l’idea che “ogni persona è in sé stessa come una forma idiomatica, un’apparente violazione della sintassi della specie. Un idiomatismo si sviluppa nel suo particolare contesto e per comprenderlo dobbiamo conoscere questo contesto” (cit. in C. Bollas, La mente orientale, Raffaello Cortina, Milano, 2013, p. 95). Questo idioma è tutt’altro che chiaro e perfettamente traducibile: al contrario, è lo scarto tra ciò che sappiamo e ciò che pensiamo, è “il conosciuto non pensato”, secondo Bollas, vero cuore del lavoro psicoanalitico e sottotitolo, nella versione originale, di Essere un carattere. A livello inconscio la forza di questa esperienza consiste nella sua capacità di riattivare l’originario linguaggio materno, preverbale, che non ruota attorno a ingiunzioni, argomentazioni o spiegazioni esplicite ma funziona piuttosto mostrando in forma implicita “forme dell'essere, del pensare e del relazionarsi” (id., La mente orientale, pag. 14). In questo modo esso fornisce modelli comportamentali assimilabili dall’Io che diverranno poi suoi inconsapevoli paradigmi relazionali e cognitivi. Questi modelli, dunque, non dipendono dalla corretta rappresentazione che il soggetto si farà dell’oggetto, in virtù di un’adeguata categorizzazione concettuale, ma prendono piuttosto vita dall’incontro con l’oggetto, ossia dalla relazione che s’instaura tra soggetto e oggetto, in una maniera che a me è parsa analoga al giudizio riflettente proposto da Immanuel Kant nella sua celebre Critica del giudizio.

In essa Kant introduce questa forma di giudizio che chiama “riflettente” per differenziarlo dal giudizio determinante – al centro di La Critica della ragion Pura e, più in generale, del nostro modo di rappresentarci correttamente l’oggetto di cui parliamo – perché esso non ruota attorno ad una categoria concettuale già nota che esiste a priori, ma emerge solo in virtù dell’effetto che l’oggetto stimola nel soggetto il quale riflette, come in uno specchio, la realtà interiore su quella esteriore. Il giudizio riflettente, dunque, non è propriamente un giudizio conoscitivo, perché non fa luce né sulle proprietà dell’oggetto, né sul nostro modo di conoscerlo, esso ci permette piuttosto di cogliere in forma riflessa la finalità che portiamo dentro di noi. Tale finalità, in Bollas, è la ricerca di un senso di integrità che sappia raccogliere le diverse parti che compongono il nostro Sé e conferirgli un senso unitario (p. 43); un senso di unità che è una pura illusione ma della quale l’essere umano ha bisogno e che sembra palesarsi quando si rivela il nostro personale idioma.
Tanto nella Critica della Ragion pura, quanto nell’esperienza di cui parla Bollas, non contano dunque le proprietà dell’oggetto in sé, né quelle del soggetto in sé, quanto lo “spazio intermedio” nel quale avviene il loro incontro che è in grado di stimolare una particolare rivelazione del Sé che l’oggetto non contiene ma per il quale appare non di meno determinante. Scrive Bollas: “Tutti viviamo tra migliaia di questi oggetti che illuminano il nostro mondo [che hanno cioè il potere di fare luce sul nostro mondo interiore ed esteriore]: non si tratta di allucinazioni, essi esistono, ma la loro essenza non è quel che Lacan chiama il reale. Il loro significato si trova in ciò che Winnicott ha definito lo “spazio intermedio” o “la terza area”; il luogo in cui in soggetto incontra la cosa, per conferire un significato proprio nel momento in cui quell’essere viene trasformato dall’oggetto. Gli oggetti dello spazio intermedio sono formazioni di compromesso tra lo stato mentale del soggetto e il carattere della cosa” (id, Essere un carattere, op. cit., p.8).
In virtù di questo potere, gli oggetti percepiti come evocativi e trasformativi dal soggetto, possono permettergli di “sognare la sua vita”, nel senso di applicare alla realtà di veglia le stesse categorie interpretative che si applicano ai sogni, dove tutto dice io, è cioè una parte del soggetto sognante, pur essendo, evidentemente, da esso distinta. Ecco che gli oggetti attivano dunque un potere rivelativo sul soggetto che viene però innescato da una riflessione e da un’analisi che aprono al loro significato simbolico, il che svela contemporaneamente il funzionamento del nostro mondo interiore (la “capacità della persona di esperire il proprio idioma evocato dall’oggetto”, Id, Essere un carattere, p. 25). Perché un certo brano musicale si rivela capace di promuovere in noi una significativa variazione di umore e un altro no? Perché un argomento di discussione attiva improvvisamente il nostro interesse e un altro ci annoia? Secondo Bollas ciò è dovuto alla loro capacità di mettere in azione un certo stato del Sé, ed in particolare alla capacità di facilitare il passaggio dal Sé semplice (la condizione di quando siamo immersi nell’esperienza) al Sé complesso (che si attiva quando riflettiamo sull’esperienza che abbiamo vissuto). In questo modo gli oggetti divengono strumenti per esprimerci, di più, scrive Bollas, “per incontrare ed esprimere il Sé che noi siamo”, nelle sue diverse forme (p. 23).
La sua forza, dicevamo, sta nella capacità di riattivare quell’idioma personale, unico per ciascuno di noi, che ci offre l’impressione di accedere a quello che Winnicott definiva il vero Sé, entità nella quale Bollas non crede in senso ontologico ma solo cognitivo: il vero Sé non è che il senso unitario che conferiamo alla complessità, irriducibilmente eccedente le nostre possibilità di comprensione, della nostra psiche (p. 43). “La saggezza” – uno junghiano direbbe l’individuazione – “consiste nella capacità di abitare l’incertezza sul significato del nostro Sé, o della vita” senza rifuggirla o saturarla con un significato qualsiasi (p. 44) per ricercare non tanto definizioni ultime ma opportunità per sintonizzarsi con quanto, fuori e dentro di noi, attiva il nostro idioma personale e favorisce una riflessione di senso sul nostro modo di essere. Con le sue parole: “l’idioma che dà forma al carattere umano non è un contenuto latente del significato, ma un’estetica della personalità, che non cerca di esprimere un significato inconscio, ma di scoprire oggetti che si coniugano in esperienze cariche di significato. Muovendoci nel mondo degli oggetti, respirando la nostra vita nell’impersonale, raccogliamo e organizziamo i nostri effetti personali” (p. 47).
Forse non siamo lontani da quanto invitava a fare, in una celebre lettera al fratello, il poeta John Keats, quando scriveva: “Chiamate il mondo, vi prego, la valle del fare anima e allora scoprirete qual è la sua utilità. [...] Dico fare anima intendendo per "anima" qualcosa di diverso dalla "intelligenza". Possono esistere milioni di intelligenze o scintille della divinità, ma esse non sono anime fino a quando non acquisiscono identità, fino a quando ognuna non è personalmente se stessa”.
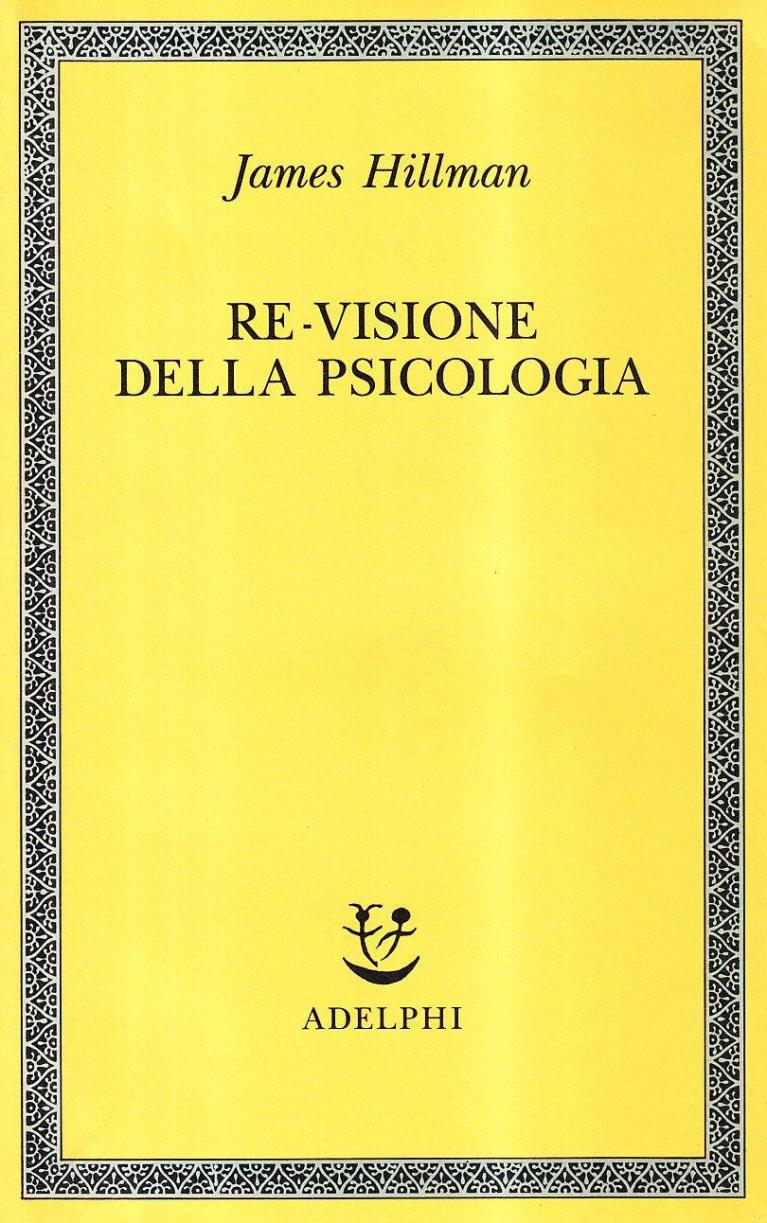
Tale prospettiva, resa celebre da James Hillman a partire dal suo Re-visione della psicologia (Adelphi, 1983), chiama in causa un lavoro di elaborazione personale che in Bollas conduce a Essere un carattere: si tratta di una specie di “intelligenza operativa” (p. 63), di “una virtù che irradia ed esalta tutti gli oggetti nei rapporti di senso” (p. 64). Questa particolare “gravità psichica che attrae a sé le idee, i sentimenti o gli stati del Sé inconsci o nascenti”, è detta anche “genere” e sarebbe “l’incubazione psichica degli investimenti libidici del mondo degli oggetti” (p. 50). Non ho intenzione di addentrarmi nella spiegazione della nuova accezione che Bollas attribuisce a questo termine – operazione di cui, sinceramente, non si sentiva l’esigenza – voglio limitarmi a indicare come il suo funzionamento, caotico e creativo, faciliti le dinamiche che abbiamo descritto sopra e rilanci l’idea bollasiana di un inconscio recettivo il cui linguaggio simbolico spesso criptico non sarebbe il tentativo di evitare la censura superegoica ma “di eludere una coscienza prematura”. È questa condizione particolarmente feconda proprio per la sua indeterminatezza, che è paragonata da Bollas al sogno e costituisce il paradigma del suo approccio psicoanalitico che può considerarsi un invito a divenire “il lavoro onirico della propria vita”, ossia ad attivare un particolare stato di recettività, interesse, ragionamento, sensibilità e attenzione liberamente fluttuanti, che richiedono l’elaborazione di un significato non immediatamente chiaro nei quali il nostro Sé si svela e si ridesta, quasi potesse concludere: “sogno e son desto”.







