Quando navighiamo le parole / Chandra Livia Candiani. Infanzia e poesia
Il mio angelo è un po’ teppistello fa gli scherzi
brucia le ali degli altri angeli gioca alla Wii
non sta mai fermo
il mio angelo è molto rabbioso
io e il mio angelo siamo uguali.
Zoubayr, 9 anni
Le edizioni Dante e Descartes, in questo periodo sulla cresta dell’onda per Averno, della neonata Nobel Louise Glück, hanno recentemente pubblicato un mini scritto di Chandra Livia Candiani, L’angelo teppistello. Mini perché il libro fa parte della collana Storie in trentaduesimo. “All’insegna del piccolo formato per conto dei librai in fondo alla città” recita il colophon. Piccolo formato significa proprio piccolo: 4x5 cm, per un totale di 80 pagine. Che i librai stiano in fondo alla città (di Napoli) non è, credo, ininfluente, per una scrittrice che in un precedente libro sulla poesia e i bambini, Ma dove sono le parole (Effigie 2015), ha scritto che il luogo dove li incontra e a essi fa incontrare la poesia è “quella periferia dell'essere dove si sbaglia sempre, si è fuori luogo, si vacilla fortemente e si vive senza rete”.
L’angelo teppistello, si legge nel frontespizio, è apparso nel 2015 in “Rivista di psicologia analitica” (n. 40, vol. 92). Ottima l’idea di riproporlo oggi all’attenzione dei lettori. Sarebbe stato un delitto perdere questo contributo che ha il dono di presentare in una sintesi fulminante infanzia e poesia, due terre di nessuno a cui si approda senza intenzione.
In Essere visti dalla luna, introduzione a Vista dalla luna, raccolta poetica edita da Salani nel 2019, Chandra Livia Candiani scrive: «L’infanzia è un luogo assoluto, senza tempo, luogo di transito, in cui non si può sostare, ma tornare sempre.» Un luogo, cioè, molto affine alla poesia.
La protagonista di Vista dalla luna è la bambina Io che così prende la parola all’inizio della raccolta:
«E io, mamma?»
«Non c’eri».
«Dov’ero io, mamma?»
«Non c’eri».
«Dov’ero?»
«Dov’eri?»
«Dov’ero».
«Nel mondo della luna eri».
In tutte le raccolte di Chandra Livia Candiani a ogni giro di pagina spuntano infanzie e bambini e ogni sorta di creature e di cose piccole, mute e insieme parlanti. Ma Vista dalla luna è dichiaratamente a esse dedicato: «Non ho le parole per dirlo. Ma ho i versi della poesia per far vedere. Cosa? L’infanzia sterminata. Sterminata è un aggettivo a doppio taglio. Significa sia smisurata che annientata», scrive Candiani.
La presenza dell’infanzia, così come quella della poesia, è legata, qui, a un non esserci che impronta l’origine, quello con cui la madre, creatrice per eccellenza, battezza la bambina Io: «Non c’eri». Un non esserci che attesta dell’infanzia e della poesia la grandezza e il rischio – sterminate entrambe. Negazione che ne ospita molte altre: non appartenere, non sostare, non sapere, non conoscere, non spiegare, non capire, non possedere, non vincere, non avere – scelta, possibilità, strumenti, sicurezze... Un lungo elenco di senza, di mancanze, di perdite che hanno l’effetto di fare il vuoto, di mettere all’erta, in una condizione di nudità e di attesa, esposti al silenzio, all’ascolto.

L’angelo teppistello, come Ma dove sono le parole, racconta di un’esperienza: quella del tentativo di fare incontrare nella poesia i bambini e le parole (e i silenzi che entrambi portano). Da alcuni anni, a Milano, Chandra Livia Candiani svolge seminari sulla poesia in alcune scuole primarie, quasi sempre in zone marginali della città, connotate dalla forte presenza di bambini che spesso vengono da molto lontano. Bambini la cui esperienza è stata spesso smisurata e rischiosa, e che porta i segni di molte negazioni, di molti senza, di molte perdite, una delle quali è quella di una lingua conosciuta a favore di una sconosciuta.
Scrive Candiani in un passo di L’angelo teppistello: «Incontro bambini che hanno poche parole, una lingua strappata alle spalle, una lingua che hanno dovuto abbandonare per un’altra che ancora non suona, che non ha memoria, che è tutta nuova e un po’ sterilizzata, ma che crea quell’insondabile mistero per cui uno pronuncia delle parole e l’altro le capisce e risponde. E quel mistero brilla ancora, scintilla negli occhi di molti di loro. Insieme alla fatica. E alla paura. Qui bisogna togliere pesi, penso.» E spiega che quando dice ai bambini di non sapere cosa sia la poesia, loro guardano la maestra preoccupati: «E poi gli parlo di cos’è per me la poesia. Di che forza potente sia. Di come non abbia niente a che fare con il poetico, ma possa dire tutto, anche il male, anche il loro male, il male dello strappo, anche il male delle poche parole.»
Scomparire, non suonare, abbandonare, essere strappati, togliere: chi conosce la scrittura di Chandra Livia Candiani conosce bene questo lessico che fa riferimento alle privazioni, alle mancanze, alla rinuncia, all’essere scassati, alle miserie non solo materiali che toccano in sorte a chi è accolto da una patente di inesistenza. E tuttavia questo libro che ha esso stesso operato una rinuncia, e nasce piccolo, ridotto, mancando in partenza di occupare uno spazio, una visibilità, è in grado di capovolgere la prospettiva in modo fulmineo.
«Uno dei giochi che i bambini amano di più credo sia scomparire e apparire e la poesia glielo permette, soprattutto se è in un’altra lingua» si legge in un passo.
Apparire e scomparire: vengono in mente le parole di Giuliano Scabia in Il bambino d’oro (in Una signora impressionante, Casagrande 2019):
Baussète: eccolo il seme-germoglio di tutti i giochi.
Apparire, sparire.
Nascondersi, farsi trovare.
Aver paura di non essere trovati.
Rischiare di restare al buio.
Nascere o morire.
Baussète!
Sono qui, sono vivo. Trovatemi. Giocate con me.
La mancanza delle parole, dunque, questo accesso maldestro al mistero di una lingua nuova è non disgrazia, ma chiave di volta che accende il pensiero di una luce completamente nuova.
Non si tratta di una sublimazione di una condizione di povertà, un premio di consolazione a chi sta ai margini consegnato da chi guarda dalla riva, bensì di un concretissimo e percorribile sentiero alla salvezza, di quei sentieri della famiglia costellata di molliche o sassolini: la scoperta di un luogo abitabile, un luogo che dà alla vita. «La poesia non è in nessuna lingua che conosco, prende in prestito le parole dalla lingua che conosciamo, ma è una lingua di sussulti, trasalimenti, gioie e spaventi, bisbigli e silenzi.»
Togliere pesi, dunque, qui significa non far sì che i bambini ‘evadano’, dimentichino le proprie storie, volgano l’attenzione ad altro, ma spalancare la mancanza a spazio smisurato, a voce. È fare del lessico della negazione un lessico della presenza. Per questo, insieme a Chandra Livia Candiani, nelle classi, entra un corteo variegato e nobilissimo di presenze che molto di rado frequentano le aule delle scuole: Emily Dickinson, Paul Celan, Eliot, Pasternak, Caproni, Lorca, Hikmet, poeti cinesi antichi e moderni, Rumi...
Una scelta che suscita sorpresa, se non scandalo, se si pensa a quanto, oggi, molto di ciò che riguarda bambini e didattica sia soggetto a un impoverimento e a una riduzione costanti in nome di una facilità scambiata per strada maestra all’inclusione. Una vera e propria sindrome che porta a una costante perdita di profondità e a un appiattimento del senso delle esperienze che toccano ai bambini, molte delle quali riguardano proprio il sentire, l’espressione, la lingua, la scrittura, la parola.
In proposito mi vengono in mente due cose. La prima è un articolo, qualche tempo fa, di un linguista che sul “Sole24Ore” lamentava, in un albo illustrato per bambini, la presenza della parola afidi. Una parola che, diceva, lui stesso aveva da poco appreso e, dunque, riteneva inadatta in una storia destinata ai piccoli, in quanto troppo difficile.
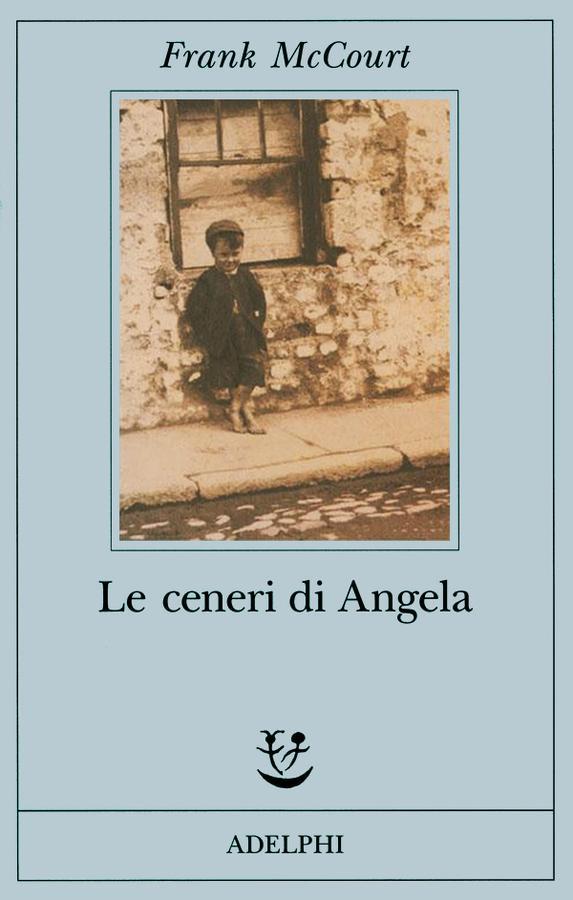
E parole troppo difficili, sottolineava, si incontrano in libri per bambini pur ammirevoli – e portava esempi: maniero per castello, assopirsi anziché addormentarsi, un cielo trapunto di stelle, vestiti consunti e via discorrendo – scelte lessicali, concludeva che finiscono per mortificare i bambini e disamorarli alla lettura. Come se il processo di apprendimento di una lingua, i legami profondi e del tutto personali che i bambini stabiliscono con essa nella crescita e nella scoperta del mondo, quel fatto del tutto straordinario, complesso e smisurato che ha descritto benissimo Elias Canetti in La lingua salvata, ovvero la scoperta delle parole, potessero essere ridotti entro i confini di una concezione della lingua come quantificabile e ‘corretta’ presa di possesso della realtà in base a misurabili skill (le temibilissime competenze) assegnate a specifiche fasi di età.
La seconda cosa che mi viene in mente è quel passo magnifico di Le ceneri di Angela in cui la potenza e il mistero della lingua si offrono intatti al protagonista attraverso un libro del tutto casualmente, e improbabilmente, giunto fra le sue mani. Chi parla è Frank McCourt che racconta la propria infanzia a Limerick, in una Irlanda poverissima e stracattolica, negli anni Trenta e Quaranta. Decenne, mezzo morto per tifo, dopo averne passate di ogni colore, primo di cinque fratelli di cui tre moriranno piccoli, con un padre alcolizzato e una mamma disoccupata, Frankie, ricoverato in ospedale conosce una ragazzina difterica, Patricia Madigan. Lei non lo vede mai, gli parla dalla stanza accanto e gli presta, affidandolo alle mani dell’infermiere Seamus, un libro che racconta la storia dell’Inghilterra: «Nel libro» scrive McCourt, «ci sono i primi versi di Shakespeare che mi sia mai capitato di leggere: 'Persuasa da circostanze incontestabili, io credo che voi siate mio nemico'. Come riferisce l'autore del libro, è così che dice Caterina, una delle mogli di Enrico VIII, al cardinale Wolsey che vorrebbe farla decapitare. Io non capisco che cosa significa la frase ma non mi importa perché è Shakespeare e quando pronuncio quelle parole è come se avessi in bocca delle pietre preziose. Se mi dessero un libro tutto di Shakespeare potrebbero pure tenermi in ospedale un anno intero.»
La formazione poetico ospedaliera di Frankie prosegue, attraverso il muro che separa le due stanze, quando Patricia gli legge i versi della ballata romantica The Highwayman di Alfred Noyes: «Il vento era un fiume oscuro fra gli alberi furiosi/la luna una galea spettrale su mari tempestosi/la strada un nastro argenteo sulla purpurea landa/ e cavalcando giunse il bandito/cavalcando cavalcando/ cavalcando giunse il bandito all’uscio della locanda...»
«Questa poesia è emozionante e bella quasi quanto i miei versi di Shakespeare» scrive McCourt. «I soldati danno la caccia al bandito perché sanno che ha detto alla fanciulla: Verrò da te ai primi raggi di luna s’anche il demonio mi sbarrasse la strada.
Mi piacerebbe tanto fare anche io così, andare ai primi raggi di luna da Patricia nella stanza accanto e s’anche il demonio mi sbarrasse la strada scoreggiarci sopra. Patricia è pronta a leggermi le ultime strofe, quand’ecco che entra l’infermiera del Kerry strillando a tutti e due: Ve l’avevo detto che fra due stanze è proibito parlare. La difterite non può parlare col tifo e viceversa.» I due innamorati vengono separati, lui mandato a un altro piano dell’ospedale. Poco dopo Patricia muore, e il libro con i versi di Shakespeare rimane a Frankie che li reciterà fra sé tutte le volte che potrà, un talismano che rende splendenti.
«La sete inestinguibile di lettere dell'alfabeto», come la definisce Elias Canetti, le parole come pietre preziose in bocca sono qualcosa che somiglia a quello di cui parla Chandra Livia Candiani quando racconta della propria scoperta della poesia (in La formazione della scrittrice, “Vibrisse”, marzo 2014): «Prima di andare a scuola, attorno ai cinque anni, c’è stata la faccenda di Pascoli.
Sempre Max, mio fratello, studiava una poesia a memoria, diceva e ridiceva parole strane, sonore ma che creavano in corridoio delle immagini: rondini, nidi, bambole al petto, cavalline, stelle. Camminando lungo quel brutto e anche un po’ cattivo corridoio, le parole mi colpirono alla schiena, mi immobilizzai e le ricevetti, correvano le immagini un po’ di qua e un po’ di là e io mi dissi solo: “Da grande scriverò in quella lingua.” […] Ho cominciato a leggere di nascosto, perché un somaro non legge libri, al massimo giornalini. Io prendevo i libri di mia sorella, alle medie leggevo sotto il banco Goethe, Dostoevskij, Tolstoj, Thomas Mann, Musil e via e via, i grandi classici ma di nascosto, come un furto. E Calvino, tanto Calvino. E Ungaretti e Quasimodo e Montale e Pavese. Non so bene com’è andata che ho cominciato a comprare i libri di poesia, i miei libri. In realtà, cercavo la poesia dappertutto, mi stufavo appena uno scrittore si dilungava, mi sentivo abbandonata appena scriveva cose senza sussulto. Cercavo vie di comprensione del mondo e della vita fulminanti. Cercavo la poesia. Sempre leggevo di nascosto, dovevo mantenere la mia identità somara e un po’ scema, mi sembrava un sacrilegio leggere quei libri, temevo che da un momento all’altro qualcuno, a casa o a scuola, avrebbe urlato: “Come ti permetti!”».
Frankie, la piccola Livia e il piccolo Elias, i bambini delle scuole milanesi che Chandra incontra e fa scrivere appartengono a quella schiera di ragazzini che (forse) la letteratura salva, ma anche con cui la letteratura ha un debito costante. Sono, i Felici Pochi (contro gli Infelici Molti): solo per citarne alcuni, Miguilim dell’omonimo romanzo di João Guimarães Rosa, Louis protagonista di L’angioletto di Georges Simenon, Erica e i suoi fratelli del romanzo omonimo di Elio Vittorini, Momò di La vita davanti a sé di Romain Gary, Eugenia, la bambina mezza cecata di Il mare non bagna Napoli, Useppe (all’anagrafe Giuseppe Felice Angiolino) della Storia di Elsa Morante, e molti, moltissimi altri. Il lettore potrebbe scambiare le loro storie per narrazioni di infanzie drammatiche, ma finisce, attraverso le loro vite, per entrare in una dimensione che sopravanza di gran lunga qualsiasi tentativo di trovare una misura dicibile. È l’eccedenza, la gratuità, di cui l’infanzia è così prodiga. In Il mondo salvato dai ragazzini Elsa Morante lo dichiara in versi memorabili:
La vostra benedizione è conoscere
che pure il desiderio del paradiso è servile.
Il gioco è divino perché non c’è nessuna promessa
o speranza di guadagno.
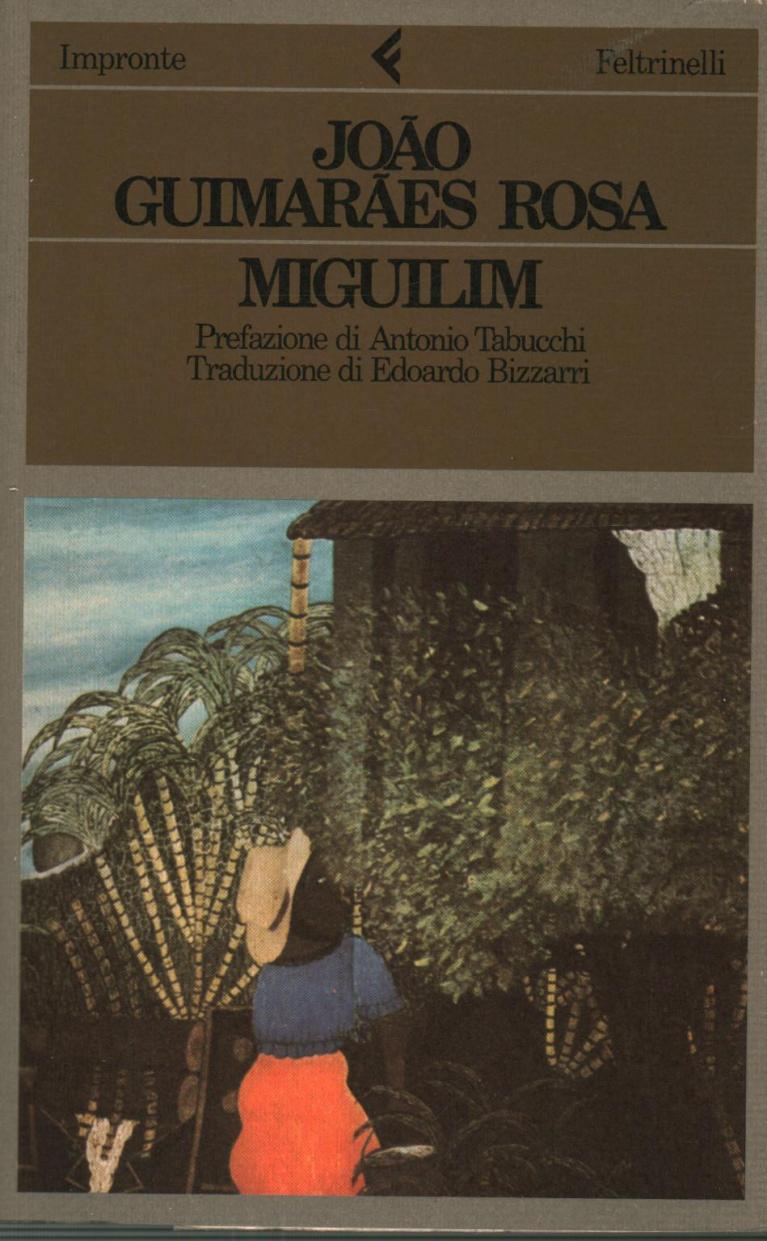
Scrive João Guimarães Rosa: «Miguilim non aveva voglia di crescere, di essere una persona grande, i discorsi delle persone grandi erano sempre le stesse cose secche, con quella necessità di essere violente, cose spaventate.» Scrive uno dei bambini di Chandra, Jaime, 9 anni, peruviano: «I grandi/Sono noiosi/Sono arabiati confronto ai bambini/Non si divertono/solo parlano/Ma i grandi sono come bambini/ soltanto che fanno i duri». Scrive Elias, nove anni, egiziano: «I grandi sono gente che salgono la torre inabitata/cose e oggetti che si buttano da soli/rompono le porte /distruggono le nostre anime.»
Scrive João Guimarães Rosa: «Dito diceva che bisognava essere sempre pieni di allegria, allegri per dentro, qualsiasi cosa di brutto accadesse allegri nel profondo.» Scrive Leo, otto anni: «Quello che conta/è la formica/è tutto che conta/è sacro.»
Scrive Vittorini, a proposito di Erica e i suoi fratelli: «La vita doveva, per loro ragazzi, essere quella che era lì, in una casa, in una città; e non era brutto. A loro ragazzi piaceva, e il brutto era stato sempre soltanto per la miseria di cui facevano peso i grandi. La miseria non esisteva se non che attraverso i grandi per loro ragazzi. Forse neanche il freddo esisteva per loro se i grandi non lo nominavano.» Scrive Christian, 10 anni, filippino: «Grazie per la sedia/ed avermi dato una casa, /io sono piccolo,/ma dentro/sono gigante/che è sbocciato/da una briciola.»
Scrive Vittorini in una lettera a Moravia e a Carocci: «Erica avrebbe scoperto tutto della vita e conosciuto tutto di essa, a poco a poco (anche il piacere, e anche l'amore, anche l'amicizia), pur attraverso il disastro della propria condizione. Si sarebbe sviluppata (pur in mezzo a un tale disastro) in tutto quello che è della creatura umana, e insomma da tutte le parti di quello che è l’animo umano. Questo era il tema specifico del libro. L’allegro fondamentale che è della vita, malgrado tutto, raggiunto appunto (a mostrare il – malgrado tutto –) da una partenza di disastro assoluto…» Scrive Marian, 10 anni, rom: «L’amicizia è una giacca leggera,/una bellezza che non si può restituire./Amore incancellabile, incontenibile,/immisurabile, ricaricabile, indescrivibile./L’amore è infinito ogni modo d’amare/è come un oggetto.»
«Portare a scuola quello che nel mondo non funziona» scrive Chandra Livia Candiani, «è una grande fiducia nell’infanzia, infanzia della parola, della vita senza rete, fiducia che la poesia sia un luogo e sia possibile lanciare molliche di pane perché un bambino si avventuri verso quel luogo e trovi quel linguaggio a schegge che permette di dire senza dover dire per bene, senza dover dire per intero, senza descrivere, spiegare. […]»
È nel luogo abitabile della poesia che Chandra Livia Candiani porta i bambini, facendo molto di più che spalancare davanti a loro la selvatica e ardente bellezza delle parole, quella che travolge Frankie e fa piazza pulita di qualsiasi tentativo di fare della lingua un parco giochi diviso per fasce di età che stringe le parole nei recinti di “adeguate e difficili”, “facili e inadeguate” (il tifo non deve parlare con la difterite e viceversa!). Quel che fa, in più, è dal disastro assoluto aprire lo spazio smisurato, eccedente, di assoluta gratuità della poesia: Il vento era un fiume oscuro fra gli alberi furiosi/la luna una galea spettrale su mari tempestosi/la strada un nastro argenteo sulla purpurea landa…
«Per portare la poesia a scuola si tratta di essere poesia e cioè una cassa di risonanza vuota e spazzata, un non-sapere molto consapevole» scrive Chandra Livia Candiani. «Dopo molti anni di funambola tra silenzio e parola, improvvisazione e studio, gioco e lavoro, ho trovato non so più dove una frase di Edgar Morin che mi ha fatto una grande compagnia: “Educare gli educatori al pensiero dell’incertezza.” Uh, mia misura! Educarsi non all’incertezza solamente, ma al pensiero dell’incertezza, un pensiero che si fa di volta in volta, che non sa prima, che sa insieme ed è pronto a lasciare il conosciuto per salpare verso il non-conosciuto. Come mi è successo di scrivere in una poesia dedicata ai miei Maestri bambini: io sono capitano serio / quando navighiamo le parole / il loro buio fitto / l’alto mare.»







