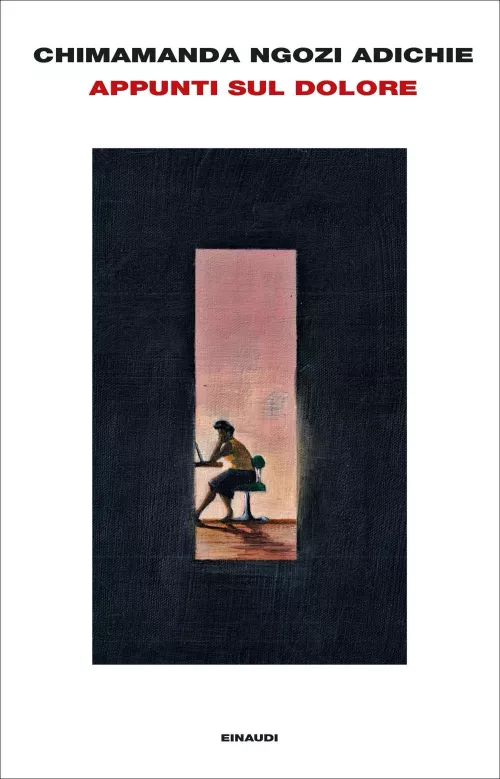Il lutto è un dialogo interrotto / Chimamanda Ngozi Adichie, Appunti sul dolore
Il 9 giugno Chimamanda Ngozi Adichie telefona al padre James. La telefonata è breve, lui è stanco, lei riesce comunque a farlo ridere imitando una parente. Alla fine si dicono ka chi fo, buonanotte, e riattaccano. Il giorno dopo, 10 giugno, James Nwoye Adichie è morto, per le complicazioni di un blocco renale. Intanto nel mondo c’è il Covid, e così la notizia viaggia dalla Nigeria agli Stati Uniti attraverso Zoom. Chimamanda Ngozi Adichie racconta tutto questo in Appunti sul dolore, e Susanna Basso lo traduce per Einaudi.
Il dolore non è liquido – non ci puoi nuotare agevolmente. Non è nemmeno solido – quando ti cade addosso, non ti lascia un livido che va via dopo qualche giorno. Il dolore non è gassoso – non lo puoi inspirare ed espirare, non ci puoi passare attraverso come fosse aria. Il dolore è viscoso. Come il bitume. Non è inconsistente, ma non ha nemmeno un peso costante. «Il suo peso aumenta in massima misura la mattina, dopo il sonno». Il dolore è vertiginosamente verticale – «sono andata in pezzi», scrive semplicemente Adichie.
Il dolore è una lacerazione improvvisa del tessuto grammaticale – anche di questo parla il libro. È lo strappo dei tempi verbali: non è, ma era. Ho amato. Sono stata amata. Ha fatto. Faceva. «Sto scrivendo di mio padre al passato, e non posso credere che sto scrivendo di mio padre al passato». Il dolore introduce un nuovo tempo – il tempo prima e il tempo dopo, – e un nuovo lessico, che al nuovo tempo è legato– il lessico dei mai più e il lessico delle ultime volte: «è l’ultima cosa che mi ha detto», «una risata che non farò mai più». Elimina la prima persona plurale dal presente e la relega al passato: ora il presente è io – se è noi, si tratta di io più qualcuno che non è lui. Dunque il dolore è anche un fatto linguistico: rappresenta lo sgretolamento del linguaggio e il fallimento di un sistema di senso, ossia di ciò che ci consente di orientarci nel mondo. Adichie è una scrittrice che si riconosce per la sua lingua composta, precisa, sempre controllata: in Appunti sul dolore lascia il pedale del freno, va in folle, si preoccupa appena di controllare lo sterzo. E così la sua lingua cambia, si fa meno misurata: «la mia diffidenza nei confronti dei superlativi è sparita del tutto», scrive. Ma a cambiare non è solo la lingua di chi soffre: nella viscosità linguistica si impantanano anche coloro che al dolore si avvicinano da esterni, ma il cambiamento è di segno opposto – il lessico si fa più edulcorato, i verbi più cauti, la lingua si fa decorosa, presentabile, si veste a lutto in un elegante abito nero, che alla praticità dell’è morto sostituisce un più azzimato è scomparso, o si è spento, se n’è andato, ci ha lasciati, non c’è più.
Il cambio d’abito vale per tutti, tranne che per i bambini: in uno dei frammenti di cui questo libro si compone troviamo la figlia di Adichie, che col candore dei suoi quattro anni spiega che «la mamma è triste perché il nonno è morto» – salvo poi chiederle, dopo qualche giorno, «ma il nonno quando si sveglia?». I bambini riescono a sfuggire all’edulcorazione del linguaggio, ma non allo sconquasso del senso. La morte, per i bambini, è completamente irragionevole: perché una persona dovrebbe di punto in bianco smettere di esistere? Non esistere mai più? Esistere per l’ultima – e unica – volta? Imparare a dare un senso alla morte – a capire che la morte ha un significato fisico – e di conseguenza fare i conti con le conseguenze emotive significa rinunciare a un pezzo d’infanzia. L’infanzia è il regno in cui nessuno muore, scriveva Edna St. Vincent Millay. Nessuno d’importante, s’intende: i parenti lontani, quelli che vediamo una volta all’anno, non si può dire che siano mai stati vivi. Nemmeno gli animali valgono, dice la poeta. Un gatto muore, prendi una scatola, lo seppellisci, ma non è che dopo un anno, due anni, ti svegli nel cuore della notte gridando Mio Dio, Mio Dio! per il gatto. L’infanzia è il regno in cui nessuno d’importante muore. Non muoiono i padri, non muoiono le madri. Si diventa adulti quando ci si siede a tavola con i morti, con «persone che non parlano e non sentono», persone che non bevono il tè, «che pure dicevano / essere un tale piacere». Il dolore rende adulti, la morte fa uscire dall’infanzia: «Ora il tè è freddo. Lo bevi in piedi / e vai via».
Il dolore è un fatto fisico, di corpo. «Non è il male a sorprendermi, ma la sua manifestazione fisica, la bocca amarissima, come se avessi mangiato un pasto ripugnante e avessi scordato di lavarmi i denti; un peso atroce sul petto e la sensazione che dentro di me tutto si vada disfacendo», scrive Adichie. Il dolore somiglia alla paura, scrive invece C. S. Lewis in Diario di un dolore (traduzione di Anna Ravano per Adelphi): «la somiglianza è fisica. Gli stessi sobbalzi dello stomaco, la stessa irrequietezza, gli sbadigli. Inghiotto in continuazione». Ma il dolore è anche imbarazzante – per te, per gli altri. Non c’è nulla di più comico, diceva Beckett. Quando nella stanza entra un vedovo, i presenti cambiano postura; per la strada, cercano di non incrociare la conoscente che ha perso il marito. Non si sa cosa dire – se sorvolare e apparire maleducati o fare un rapido accenno col rischio di toccare carne viva, se ricordare il passato o provare a immaginare un futuro, se porre le condoglianze o lasciar parlare lo sguardo – si tratta sempre di zigzagare tra pietismo e distacco. «Forse chi è in lutto dovrebbe essere isolato in quartieri speciali, come i lebbrosi», taglia corto C. S. Lewis.
Il dolore, poi, è egoista: perché è morto lui e non un altro? È egocentrico: vuole che se ne parli. Il dolore è iconoclasta: le immagini non bastano, le fotografie fanno piangere, i video rendono tristi – è il corpo che vuole. Il dolore è sgarbato, è maleducato, talvolta violento, e Adichie se ne rende conto: «c’è un video che mostra la processione della gente in casa nostra per mgbalu, la cerimonia delle condoglianze, e mi viene voglia di fare irruzione e cacciare tutti fuori dal soggiorno dove mia madre già occupa il divano in una placida posa vedovile. […] io penso: Andatevene! Che ci fate in casa nostra, che cosa avete da scrivere su quel quaderno? Come osate trasformare questa cosa in una realtà?». Il dolore – e questo è uno degli aspetti più interessanti del libro – è una questione culturale. Il dolore igbo non è il dolore statunitense: «c’è un valore nel modo igbo, il modo africano, di trattare il dolore». Il modo igbo è un modo da tragedia greca, è un modo molto classico, da Orestea, molto diverso da quello occidentale: «La mia bambina di quattro anni dice che l'ho spaventata. Si butta in ginocchio per farmi vedere, con i piccoli pugni stretti che vanno su e giù, e la sua mimica mi restituisce l'immagine di me, completamente distrutta, che grido e batto i pugni a terra». È un modo che prevede una «reazione drammatica e performativa», oltre a una serie di rituali e usanze ben precise.

Il corpo della vedova, ad esempio, deve recare l’impronta della perdita: la donna che ha perso il marito deve rasarsi i capelli in segno di lutto. Adichie e i suoi fratelli protestano in coro che è ridicolo, che nessuno ha mai pensato di rasare un uomo alla morte della moglie, e che questa cosa, semplicemente, non si farà. È però la stessa vedova, loro madre, a intervenire: «Farò tutto quel che si deve fare», dice. Questo perché il dolore non è solo una questione culturale, non è solo locale – è anche individuale. Il dolore a volte prende la via della loquacità, «quella in cui si risponde a tutte le chiamate e si ripete daccapo la storia di come sono andate le cose, quella in cui isolarsi è un sacrilegio e “basta lacrime” un continuo intercalare». Ho visto molte persone reagire a un lutto rivivendolo a parole. Il racconto straziante della morte arriva fino all’ultimo respiro, viene ripercorso il penoso declino o lo sbalorditivo tracollo, si sfoglia la cartella clinica, s’interrogano amici medici – siamo creature di senso, ed è per questo che cerchiamo di mettere in fila gli eventi, per fare sì che quantomeno abbiano un senso, una logica. Questo è un modo. Non un modo igbo, non un modo statunitense. Un modo di alcune persone. Altre volte invece il dolore vuole tacere, si ritrae, non risponde al telefono e non legge i messaggi, non vuole dire né ricordare. Non vuole nemmeno che si sappia troppo.
Non vuole le insegne, non vuole i necrologi, non vuole le condoglianze. Vuole il tempo privato dei ricordi belli rivissuti nella mente. Vuole il rituale, la messa nella chiesa barocca, preferisce l’impersonalità di un rosario alle letture degli amici.
Il dolore, poi, è anche insidioso: finisce che ti ci affezioni. Che ti sembra rispettoso proteggerlo, continuare a custodirlo in modi assurdi, aggrappandosi agli oggetti più insulsi. Ho visto persone andare in giro con maglioni logori, camicie bucate, orologi rotti. Perché era il maglione di. Era la camicia di quella volta che. Era l’orologio che indossava quando. L’ho fatto anche io, comunque. Per mesi dopo la morte di una persona cara sono andata in giro coi suoi orecchini. Orecchini che mai avrei messo, se non fossero stati orecchini genitivi – gli orecchini di. Poi li ho persi. All’aeroporto di Londra, al check-in. Solo allora si capisce quant’è stupido, com’è assurdo preservare l’esteriorità di un ricordo che può essere solo interiore. Il dolore, in realtà, è molto banale. È una condizione umana, universale, non clinica. È solo l’universo che fa il suo mestiere, direbbe Barnes.
Eppure il dolore lascia increduli. Increduli perché non ci si può mai preparare, perché «non sappiamo come reagiremo al dolore prima del dolore», e poi lascia increduli anche l’indifferenza del mondo: «non posso assolutamente credere che il postino arrivi alla solita ora e che qualcuno mi inviti a parlare da qualche parte e che sul mio telefono compaiano come sempre le notizie dal mondo. Come è possibile che il mondo vada avanti, imperterrito, mentre la mia anima è in perenne sconquasso?». Ci vuole tempo a credere alla morte. A capacitarsi, a scendere a patti. E questo libro mette a tema un’altra difficoltà, ossia la morte al tempo del Covid. Il dolore è di per sé insidioso, nel senso che tendiamo a dimenticarci, anche quando la salma l’abbiamo avuta davanti, anche quando siamo stati presenti fino all’ultimo. Col Covid è peggio: «me ne dimentico perché non sono presente? Probabile. Mio fratello e mia sorella si trovano lì, faccia a faccia con la desolazione di una casa svuotata di mio padre. Mia sorella piange, in ginocchio accanto al suo letto. Mio fratello piange, con uno dei suoi berretti a visiera sulla testa. Hanno modo di constatare che a colazione lui non è seduto al suo posto a tavola, di spalle alla luce della finestra, e che dopo colazione non si piazza sul divano per il consueto rituale di metà mattina, fatto di sonnellini alternati a letture e ad altri sonnellini. Se solo potessi esserci anch’io; invece sono bloccata in America». Il Covid dilaziona in dolore, ritarda il funerale, ostacola il conforto dei rituali: «mia madre ha un disperato bisogno di una data certa. “Dopo la sepoltura potremo cominciare a guarire”, dice».
Il lutto – ed è questo che più mi colpisce – è un dialogo interrotto. Il dolore viene soprattutto da lì. «Le prime parole di mia madre quando Okey le ha dato la notizia sono state “come può?”, versione nigeriana di: “Non può essere, è impossibile. Non mi aveva detto niente”. Perché glielo avrebbe detto. Era così tra loro. Se ci avesse lasciati per sempre, glielo avrebbe detto, perciò il fatto di non averglielo detto significava che non poteva essere vero». È questo di cui in fondo si fatica a capacitarsi. Non me l’hai detto: che il tempo che avevamo stava per finire, che quel nostro tè era l’ultimo, che quello era l’ultimo viaggio. Non lo sapevo: che questa mostra non l’avresti vista, che di questo libro non avresti mai sentito parlare, che di quel film non avremmo potuto discutere. Che c’è qualcuno che se ne va e qualcuno che resta. Che prima eravamo noi e ora sono io.
Al di là della specifica operazione editoriale, ci sono libri che ho letto e subito mi hanno fatto dire: questo è servito molto a te che l’hai scritto, meno a me che l’ho letto, e anzi, mi hai fatta sentire come una che spia la camera ardente dal buco della serratura – ma va bene così. Appunti sul dolore è uno di quei libri. Tu mi parli del tuo dolore perché ne hai bisogno, io ti ascolto, ti tengo compagnia, e poi allungo la mano verso lo scaffale, prendo un altro libro, e comincio a leggere: «la gente dice che ne uscirai. E ne esci, in effetti. Ma non come esce un treno da una galleria, emergendo nel sole sui colli dei Downs e sferragliando in discesa verso la Manica; ne esci come un gabbiano da una marea nera; sporco di petrolio e incatramato per sempre» (Livelli di vita, di nuovo Barnes, di nuovo Einaudi, di nuovo Susanna Basso).