Tove Ditlevsen, alle origini dell’autofiction
Ai primi del Novecento Vesterbro, il quartiere a luci rosse di Copenaghen, puzza di birra e urina; dai cortili salgono le grida di famiglie che si picchiano e s’insultano, a colpi di bastoni e gambe di sedie; a Vesterbro abitano operai e immigrati, «ci sono ubriachi stesi al bordo della strada, con la testa rotta e sanguinante», e il silenzio della notte è rotto dalle sirene di polizia e ambulanze. È qui che nel 1917 nasce Tove Ditlevsen, una delle autrici più celebrate in Danimarca, riscoperta prima negli Stati Uniti – dove ha cavalcato l’onda dell’eterna diatriba tra memoir e autofiction – e adesso in Italia, dove i primi due volumi della sua Trilogia di Copenaghen, rispettivamente Infanzia e Gioventù, sono usciti per i tipi di Fazi nella traduzione di Alessandro Storti.
Nel primo dei due volumi, Ditlevsen si rituffa nelle acque torbide dell’infanzia scandagliandole con una lucidità che ha del miracoloso: giù, «sul fondale dell’infanzia», c’è Ditlev, il padre di Tove, un convinto socialdemocratico che da giovane aveva coltivato ambizioni letterarie, ma che adesso si trova a lavorare come fuochista dodici ore al giorno. Tove si forma sui libri della sua biblioteca, lo guarda mentre sfoglia le pagine del Socialdemokraten, vorrebbe che lui le parlasse di politica, le spiegasse perché legge certi giornali e non altri, perché tiene la foto di Stauning appesa al muro – ma Ditlev, scuro e taciturno, sembra non calcolarla, chiudendosi in un analfabetismo emotivo da padre che di sua iniziativa non rivolge mai la parola alla figlia, perché «non sa cosa dire a una bambina» – salvo poi spiegarle, quando Tove gli rivela i propri sogni, che «le femmine non possono fare le scrittrici».
Ma non è all’approvazione di Ditlev che Tove mira realmente: la bussola della sua devozione punta verso Alfrida, la madre, verso «la quiete distante del suo cuore misterioso», da cui Tove cerca disperatamente di elemosinare affetto, assecondandola, compiacendola, stando ben attenta a non fare nulla che possa turbarla o, peggio, ricordarle che Tove è solo una bambina.
Alfrida è una donna semplice – il mondo esterno, in cui va con «mani che sanno di bucato», le fa paura; è una donna nervosa, che «si veste con movimenti bruschi e rabbiosi, come se ogni capo d’abbigliamento fosse un’offesa alla sua persona»; è molto pratica – vuole che sua figlia si sposi, che trovi un uomo affidabile e con un buon lavoro – perché sa che la vita che sta vivendo non è quella che aveva immaginato da giovane, né quella che vorrebbe per sua figlia: con l’arrivo della Grande Depressione, Ditlev perde il lavoro, e la famiglia comincia a percepire gli assegni di disoccupazione. Solo una volta Ditlev e Alfrida parleranno della possibilità di ottenere anche i sussidi di povertà, ma lo faranno la sera, a bassa voce, di nascosto dai figli, «perché era una vergogna insopprimibile, alla stregua dei pidocchi e dell’affido familiare».
Nel frattempo, Tove comincia a scrivere poesie, mentre cerca di disfarsi dell’infanzia, una bara «lunga e stretta, da cui è impossibile uscire da soli»: a scuola, per cercare di sfuggire alla crudeltà che le sue compagne di classe riservano a chi viene percepito come diverso, indossa la maschera della stupidità, accettando di buon grado la parte dello zimbello, che vede come il prezzo da pagare per essere lasciata in pace con i suoi libri. L’abitudine alla maschera e il bisogno di compiacere le restano attaccate addosso come «l’odore dell’infanzia», tanto che quando incontra Ruth, che diventerà la sua prima amica, la paura di perderla la porterà a fingere di essere simile a lei, «perché le voglio bene, perché è la più forte» – mentre in segreto scrive poesie e coltiva il sogno di andarsene da quel quartiere a cui Ruth sembra invece così intimamente legata.
L’apice di Infanzia è senza dubbio la pagina in cui Edvin, fratello maggiore di Tove, sopraffatto dalle ambizioni che il padre ha proiettato su di lui e solo parzialmente difeso dalla madre, scopre il quaderno di poesie della sorella: sulle prime la prende in giro – scoppia a ridere, la chiama «cacciaballe patentata», legge ad alta voce i componimenti con fare canzonatorio – ma a un tratto le risate si mutano in singhiozzi, Edvin piange sul letto, un pianto inconsolabile e incontrollato, di fronte a cui Tove non sa come reagire.
Il mutamento emotivo è descritto con incredibile finezza narrativa: il libro di poesie abbandonato a terra, il copriletto a righe, il viso nascosto nell’incavo del gomito – Edvin piange il luogo in cui lavora, piange quell’apprendistato voluto dal padre, piange le percosse del padrone. Edvin sembra piangere, più di ogni cosa, la fine dell’infanzia – rispetto a cui anche Tove comincia a mostrare un atteggiamento ambivalente, ora che si avvicina il momento di lasciarsela alle spalle.
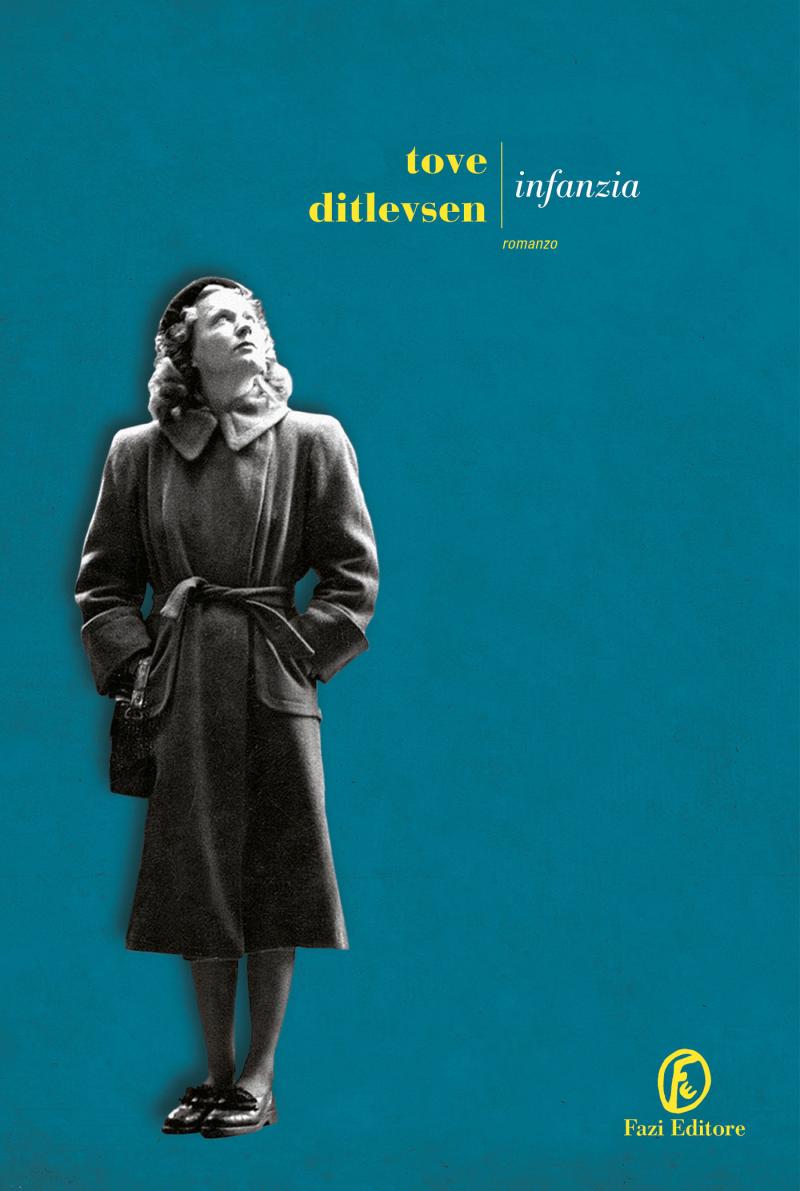
Ma Edvin piange anche la mancanza di privatezza, piange gli spazi comuni a cui la povertà ti obbliga – «non c’è uno straccio di angolo in cui si possa avere uno spazio per sé» – e non vede l’ora di poter andare a vivere da solo. Sulle prime il cedimento del fratello spaventa Tove, ma poi intravedere una breccia nel muro di distacco che Edvin aveva eretto intorno a sé la consola: «in questo momento voglio bene a Edvin più che in tutti gli anni nei quali è stato distante e prodigioso, bello e allegro.
Non era esattamente umano, da parte sua, non mostrare mai neppure un pizzico di dispiacere», dice. Poi esce dalla camera, va a contare le uova in dispensa, e decide di preparare al fratello uno zabaione – e non a caso sarà Edvin la prima persona con cui Tove condividerà la gioia di vedere pubblicata la sua prima raccolta di poesie.
In Gioventù lo scenario cambia: Edvin va a vivere da solo, e Tove comincia a lavorare. Il suo primo lavoro dura solo un giorno – il tempo che le serve per rovinare un pianoforte d’epoca nel tentativo di pulirlo. Ma per Tove gioventù significa soprattutto educazione sentimentale e intellettuale. Conosce il signor Krogh, un vecchio bibliofilo dalle mani affusolate, che la accoglie in vestaglia di seta e pantofole rosse offrendole il caffè in una cuccuma d’argento, ma soprattutto le presta i libri della sua immensa biblioteca; Tove gli fa leggere le sue poesie; lui le reputa «inservibili», ma al contempo le dice che «ha tutti i numeri per diventare poetessa» – e tanto basta per spingerla a migliorarsi.
Poco dopo conosce Erling, un ragazzo con cui esce tutti i sabati anche se sa di non amarlo – «i suoi abbracci non fanno vibrare neppure la più piccola delle mie corde», confessa. L’educazione sentimentale e intellettuale si rivela più burrascosa del previsto: il signor Krogh sparisce senza lasciare tracce, la storia con Erling finisce ancor prima di iniziare, il caporedattore del Socialdemokraten che le aveva promesso di valutare le sue poesie per la pubblicazione muore all’improvviso; Tove passa da un lavoro all’altro, da un ragazzo all’altro, va a vivere da sola affittando una stanza da una donna che inneggia a Hitler – il quale nel frattempo è diventato cancelliere e ha invaso l’Austria – ma le poesie continuano a fare da sfondo alla sua esistenza.
Finalmente conosce il vecchio e affascinante caporedattore del periodico Vild Hvede, Viggo F. Møller, che non solo accetta di pubblicarla, ma la aiuta anche a trovare un editore per la sua prima raccolta di poesie. Naturalmente Tove se ne innamora, subendo il fascino di quella maturità a cui tanto aveva aspirato – «la giovinezza è provvisoria, fragile e incostante. È fatta per lasciarsela alle spalle, non ha altro scopo che questo».
Ed è proprio qui che s’interrompe Gioventù, ma l’acme della Trilogia di Copenhagen deve ancora venire. Il volume finale, Dipendenza, in uscita nel 2023, in danese s’intitola Gift, parola che ha il doppio significato di matrimonio e veleno. I matrimoni per Tove saranno quattro, ma il veleno del titolo arriverà soprattutto con il terzo – quello col dottor Carl Rydberg, che prima la aiuta ad abortire, e poi la rende dipendente dal Demerol, un oppioide che comincia a iniettarle regolarmente per poi possederla e godere della sua passività.
Tove, dal canto suo, sa di essere innamorata del contenuto della siringa più che dell’uomo che le somministra la sostanza, di cui ormai non riesce più a fare a meno: costretta a letto, arriva a pesare trenta chili, e a sottoporsi a un’operazione che la rende sorda da un orecchio, pur di poter avere altre dosi di Demerol. La dipendenza da alcol e droghe si fa sempre più profonda, finché nel 1976, con un’overdose di sonniferi, Tove Ditlevsen si suicida: ha cinquantotto anni, quattro matrimoni e altrettanti divorzi alle spalle, ha avuto due figli, e scritto ventinove libri – romanzi, memoir, ma soprattutto poesie.
E leggere la Trilogia di Copenhagen fa capire perché Tove Ditlevsen vada ricordata soprattutto come poeta – non perché le sue poesie siano migliori o più famose dei romanzi e dei memoir, ma perché prettamente poetica è la distillata eloquenza della sua scrittura, l’obliquità del suo sguardo sul mondo, l’occhio per il dettaglio in grado di dispiegare un’intera esistenza. Ditlevsen ha raccontato la propria vita senza farsi sconti; ha raccontato le difficoltà di una donna che vuole scrivere, senza sottacere i bassifondi esistenziali della classe operaia, con uno stile crudo, asciutto, che riflette il disincanto di chi sa che precipitare nel baratro è sempre possibile, anche se «al mattino la speranza c’era».







