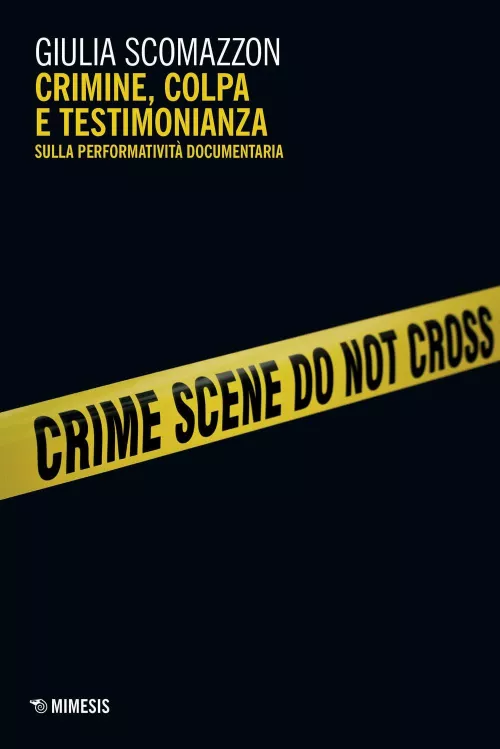Uno studio di Giulia Scomazzon / Crimine, colpa, testimonianza
I saggi sono come le caverne: l’ingresso spesso disincentiva e intimorisce, ma superato il primo ostacolo il percorso può rivelarsi ricco di sorprese. È il caso dello studio di Giulia Scomazzon, docente di Letteratura e Media alla UILM di Milano, che si presenta con un titolo aspro (Crimine, colpa, testimonianza. Sulla performatività documentaria, Mimesis 2021), ma diviene alla lettura stimolante su alcuni nodi cruciali. Come viene mostrato il crimine? Le sue rappresentazioni sono oggettive oppure influenzate da spinte che sollecitano a riflettere e a far riflettere? L’autrice non ha dubbi nell’optare sulla seconda alternativa, e in effetti è difficile averne.
Assistiamo innanzitutto alla crisi della rappresentazione oggettiva, quella descrittiva in cui realtà e irrealtà si aggrovigliano in una proiezione fantasmatica. La realtà si polverizza in un caleidoscopio di possibili soluzioni che decostruiscono le certezze e logorano ogni capacità di resistenza. La finzione sembra libera ma non lo è, non è più libera, bensì corrotta dall’esterno, diventando “futile, si muove nel vuoto, senza significati, ozioso segno lasciato nell’aria, sterile in quanto gratuito, rigido con la volontà di non collaborare al confuso intrico di significati, feroce astuzia di appartarsi” (Manganelli, Ancora concupiscenze, Adelphi, 2022). Nasce così un atto truccato in cui l’autore-realizzatore mostra la “sua” verità, forse nascosta dietro i fatti “come dietro il quadrante dell’orologio si nasconde il suo segreto meccanismo” (Barthes, “Il discorso di storia”, in Il brusio della lingua, Torino, 1988). E rimettendo in discussione l’idea di oggettività ogni forma di “realismo” è soggetto a usura.
Questa politica dell’irrealtà, per usare l’espressione di Mazzarella (Politiche dell’irrealtà, Bollati Boringhieri 2011), crea una conseguenza non solo teorica ma anche giuridica, tuttora sorvolata e quasi inesplorata. È il tema della tutela dell’identità personale, che non si presenta quando si affronta la realtà oggettiva, ricostruttiva, storica o autobiografica, perché le persone vivono nell’autenticità e non si possono lamentare di comparire. Viene alla ribalta invece quando ci si addentra nella costruzione della ‘fiction’ che non può, né deve incidere sulla reputazione o sull’immagine delle persone esistenti o esistite. Che dire allora di una rappresentazione, letteraria o filmica, in cui la combinazione spuria di quegli addendi, finzione e realtà, è palese e persino dichiarata? Di qui la difficoltà, talora l’impossibilità, di incasellare il genere cui il prodotto appartiene, e quindi individuare di quali tutele gode chi vi compare.
Questo prodotto ibrido, ondeggiante tra realtà ed irrealtà, si cala nella dimensione “performativa”.
Questo termine viene utilizzato fuori dall’ambito linguistico per designare l’opposto del ‘descrittivo’. Esso esprime la coincidenza del dire con l’agire, si manifesta quando la comunicazione è impegnata a ricercare verità immerse nei mutamenti storico-culturali, non falsa perché animata da lealtà e sincerità, orientata a disegnare fatti o eventi fluidi. In questo quadro un ruolo cruciale viene assunto dallo spettatore-lettore, chiamato in causa in modo sempre più deciso per tenere insieme la macchina del racconto.
Come nota l’autrice i due segmenti, la crisi dell’oggettività e la narrazione performativa, confluiscono nel documentario. Esemplificativo è il video sull’assassinio di George Floyd, ripreso e diffuso su Facebook da Darnella Frazier, testimonianza che prova la brutalità della polizia. Frazier non era alla ricerca di una verità universale e neutra, ma voleva mostrare un contenuto di verità come parte di una comunità consapevole dell’ingiustizia vissuta.
Negli ultimi anni il documentario ha visto scolorire i parametri precedenti ed ha coinvolto l’autore nell’esposizione dei fatti consapevole che l’obiettivo rimane l’indagine sul reale, purtuttavia con la consapevolezza che la verità non è unica, disponibile ad assumere un significato sociale recuperando aspetti bui o negati tra le pieghe della storia ufficiale.
L’illusione che il documentario potesse restituire la totalità del mondo era stata criticata già negli anni ’60 dai situazionisti guidati da Debord, e con lucidità lo aveva riaffermato Gianni Celati. Questi affermava che il documentario “afferra qualcosa di concreto, … ma non bisogna più considerarlo come qualcosa di chiuso, che sta al di sopra e che spiegherebbe tutto… il reale in realtà è un inciampo… in quanto è impossibile fare a meno delle nostre affezioni” (Bellizzi intervista a Gianni Celati, Doppiozero). È uno ‘scarto nella visione…uno dei pochi spazi di resistenza al modello di una fiction totalitaria chiusa a quanto può succedere, a differenza dei media e della televisione dove esperti e conduttori parlano con frasi prescritte (Riga 28). Illuminante è la storia di don Chisciotte che pone la questione della realtà rispetto all’immaginazione, del nuovo che spazza via il vecchio, cioè i romanzi cavallereschi. Succede però che proprio quelle fantasticherie arricchiscono e arricchiranno il senso del mondo.

Il documentario adempie a un’ulteriore, cruciale funzione, cioè la conservazione della memoria, in quanto ha la possibilità di riunire i vari elementi (storici, biografici, cronachistici) in un archivio dal doppio volto. Da un lato è un dispositivo “conservatore” che si oppone all’oblio, lottando contro l’autoeliminazione insita in ogni memoria storica. Dall’altro è un ponte tra quanto tramandato e quanto smarrito con il dimenticare. Mentre i documentari del passato, fondandosi sullo sguardo, privilegiavano il “Chi? Che cosa?”, quelli performativi si focalizzano sul “Come? Perché?”.
Non osservano per ricostruire, ma raccontano per non perdere la memoria contrastando il progressivo impallidirsi creato dalla storia. Se la spinta per conservare il passato è il timore del dimenticare, oggi la riproposizione in veste soggettiva si presenta attraverso la testimonianza. Ma quando e come la testimonianza è affidabile? Si apre così il delicato capitolo, cui il saggio accenna, del rapporto testimone-corpo, del come può un corpo lacerato divenire teste, del come può essere influenzato dal coinvolgimento emotivo (sul tema di recente Di Giovine, Dilemmi morali e diritto penale, Il Mulino, 2022 e il nostro “Il superstite, lo storico, il giudice”, qui). Il documentario sembra puntare all’“esemplarità” della memoria: il passato cerca di rivendicare collettivamente la giustizia (Todorov, Gli abusi della memoria, Napoli,1996), esorcizzando il rischio che la memoria di secoli oscuri diventi possesso esclusivo di chi ne ha vissuto il trauma, escludendo il resto della comunità.
Questa cornice si esalta con la rappresentazione del crimine. Esiste la cronaca nera nei giornali e nei media, esiste il “noir” con storie di morte, violenza e terrore, esistono le serie televisive, esistono le ricostruzioni di casi reali, ma quali obiettivi si propone questa rappresentazione? Quanto emerge dei problemi veri della giustizia? La tv isola il crimine, lo analizza travasando con una continua emorragia le informazioni dal giudiziario al giornalismo, mostra l’ansia per l’imprevedibile e individua nella soluzione certa dei casi la sicurezza da raggiungere. Le serie poi creano una distanza dalla ricostruzione del tribunale costruendo un universo narrativo selvaggio influenzato dalle esigenze proprie del mezzo usato. Sono animate spesso da una sorta di ‘pentimento’ per “lo scatenamento infernale e morboso con cui la tv si è buttata su quelle sciagure” (Grasso, “Un pentimento per gli orrori della tv degli orrori”, La lettura, 28-11-2021). Con la riscrittura dei casi reali promossa da Truman Capote, la morsa delle regole processuali si allenta, sorgono gli eroi o si esaltano le vittime.
Si costruisce un universo credibile in bilico tra giornalismo e intrattenimento, ma nella sostanza con margini di ambiguità. La narrazione viene estratta dalla cornice sociale, vuole ingenerare sicurezza, placare la paura, canalizzare l’ansia anche con l’influsso della scienza (vedasi ad esempio la serie CSI) proponendosi come anestesia. Talora compare una sorta di fascinazione per la violenza e lo sdegno, il dolore diviene oggetto di consumo, la gogna si propone con enfasi nelle vesti del giustizialismo. Si attribuisce la colpa senza mettersi in discussione, e soprattutto mescolando quella da reato con quella da peccato, come osservato di recente (Premoli, Di chi è la colpa, Mimesis, 2021). Viene proposta una sorta di deresponsabilizzazione collettiva in quanto il colpevole è uno solo, non appartiene alla collettività. L’atto delittuoso, vissuto come male imponderabile, alimenta il desiderio di punizione verso l’inquisito nei cui confronti si apre la caccia e al quale si imprime lo stigma del delinquente.
Così ci si pone una domanda sul giudiziario: il messaggio è esauriente? La verità si sposa con la giustizia? Cosa aspettarsi da quel sistema? Molte le risposte e quella dell’autrice è netta: la colpa e il delitto sono questioni politiche (p.125), La risposta della giustizia, osserva l’autrice, deve intervenire nella quotidianità con la minor afflizione possibile incrementando quella riparativa, attraverso un nuovo patto sociale che renda più visibile la capacità di giudizio con l’intervento dello spettatore-lettore che diviene soggetto sociale, sensibile, stimolato a prendere posizione. L’obiettivo è la ricerca della verità attraverso un’azione testimoniale sui meccanismi interni della giustizia, smascherandoli. Sempre però con spirito propositivo, lealmente, responsabilmente, senza usare le unghiate della delegittimazione perché, aggiungiamo noi e non solo noi, il rispetto per le istituzioni è uno degli elisir di lunga vita per la collettività.
Giulia Scomazzon, Crimine, colpa, testimonianza. Sulla performatività documentaria. Mimesis 2021