Quid animo satis? / Dannato cibo
Se con una bacchetta magica facessimo scomparire dalla nostra società tutti i luoghi dove si propone del cibo preparato, probabilmente assisteremmo a una sorta di desertificazione dei centri storici, delle vie eleganti, delle piazze più belle, di tanti deliziosi paesini. Venendo meno l’istanza alimentare iperbolica della nostra epoca scopriremmo traumaticamente che non pensiamo quasi ad altro che al cibo, anzi, al consumo di cibo. Una vera damnatio ad cibum che stentiamo sempre più a vivere come fisiologia.
Mangiare è un’azione primaria, ma che, a un certo punto del nostro percorso evolutivo, superato il confine della funzione di nutrimento, oggi si trasformasse quasi in un vezzo comportamentale, in un pervasivo arzigogolo gastronomico, era difficile da prevedere. Cibo-schifezza ovunque (nelle macchinette dei corridoi delle scuole, degli ospedali, nelle sale d’attesa) e birignao gourmet: guai se non sai abbinare una pietanza a un vino, attenti alle cremosità, occhio agli aromi, se non prenoti per tempo non è possibile trovare un tavolo nei nuovi templi della religione alimentare per la preghiera laica del sabato sera. La nozione di cibo è divenuta in qualche modo onnicomprensiva perché dentro al cibo trovano posto i temi della salute, il gusto, l’etnografia, l’economia, la spiritualità, ovviamente la culinaria con tutta la tecnologia che vogliamo. Ogni cosa sembra portare al cibo. E qui in Italia tutto ciò è un vero e proprio trionfo, anche grazie alla carica mediatica (chef di qua e chef di là) che il fenomeno continua a ricevere. Esemplare su questo Gastromania di Gianfranco Marrone (Bompiani, 2015).
Il food system orienta i consumi vendendoci l’illusione di mangiare meglio, e nonostante ciò uno dei più grandi problemi che abbiamo rimane innanzitutto quello di mangiare meno, in generale. La questione è enorme, anzi “molto enorme” e si mostra plasticamente nella possente semantica del grande obeso, figura sacrificale che dal secondo dopoguerra in poi (l’epoca dei babyboomers) descrive l’effetto ipertrofico del cibo divenuto un preciso marchio delle nostre società. Il cibo da linfa è diventato veleno, e non è il cibo in sé la fonte dei problemi, naturalmente (a suo tempo ho ragionato su questo atteggiamento in La bici nella cyclette, qui). Su questo torniamo dopo.
Le persone declinano la loro individuale versione della vita come possono, difficilmente come vogliono. E quando il cibo ti assale, te proprio te, come un nemico, si innesca una specie di dinamica bellica, di lotta per l’annientamento dell’avversario che giocoforza condiziona ogni aspetto della tua esistenza. La dannazione del cibo ti impregna e ti costringe a occupartene. È quello che è accaduto a Luca Doninelli il quale, vittima della grande obesità, in La dieta sono io (La nave di Teseo, 2019) ha provato a raccontare una specie di miracolo di cui è stato protagonista. Come ho perso 50 chili. Definitivamente dice il sottotitolo, ed è proprio quel “definitivamente” che probabilmente caratterizza la sua esperienza. Il fatto che egli sia uno scrittore navigato (ricordo almeno Le cose semplici, Bompiani 2015), capace cioè di ogni sfumatura di pensiero, rende il suo racconto particolarmente efficace proprio perché non è, va da sé, un report tecnico, ma il resoconto di un’esperienza di sofferenza vissuta in prima persona, quella che si usa definire una “autopatografia” (ulteriore episodio di una letteratura fiorita anche in Italia a partire dagli anni Novanta).
Quando pesi 140 chili, dice Doninelli, il corpo scompare, non appartieni più “all’assemblea dei corpi”, l’obeso è solo e, “nella sua solitudine senza corpo, sbircia il mondo attraverso la finestra degli occhi”. L’obesità significa sottrarsi alla volontà di affermazione nel gioco del potere sociale, del dominio sugli altri. “L’obeso è un individuo che odia sé stesso” e per tornare a volersi bene deve cercare di capire le ragioni di questa autodenigrazione. È un fatto, racconta Doninelli, che “un giorno mandai affanculo dentro di me una persona che avevo creduto di dover ossequiare. […] Da questo atto ricevetti un senso di liberazione veramente piacevole, come un soffio di aria fresca. […] Dopo un mese iniziò la mia dieta.” (p.43)
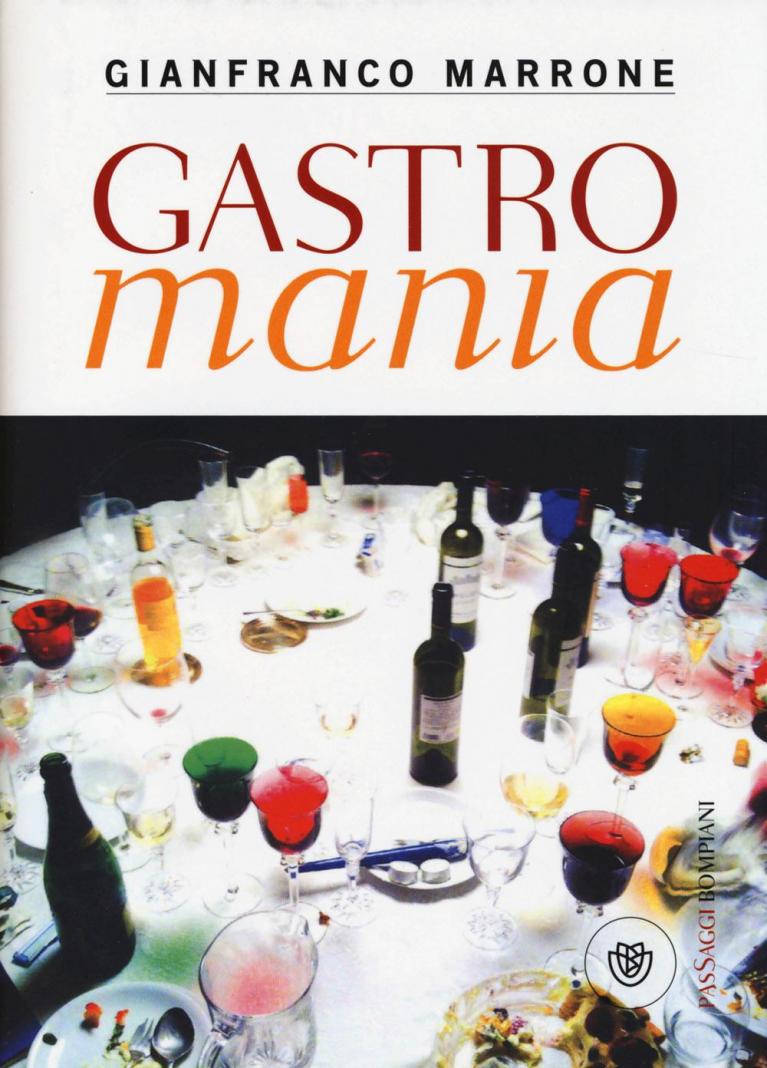
Il problema prima era di sradicare il vizio, la dipendenza e l’idea che la grassezza fosse addirittura un tratto di distinzione, se non di superiorità. In un’intervista Doninelli racconta di quando stroncò il Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi: “Ebbi attacchi enormi, mi diedero del fascista. Capii che l’avevo colpito perché rappresentava l’establishement intellettuale. Da uomo-contro avrei dovuto essere felice degli attacchi. Invece, capii che ero frustrato, che, come diceva Flannery O’Connor, non bisogna dire di no, bisogna fare di no. […] Invece l’invidia aveva fatto esplodere la mia rabbia, portandomi pessima fama” (Corriere delle Sera, 20 marzo 2019). Anche di questo equivoco, di radice cartesiana, Doninelli afferma di essersi dovuto sbarazzare, da raffinato intellettuale, per superare “l’insoddisfazione, l’amarezza, la tristezza” del suo quotidiano strettamente connesse a uno smisurato senso di colpa. Tra depressione ed euforia, in un andamento bipolare, dopo riflessioni incessanti sui rapporti umani e autoanalisi, con l’aiuto delle “finestrelle” che si aprono sul reale, Doninelli giunge all’intuizione dirimente, realizza che “noi siamo qualcosa anche al di fuori delle nostre considerazioni. […] Noi siamo qualcosa a prescindere dal nostro abbattimento e dalla nostra euforia, siamo qualcosa di più dell’una come dell’altra cosa.” (p.73) Da qui inizia, grazie anche a una dieta (quella chetogenica) e a una dietologa “giusta”, il percorso di uscita, di liberazione dalla cosa più difficile, il fatto che “a noi il male piace” e “finché nel male ci si sta bene, è assai improbabile che si possano perdere 50 chili in modo duraturo. Invece, nel male ci si deve star male. Tutto comincia da qui.” (p.81)
Le dimensioni del corpo non sono più l’ossessione della testa, il corpo torna ad essere linguaggio e “noi torniamo a essere il nostro corpo”. Non basta: “Tanti chili persi, tanta fatica fatta mi hanno messo di fronte a una nuova evidenza: che il corpo è più intelligente della testa. È più rapido, elabora meno, arzigogola meno, predilige il presente al passato prossimo e il passato prossimo a quello remoto. Il corpo è più illuminista della mente, più pragmatico, preferisce Hemingway a Proust, la conoscenza diretta alla rimemorazione.” (p.123) E il dimagrimento diventa eros, quello che ci fa piacere a noi stessi e dunque agli altri. Ritorna il desiderio. Doninelli mostra che il rimedio non sta fuori di noi, ma che il rimedio siamo noi: la dieta sono io, per l’appunto.
Ma il cibo è anche linguaggio. Quando non ruba la scena è un prezioso co-protagonista delle nostre vite. È ciò che si vede in Cibo di Helena Janeczek (ora ripubblicato, parzialmente riveduto, da Guanda, 2019). Un libro, un romanzo, che io vedo in singolar tenzone con quello di Doninelli: La dieta sono io alle prese con le patologie generate dal cibo, l’altro con le sue tempeste emotive. Janeczek ci dà un’intensa visione del mondo “fatta con il cibo”. Senza affettazioni gastronomiche, con delicatezza e leggerezza, l’autrice racconta le vicende dell’Europa post-bellica con la voce (molto autobiografica) di Elena, tedesca ebrea di origini polacche giunta in Italia a Milano dove vive ormai da più di trent’anni, e Daniela, un’estetista di Treviso, anche lei a Milano per lavorare, anche lei alle prese, come Elena, con il problema della dieta, del corpo disubbidiente. È uno scambio di “esperienze dietetiche” che contiene le storie delle loro vite. Amicizie vecchie e nuove sono abbinate a una pietanza, a una ricetta, le atmosfere di famiglia del sabato ebraico con l’aringa salata, i würstel e krapfen lassù in Baviera con Ulrike Seitz, l’anoressica che aspirava alla perfezione, la Praga di Ružena Perl, l’amica disperatamente cicciona ancora scossa dal trauma della Primavera di Dubcek, il pane e burro con Andreas l’irraggiungibile. Atmosfere, profumi, umori, sentimenti. Per esempio la nostalgia struggente di Teresa Aiace che a Napoli in venticinque anni è tornata una sola volta:
“Però, quando estrae una mozzarella dal sacchetto di plastica per fartela mangiare con l’insalata di pomodori, ti spiega che questa, a Napoli, non si sognerebbero neanche di chiamarla mozzarella, non la metterebbero neppure sulla pizza, perché a Napoli usano solo quella di bufala o il fiordilatte, il fiordilatte che, come dice il nome stesso, sa di latte, di latte fresco e non di plastica, e quando affetta un salame sostiene spesso che quel salame puzza d’aglio, perché al Nord li strofinano d’aglio, i salumi, per conservarli, mentre il salame di Napoli è fatto solo di carne sale e pepe in grani, e non so quante volte, servendomi cime di rapa, mi abbia raccontato che i friarielli crescono nei terreni fertili del Vesuvio e te li vendono, a Napoli, a piccoli mazzetti solo di fiori e foglioline, quasi mazzi di fiori. […] Ma se, cogliendo l’occasione, la interrompevamo nel pranzo e nei ricordi buttando la domanda, cosa ne direbbe se andassimo a fare un giro a Napoli, ci rispondeva subito che Capri era magnifica e anche la costiera amalfitana meritava di essere visitata. Così, di Napoli, per lunghi anni ho saputo che esiste un posto dal nome Porta Capuana, dove si può assaggiare il polipo bollito e bersi il suo brodo di cottura e altri, Mergellina, Marechiaro, dove si trovano la maggior parte dei ristoranti di pesce della città, e infine anche il quartiere chiamato Vomero dove non c’era altro che la sua casa.” (pp.172-173)
È l’“uso qualitativo” del cibo che colpisce nel libro di Janeczek, un vero linguaggio per la conoscenza, non del limite e della sofferenza. Questo è il punto: tutto funziona bene quando ci si muove tra la sensualità del cibo e tra i suoi rimandi culturali, storici. Viceversa, l’economia del cibo lo ammazza (e ti ammazza), lo trasforma in sottocultura quantitativa, un tanto al chilo, come si dice. Ed è anche una questione di quantità di comunicazione intorno al cibo, una tempesta informativa incessante, che ne attutisce la sostanzialità. Proprio come l’iper informazione globale ci rende più sprovveduti.
Riproporrei, in chiusura, la domanda di San Francesco: Quid animo satis? (che cosa ci soddisfa veramente?) che anche Luca Doninelli si pone a un certo punto del suo libro, e ne farei uno spunto radicale di riflessione, proprio per tornare “alla radice della nostra cultura”.







