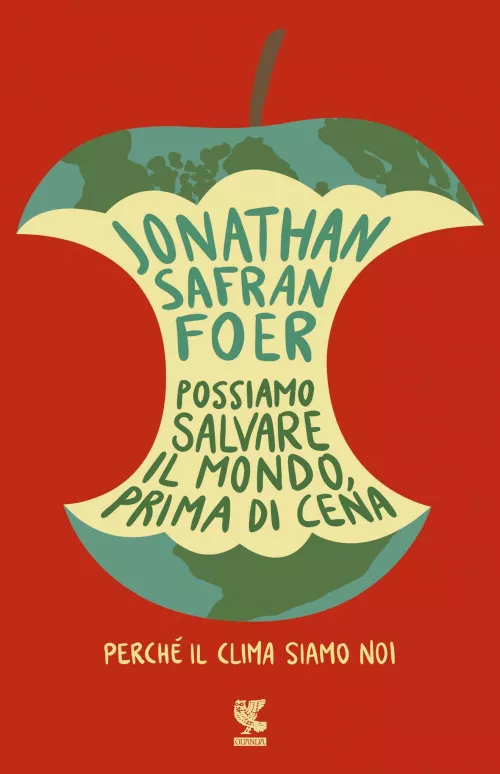Non un augurio ma un impegno / Dare inizio
Non sono tra quanti considerano il 31 dicembre un giorno come gli altri, ne vivo anzi, anche emotivamente, la forza simbolica di rito di passaggio tra ciò che termina e ciò che ha inizio (quest’anno esteso al primo decennio del XXI secolo). E come in occasione dei compleanni, la rammemorazione degli avvenimenti che, in maniera largamente imperscrutabile, inanellandosi mi hanno condotto proprio dove sono, serve a chiedermi verso dove intendo orientarmi. Insomma la mia attenzione – e non semplicemente la mia aspettativa – è rivolta molto di più su ciò che potrebbe avere inizio che su ciò che termina. Ma non si tratta né della negazione dell’irriducibile caducità di tutto ciò che esiste né dell’illusoria speranza che l’anno nuovo, per intrinseche proprietà magiche, spazzi via da solo tutto quello che non va, come se il nuovo, di per sé, significasse cambiamento, miglioramento, progresso. Conosco bene la lezione del venditore di almanacchi di Leopardi; il fatto è che sposo appieno questa riflessione di Hannah Arendt:
“Se lasciate a se stesse, le faccende umane, possono solo seguire la legge della mortalità, che è la più certa e implacabile legge di una vita spesa tra la nascita e la morte. (…) il corso della vita umana diretto verso la morte condurrebbe inevitabilmente ogni essere umano alla rovina e alla distruzione se non fosse per la facoltà di interromperlo e di iniziare qualcosa di nuovo, una facoltà che è inerente all’azione, e ci ricorda in permanenza che gli uomini, anche se devono morire, non sono nati per morire ma per cominciare”. (H. Arendt, Vita activa, Bompiani, Milano, p. 182).
La filosofa che fu anche amante di Heidegger, ne rovescia così il famoso motto esistenziale: “essere per la morte” diventa “essere per la vita”, per il rinnovamento della vita, per la creazione, cioè, delle condizioni affinché ciò che sinora non si è mai dato possa darsi, purché si dia nell’ambito del possibile. Naturalmente, come insegnava Epicuro, “la meditazione sulla vita e quella sulla morte, sono la medesima cosa” e se si vuole preparare il terreno a nuove possibilità d’essere bisogna innanzitutto accettare di lasciar andare ciò che ne impedisce l’avvento. Lo ha scritto con profonda chiarezza Clarissa Pinkola Estés:
“il grande lavoro che ci aspetta è quello di imparare a comprendere quanto attorno a noi e dentro di noi deve vivere, e che cosa deve morire. Il nostro lavoro consiste nell’apprendere il ritmo di entrambe le cose, consentire a ciò che deve morire di morire, e a ciò che deve vivere di vivere”. (C. Pinkola Estés, Donne che corrono coi lupi, Frassinelli, 2009, p. 33).

Si vede qui l’assunzione di responsabilità legata alla scelta di adoperarsi affinché possa realmente darsi un inizio nuovo e non soltanto un nuovo inizio, il suo rinnovarsi impersonale.
Gli studiosi della filosofia della Grecia antica hanno posto molta enfasi sull’invito delfico a conoscere se stessi (gnóti sautón, nosce te ipsum), ma come ha mostrato bene Michel Foucault, la conoscenza di sé, non era che l’inizio di una più vasto progetto che ruotava attorno alla cura di sé, come pratica che “prepara alla compiuta realizzazione della propria esistenza” ossia alla piena fioritura delle sue più proprie possibilità d’essere. (Michel Foucault, Tecnologie del sé, Bollati Boringhieri, 1992, p. 27).
L’importanza degli studi di Foucault, per sua stessa ammissione ispirati da quelli di Pierre Hadot, sta nell’evidenziare come questa cura che mira allo sviluppo delle nostre potenzialità d’essere – che allora secondo un modello di saggezza che varia da scuola a scuola e che oggi potrebbe invece essere messa al servizio del proprio processo di individuazione – fosse incentrato in una serie di esercizi spirituali, o tecnologie della cura di sé, che avevano lo scopo di ridurre la distanza tra il nostro ideale, d’essere o di azione, ed il nostro reale modo di essere o agire.
Foucault ne parla come di una vasta gamma di esercizi “che permettono agli individui di eseguire, coi propri mezzi o con l’aiuto degli altri, un certo numero di operazioni sul proprio corpo e sulla propria anima [psiche] – dai pensieri, al comportamento, al modo di essere – e di realizzare in tal modo una trasformazione di se stessi allo scopo di raggiungere uno stato caratterizzato da felicità, purezza, saggezza, perfezione”, ecc. (ibid, p. 13). Naturalmente simili finalità risultavano spesso superogatorie, ossia eccessive ed irraggiungibili, ma ciò che conta è che i fini che si ponevano non venivano mai concepiti come legati “semplicemente” a un cambio di mentalità, a una diversa concezione delle cose, a un mero incremento di conoscenza ma al lavoro su di sé che il soggetto intraprendeva disponendosi a divenire ciò che poteva, e voleva, essere, allenandosi a essere una persona migliore o, quanto meno, più vicina ai propri ideali. Un compito ancora possibile e attuale che Pierre Hadot amava sintetizzare con una citazione di Friedmann:
“fare un proprio volo ogni giorno! Almeno un momento che può essere breve, purché sia intenso. Ogni giorno «un esercizio spirituale», da solo o in compagnia di una persona che vuole parimenti migliorare. Esercizi spirituali. Uscire dalla durata. Sforzandosi di spogliarsi delle proprie (…) vanità, del desiderio di rumore intorno al proprio nome (…). Fuggire la maldicenza. Deporre la pietà e l’odio. Amare tutti gli uomini liberi. Eternarsi superandosi.
Questo sforzo su di sé è necessario, questa ambizione giusta. Numerosi sono quelli che si immergono interamente nella politica militante, nella preparazione della rivoluzione sociale. Rari, rarissimi quelli che, per preparare la rivoluzione, se ne vogliono rendere degni.” (G. Friedman, La poissance et la Sagesse, cit in Pierre Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica, Eianudi, 1998, p. 29.)
La differenza tra un augurio e un impegno sta tutta qui: nel disporsi a incarnare, nell’esercitarsi ad incarnare, il cambiamento che vorremmo vedere realizzato, ossia, come spiega Paolo Bartolini, “nell’attivarsi per tradurre in atto un potenziale di vita diffuso, estremamente creativo e ancora informe”, che senza la nostra personale attivazione, la nostra cura, non si tradurrebbe mai in atto (Paolo Bartolini, Desiderio illuminato e spiritualità laica, Essegi edizioni, 2017, p. 30).
Se ne trova una convincente traccia nell’ultimo libro di Jonathan Safran Foer, Possiamo salvare il mondo, prima di cena. Perché il clima siamo noi, Guarda, 2019.

E non è forse un caso che il libro si apra con quello che potremmo chiamare l’esercizio filosofico dello sguardo d’insieme – attraverso uno sguardo dall’alto sul quale torna ripetutamente – inaugurato dai pitagorici e praticato con particolare scrupolo dagli stoici (ne ho parlato nel mio Vivere la filosofia, Mursia, 2014) e che prosegua con una reiterata disputa filosofica. Il libro di Foer infatti non si propone di informare sulle ragioni per le quali dovremo attivarci per salvare il pianeta né, solamente, su come dovremmo farlo; si pone piuttosto come una disanima, scritta con metodo biografico, delle ragioni per le quali un cambio di mentalità e un’informazione corretta su questi temi non bastino, non risultino cioè capaci di indurre da soli a cambiamenti personali davvero incisivi e duraturi.
Il libro è, tra le altre cose, un’incredibile fucina di esempi e argomenti storici contro quella malafede, di sartriana memoria, che ci fa sentire impotenti o inevitabilmente destinati a fallire o ad essere irrilevanti, ricordandoci che “nessuno se non noi distruggerà la terra e nessuno se non noi la salverà”. L’impegno che intende spronarci ad assumerci nasce non solo da un buon esame di realtà – negli anni in cui era ormai impossibile non sapere le cause dell’inquinamento ambientale e la gravità delle sue conseguenze abbiamo incrementato le cattive condotte e le ragioni del suo aggravarsi – ma dalla capacità di credere, credere davvero a quello che sappiamo ma che, evidentemente, non si radica nelle nostre coscienze, non determina un cambiamento nel nostro stile di vita, non ci porta a rivedere le nostre priorità. La conclusione è la stessa alla quale giunsero gli insegnamenti della filosofia antica: occorre riconoscere e adottare una qualificazione etica del vero, che non si limita a certificare i dati – ciò che è – ma si attivi, si eserciti, per orientare l’essere verso il poter essere e il dover essere.
Il passo di Hannah Arendt dal quale abbiamo preso le mosse riconosceva all’azione umana la capacità “miracolosa di preservare il mondo dalla sua naturale rovina”, in virtù di nuovo inizio e invocava un nuovo patto, tra generazioni, legato “alla facoltà di fare e mantenere delle promesse” (op. cit., p. 129). Non un augurio, dunque, ma un impegno, non l’esito non di uno sforzo titanico ma di un processo di micro fedeltà ai nostri valori, dell’esercizio di uno stile di vita giusto, che abbracci con uno sguardo d’insieme, la vita del pianeta e se ne faccia carico per la parte che gli compete nella consapevolezza che, per usare un’efficace immagine di Foer, “noi siamo il diluvio e noi siamo L’arca”.