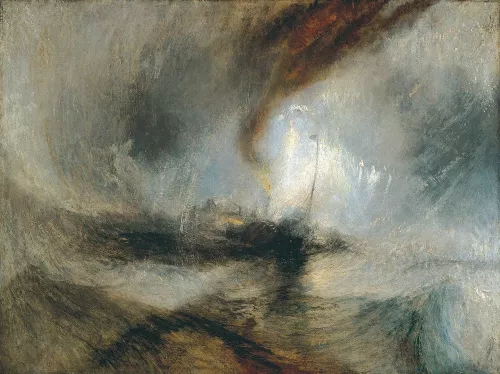Speciale
Un verso, la poesia su doppiozero / Osip Mandel`štam, Ho appreso la scienza degli addii
È il primo verso, qui riportato in una sua versione letterale, di Tristia, una delle più note poesie di Osip Mandel`štam, appartenente alla raccolta omonima, del 1922. Tristia è la seconda stazione dell’opera poetica di Mandel`štam, dopo Kamen’ (Pietra), volume pubblicato nel marzo del 1913.
In questa poesia, Ovidio e l’esilio sono l’ordito di un arazzo che, in quattro strofe di otto versi ciascuna, seguendo il movimento metrico di una pentapodia giambica, dà figurazione al sentimento dell’addio: con le immagini della partenza, dell’amara vigilia, della soglia che è al di qua della tenebra, degli emblemi che dicono il passaggio al nuovo giorno. Un giorno che dischiude il cammino e la solitudine, il rammemorare e il riconoscere. Riconoscere è custodire il fuggitivo nella presenza di un’immagine, quel che è perduto nel sapere della lontananza. Riconoscere è accogliere quel che è assente, accoglierlo in un verso, nella dolcezza provvisoria e tuttavia intima di un verso, della sua musica.
Nel primo movimento della poesia, alle immagini che salgono dalla lettura dei Tristia di Ovidio, in particolare dell’elegia I, 3 (“Cum subit illius tristissima noctis imago”), si sovrappongono i motivi figurali che vengono dalla lettura di Tibullo, di uno dei suoi Carmina, dove il poeta latino ricorda il tempo che precedette la sua partenza per l’Oriente. Ma per un poeta come Mandel`štam ogni riferimento classico è sorgente di un’irradiazione nel teatro della propria interiorità, un’irradiazione che poi si addensa in immagini-cristallo, si trasforma in stille lucenti di un sentire per metafore, di un pensare per figure-suono. Il suonosenso del dire poetico – il dantesco “legame musaico” – per Mandel`štam è il respiro stesso della poesia. Per questo, portare quella sua poesia in un’altra lingua, è sempre un’impresa d’azzardo (il che in misura diversa si può dire di ogni poesia ospitata in un’altra lingua). Ecco la prima strofe, nella traduzione (einaudiana) di Remo Faccani, che con eleganza accoglie il verso russo, la sua armonizzata scansione, in una sequenza poetica in cui l’endecasillabo italiano è la misura di base, il basso continuo (da qui muove ogni altra dilatazione sonora):
Io so la scienza dei commiati, appresa
fra lamenti notturni a chiome sciolte.
Stan ruminando i buoi, dura l’attesa:
ultim’ora di veglia delle scolte
cittadine. E mi piego al rito della notte
del gallo, quando – in spalla il carico di strazio
del viaggio – guardavano lontano umidi occhi,
e pianger di donne al canto si univa delle muse.
L’apprendimento dell’addio è congiunzione dell’esperienza immaginativa dischiusa dai classici della poesia – la notte ovidiana, le voci, i pianti – con la propria esperienza del distacco, della separazione da una casa, da una terra, da un tempo. L’addio di Ovidio, che il poeta russo evoca con la sua propria voce e in un altro tempo, è il passaggio alla condizione dell’esilio, cioè a quello stato in cui ogni appartenenza, per dir così, si derealizza, si fa astratta, il passato naufraga nell’oblio, a stento arginato dai sussulti di nostalgia, e il futuro è una nuvola nera, sempre in fuga (María Zambrano scriverà pagine molto belle su questa situazione dell’esiliato: sospensione nebulosa dell’io, esperienza dello sradicamento, difesa della sola patria che resiste nell’abbandono, cioè la propria lingua).
La scienza degli addii che il poeta russo dice di avere appreso è divenuta arteria e vena del suo sentire: la poesia fino all’ultimo sarà la replica – musicale, impetuosa e dolce insieme – a questa scienza. Una scienza che sarà sapere del corpo, ferita mai rimarginata. La lettura di Dante, poeta dell’esilio, una lettura assidua, innamorata, corporea e immaginosa insieme, accompagnerà il poeta lungo il suo cammino, fino ai giorni estremi della deportazione. Il lamento per l’abbandono – le donne “a chiome sciolte”, il loro piangere nell’alba – è contiguo all’aprirsi di quiete scene che mostrano un mondo rurale e una presenza animale: il qui e l’altrove si congiungono. Alla pena dell’attesa e alle immagini che annunciano la sofferenza del viaggio, risponde una presenza, quella del gallo, che riappare, col suo “strepito”, nella seconda strofe:
Chi, alla parola “commiato”, sa quale
distacco giungerà per noi fra poco,
che cosa presagisce lo strepito del gallo
mentre la fiamma arde sull’acropoli,
e perché all’alba di una vita nuova,
mentre il bue rumina pigro nell’andito,
il gallo, araldo della vita nuova,
sulla cinta muraria le ali sbatte?
I commentatori evocano, per quel gallo che appare come ”araldo del giorno” – presente anche negli Amores di Ovidio – l’inno di Ambrogio (Ad galli cantum) e il passaggio evangelico in cui Pietro rinnega Gesù, “prima che il gallo canti”, ma forse per questa funzione del gallo-emblema che con l’annuncio dell’alba indica un nuovo tempo, un altro tempo, si può richiamare una figura della tradizione ebraica, propriamente del Talmud, il tarnegòl bar, quel “gallo silvestre” della leopardiana operetta morale; un gallo il cui inno, dice il narratore, “si è trovato in una cartapecora antica, scritto in lettera ebraica, e in lingua tra caldea, targumica, rabbinica, cabalistica e talmudica”.
Una fonte, questa evocata da Leopardi, forse più familiare alla mitografia ebraica che ha agito nella formazione fantastica di Mandel`štam.
Nelle altre due strofe si riverbera ancora la luce del primo verso, cristallizzandosi in figure di una “scienza degli addii”, e mostrando la raggiera dei gesti e degli accadimenti il cui suono lo si ode da una lontananza estrema. Le immagini che giungono dall’elegia romana (qui, in particolare da Tibullo), e le scene quasi da bassorilievi di un’”urna greca”, sono osservate attraverso il vetro di un’aspra transitorietà : “che povera è la lingua della gioia”. Ma nel distico che chiude la terza strofe, è il tempo che si mostra, il tempo con la sua onda di sparizione e ritorno, con la spina dell’irreversibile e il lampo di una dolcezza che è riconoscimento del già stato, presenza interiore di quel che più non c’è:
Tutto fu in altri tempi. Tutto sarà di nuovo.
Solo ci è dolce l’attimo del riconoscimento.

Opera di William Turner.
È solo un breve passaggio nel meraviglioso universo poetico di Mandel`štam. Un poeta che nei suoi versi – in quelli pubblicati in vita e in quelli postumi (i Quaderni di Voronež, i Quaderni di Mosca) – e nelle sue prose (tra queste, Viaggio in Armenia, Sulla poesia, Conversazione su Dante), ha congiunto pulsione analogica con invenzione musicale, passione della lettera, del suo suono, della sua autonomia, con evidenza luminosa delle metafore. I versi di Mandel’stam mostrano come il “demone dell’analogia” – quello dell’omonima prosa di Mallarmé – possa non disperdersi nella vaghezza e nell’estenuazione di una certa tradizione simbolista, ma agire, con l’incandescenza della visionarietà e il nitore assoluto dell’immagine, per l’edificazione di una lingua che sia davvero vivente, forma propria del sentire: la provenienza del poeta russo dal movimento dell’“acmeismo” ha lasciato questi segni, ha dato impulso a questa ricerca poetica. A proposito della scrittura di Mandel`štam Angelo Ripellino annota: “Nei saggi e racconti, come nelle poesie, egli anela a restaurare la corposità degli oggetti, di cui l’impressionismo floreale aveva annebbiato i contorni, e a connetterli in densi incastri. Quasi nell’ansia di sdrammatizzare e rapprendere ciò che fluisce, dà alle parole spessezza, cubicità, una sostanza cristallina infusa di luce”.
In questa ricerca poetica sta anche il dialogo di Mandel`štam con la poesia dei suoi amici come Marina Cvetaeva, Boris Pasternak, Anna Achamatova”: un dialogo che era comune esperienza del tragico – il tragico di un’epoca – e della poesia come lingua che nella nebbia di quel tragico disegna i contorni e le figure e i suoni di un tempo altro. Molti anni dopo, nel 1957, Anna Achmatova in una poesia dedicata al poeta di Tristia, rievocherà la comune “insanguinata giovinezza”:
Oh, com’era acuto l’aroma di un garofano
sognato chissà quando laggiù.
[…]
Sono le nostre ombre che balenano
sulla Nevà […]...
(traduzione di Michele Colucci).
Si diceva del grande amore di Mandel`štam per la Commedia dantesca. Chi legge Conversazione su Dante (o Discorso su Dante, come è stato anche tradotto) – pagine dettate dal poeta alla moglie Nadežda Jakovlevna, durante un difficilissimo soggiorno in Crimea nella primavera del 1933 – non può non sovrapporre a quell’esegesi ardente, impetuosamente affettiva e dolcemente inventiva della Commedia, le figure della stessa poesia di Mandel`štam.
La posizione del poeta dinanzi a Dante (ma anche quella che egli ha avuto dinanzi ad altri amati poeti italiani, come Petrarca, di cui tradusse alcuni sonetti, Ariosto, al quale dedicò alcune composizioni, e Tasso) muove dall’idea che è poesia quel che non può essere parafrasato: eccedenza della parola e del senso e dell’immagine.
La poesia di Dante è per il poeta russo, “un tappeto di molteplici orditi”, di “metafore ramificate”, la cui “incandescente cinetica” incanta e appassiona il lettore. Le immagini della navigazione – il flusso d’onda, le impennate, i bordeggi improvvisi – possono servire a definirne l’energia linguistica e fantastica. La Commedia come uno splendido “trattato della metamorfosi”.
Il passo, il passo del cammino nell’oltretomba, è il principio della sua prosodia. Una prosodia che mostra la fisica, corporea, sonorità di una lingua musicale. La Commedia è un meraviglioso “poliedro”, “una figura cristallografica, un solido attraversato da un’incessante tensione generatrice di forme” (sto citando dalla traduzione di Serena Vitale). E dunque: “Il futuro dell’esegesi dantesca sta nelle scienze naturali, quando avranno raggiunto la necessaria raffinatezza e sviluppato la capacità di pensare per immagini”. La disposizione esegetica dinanzi a Dante chiede inoltre di leggere quella grande poesia in rapporto al nostro presente. Perché i versi del poeta fiorentino sono “congegni lanciati per captare il futuro”. Questo potremmo dire dei versi stessi di Mandel`štam. Versi che, accogliendo le ferite della propria epoca, giungono a noi anche con le risonanze e concordanze incontrate lungo il loro cammino: tra queste, l’ascolto di un poeta come Paul Celan, che tradusse il poeta russo in tedesco.
La passione della poesia fu costretta a confrontare il suo libero respiro con le nebbie e con il terrore di un clima politico come quello instaurato dal sistema staliniano (a Stalin, “il montanaro del Cremlino”, Mandel`štam aveva dedicato un pungente epigramma nell’autunno del ’33). È quel che accadde a un’intera generazione di poeti, forse la più splendente e fervida e generosa che la nostra modernità abbia avuto.
Arrestato all’alba del 2 maggio del 1938, Mandel`štam viene poi condannato alla deportazione, subisce durissime dislocazioni, infine è internato in un “campo di transito” nei pressi di Vladivostok, in attesa di essere condotto in un lager della Kolima. Muore sul finire di dicembre dello stesso anno. Si diffonde nel mondo del Gulag la raffigurazione del poeta che consola i detenuti recitando le sue traduzioni da Petrarca.