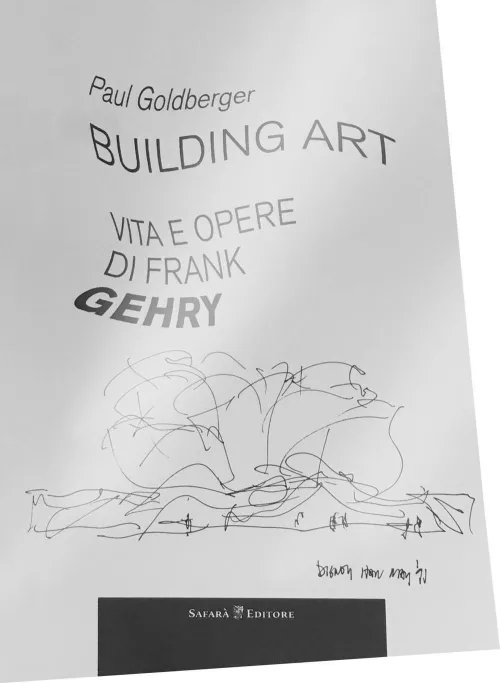Building Art. Vita e opere di Frank Gehry / Frankie Goes to Hollywood
Secondo Ermanno Cavazzoni «ogni biografia che sia minore di 40 milioni di pagine è una biografia ridotta e scorciata, a me viene da dire bucherellata, dove i buchi possono estendersi in grandi lacune [...] Ogni biografia è quindi un lampo che percorre alcune punte più cariche, e più visibili, e casualmente più emergenti. Tutto il resto è colato via nei buchi del colapasta o del setaccio che è la vita. Non si può fare diversamente. Però questo ha un vantaggio: che la biografia è una costruzione, una scelta di emergenze tra le quali si costruisce un collegamento, e quindi le biografie di una persona sono tantissime». La biografia di Paul Goldberger, Building Art. Vita e opere di Frank Gehry, 35 €, tradotta da Matteo Zambelli per il nuovo editore Safarà di Pordenone, non sfugge a questa sorte, nonostante le quasi cinquecento pagine. Sono infatti cominciate in anticipo le celebrazioni per l’imminente novantesimo compleanno dell’architetto nato a Toronto: oltre a questa biografia, uscita originariamente nel 2015, Jean-Louis Cohen nel 2017 ha dedicato alla sua opera il primo corso al Collège de France, onore fin quasi eccessivo. Goldberger, già critico del “New York Times” e del “New Yorker”, basa la sua biografia quasi esclusivamente su delle conversazioni private avute con Gehry, sua sorella Doreen, qualche amico e collaboratore o su interviste di altri. Si tratta perciò di una biografia orale, prossima alla memorialistica: i problemi e le difficoltà non sono occultati, ma appianati grazie al distacco del ricordo lontano.
Anche quando ci sono di mezzo le passioni, queste raramente escono dal bozzetto psicologico: nessuna relazione o quasi viene posta fra le poetiche degli artisti più frequentati se non in modo aneddotico – per di più con pochissime illustrazioni che invece avrebbero giovato assai, specie nel caso degli artisti californiani della Cool School (Ed Moses, Robert Irwin, Ken Price, Billy Al Bengston) tanto evocati quanto ignoti ai più, con la sola eccezione forse di Ed Ruscha. Resta comunque un libro unitario che si legge volentieri, migliore del libro di interviste di Barbara Isenberg (Conversazioni con Frank Gehry, Mondadori, Milano 2010), perché almeno prova a collocare il pensiero teorico fra le opere in modo più sistematico e, soprattutto, a ricostruire almeno in parte i diversi contesti che l’architetto ha attraversato con disinvoltura, sgusciando come una carpa per il gefilte fish che la nonna materna Leah gli preparava per ogni shabbat. Ad esempio da sempre Gehry rivendica la sua amicizia con questi e altri artisti come Charles Arnoldi o Ron Davis, che in effetti sono stati anche fra i suoi primi committenti – la casa studio terminata nel 1972 per Davis fu la prima opera a essere visitata da Philip Johnson –, per rimarcare quanto lui sia sempre stato un outsider fra gli architetti e un insider nella scena dell’arte.

Arles Tower, France, Frank Gehry.
Tuttavia considerarsi degli outsider è un classico di tutte le forti personalità, come quella di Alvar Aalto, il maestro finlandese che il giovanissimo Gehry poté ascoltare a una conferenza in Canada nel 1946 quando ancora non sapeva che avrebbe studiato architettura: la barca personale di Aalto, che è stato non solo l’architetto ma forse l’intellettuale finlandese più celebre di ogni tempo, si chiamava Nemo propheta in patria. Analogamente Gehry, che lamentava isolamento e incomprensione è divenuto l’icona di Los Angeles, tanto da essere usato come testimonial della campagna pubblicitaria “Think different” di Apple già nel 1997, alla stessa stregua di un Einstein o un Picasso, ma californiano. Eppure già nel 1971 la sua casa Danziger (1969) era inserita alla fine del capitolo sugli architetti esuli, in continuità con Richard Neutra e Rudolf Schindler, da Reyner Banham nel suo fondamentale libro su Los Angeles (Los Angeles. The Architecture of Four Ecologies, A. Lane, London 1971; trad. it. Los Angeles. L’architettura di Quattro ecologie, Costa & Nolan, Genova 1983, pp. 177-179), mentre Germano Celant lo notò nella Strada Novissima alla Biennale del 1980 per poi reinvitarlo cinque anni dopo alla performance Il corso del coltello (“Strada Novissima” in “The Presence of the Past”, «Artforum», 19, 4, 1980, pp. 84-85;e Id.., Frank O. Gehry. Disordine in architettura (1986), in Id., Architettura + design 1965-2015, Quodlibet, Macerata 2018, pp. 61-86); infine Bruno Zevi a più riprese scrisse di Gehry con toni entusiastici (Ebraismo e architettura (1993), Giuntina, Firenze 2018, p. 106) già prima del Premio Pritzker (1989) e del documentario di Sydney Pollack, Frank Gehry - Creatore di sogni (2005). In ogni caso gli artisti riuniti intorno alla Ferus Gallery (1957-1966) non formavano un movimento né artistico né di pensiero, quanto piuttosto una compagnia composita alla quale ogni tanto si univa qualche collezionista o pittore dilettante come l’attore di Easy Rider Dennis Hopper, dove cioè si discuteva e chiacchierava non solo di affari o di carriere, bevendo e fumando spinelli fino a tarda notte dalle parti di Venice prima della sua gentrificazione.
Tutta la prima metà del volume è spesa a ricomporre le origini di Goldberg/Gehry, nato il 28 febbraio 1929 nella zona ebraica di Toronto, da un padre di origini polacche così come la madre (nata a Lodz, la stessa città dove è nato Daniel Libeskind). Il lavoro intermittente del padre Irving (fruttivendolo e gestore di slot machine) portò la famiglia Goldberg a barcamenarsi fra Toronto, la città mineraria di Timmins – dove Frank ebbe il primo approccio con l’hockey su ghiaccio e con l’antisemitismo – fino a Los Angeles, dove si trasferiscono in un misero appartamento a causa dei problemi di salute del padre, tanto che sarà la madre Thelma a dover lavorare. La biografia di Gehry insomma conosce molte difficoltà all’inizio: l’indigenza, il rapporto conflittuale con la prima moglie Anita, che lo costringe a cambiare cognome (la caccia alle streghe e il caso Rosenberg erano ancora vivi nella memoria di tutti), guidare un camioncino per installare angoli cucina per potersi mantenere agli studi, il servizio militare coatto, la difficoltà a trovare uno studio professionale soddisfacente e una propria linea in architettura. Ma dal punto di vista artistico, l’esperienza cruciale per il giovane Gehry a mio parere non ha a che vedere né con l’architettura né con la pittura, e tantomeno con la scultura – l’arte cui viene più accostato, irritandolo puntualmente. È piuttosto la ceramica l’oggetto del primo corso universitario di Frank presso la University of Southern California, tenuto da Glen Lukens. Sebbene il volume gli dedichi appena una paginetta, fu Lukens a dare fiducia in sé stesso a Gehry, a instillargli una coscienza artistica embrionale, a farlo lavorare con le mani e i colori accesi, sempre lui a presentagli Raphael Soriano nel 1949-1950, e infine a convincerlo a iscriversi ad architettura dopo averlo visto entusiasmarsi nel cantiere della casa per Julius Shulman, il grande fotografo di architettura angeleno. Probabilmente dietro l’anonimo che saldò le tasse di iscrizione del primo anno, una vera manna dal cielo, si celava lo stesso Lukens, sospetta tuttora Gehry.
La ceramica è un’arte minore, ma legata a una sensibilità fondamentale per la Scuola viennese di critica d’arte, la tattilità. Centrale in Alois Riegl, che infatti elevò le arti applicate o decorative a territorio di studio privilegiato della storia dell’arte tanto quanto le arti sorelle della pittura-scultura-architettura, la tattilità è stata decisiva per Gehry perché ancora oggi progetta con le mani: la manipolazione dei cartoncini piegati, assemblati e talvolta accartocciati come nel celebre episodio dei Simpson in cui è stato oggetto di parodia, sfocia negli innumerevoli modellini di studio spesso accatastati a formare una sorta di Merzbau angeleno così come la sua celebre casa a Santa Monica (1978) – un grande accrochage di materiali ordinari e ready made. Non a caso Francesco Dal Co (Francesco Dal Co, Kurt Forster, Hadley Soutter Arnold (a cura di), Frank. O. Gehry. Tutte le opere, Electa, Milano 2003) aveva usato proprio il Merzbau di Kurt Schwitters per interpretare il processo creativo che è alla base del magnum opus di Gehry, il Museo Guggenheim di Bilbao (1997). E non casualmente Walter Benjamin prima di lui aveva ravvisato nella tattilità la cifra distintiva di un’avanguardia impegnata a scardinare le tradizionali modalità di contemplazione estetica come il dadaismo: «Coi dadaisti, da un’attraente apparenza ottica o da una formazione sonora convincente qual era, l’opera d’arte divenne un proiettile. Essa colpiva l’osservatore. Assunse una qualità tattile».
Tattile è inoltre, per Benjamin, il contrassegno della ricezione delle opere architettoniche, ricezione non concentrata bensì distratta (come sarà per il cinema): «La fruizione tattile non avviene tanto sul piano dell’attenzione quanto su quello dell’abitudine. Nei confronti dell’architettura, anzi, quest’ultima determina ampiamente perfino la ricezione ottica. Anch’essa, in sé, avviene molto meno attraverso un’attenta osservazione che non attraverso sguardi occasionali» (L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, Einaudi, Torino 1966, p. 24). E di qualità e fruizione tattile, infatti, sono le opere più mature di Gehry, la Walt Diseny Concert Hall (2003) a L. A., la Fondazione Louis Vuitton (2014) a Parigi, il Museo Guggenheim di Abu Dhabi o i vari progetti per sedi di Facebook a Menlo Park ancora in via di costruzione, quelle elette a simbolo del turbo-capitalismo da critici come Joan Ockman, ovviamente severissima con la più hollywoodiana fra tutte le archistar.
Eppure Gehry aveva cominciato usando materiali ordinari e poveri come il legno, spesso ruvidi come l’intonaco grezzo della Danziger o il cartone delle sue famose sedie ondulate, le reti metalliche da cantiere o ancora la lamiera ondulata delle case per Arnoldi, coniando il termine cheapskate architecture, architettura tirchia, senza abbandonare mai l’utopia di essere un artista dell’architettura – poggia su questo punto l’affinità con Johnson – pur sapendo che l’architettura non potrà mai essere arte per via della sua funzionalità. Ciononostante ha guardato molto i suoi amici artisti della Ferus, che spesso e volentieri usavano materiali di risulta per le loro opere, ma anche a Rudolf Schindler, conosciuto grazie a Shulman, per il suo estro da bricoleur. O forse, la sua vita somiglia a quella del personaggio dello scrittore ebreo canadese Mordecai Richler, Barney Panofsky (La versione di Barney, Milano, Adelphi 2001): figlio di un padre scapestrato, una giovinezza turbolenta spesa al fianco di intellettuali trasandati, e dopo molte vicissitudini raggiunge un certo equilibrio esistenziale solo dopo il secondo matrimonio, mantenendo esclusivamente la sua passione sfegatata per l’hockey su ghiaccio (nel 1995 Gehry ha realizzato il Palazzo del Ghiaccio Disney ad Anaheim, dove si trova il primo parco a tema inaugurato da Walt Diseny nel 1955), e finendo col raggiungere il successo professionale ed economico grazie alla sua società di produzione dal titolo emblematico: Totally unnecessary productions. Dopotutto, cosa è meno necessario e al contempo indispensabile dell’arte?