Speciale
Parole per il futuro / Respiro
Un verso di Ferdinando Pessoa, da “La mietitrice” del 1914:
“Ciò che in me sente sta pensando”.
Una sola riga, precisa come un’incisione. E ha la forza di portare alla luce il sentire, spesso considerato una conoscenza di basso rango, una non-conoscenza confinata nel sottoscala del pensiero, dove si affastellano, in massa informe, il tremore, lo sgomento, il batticuore ansioso, e altre vibrazioni d’anima, granelli dispersi di esperienze ritenute spurie, ma che risuonano dappertutto nella diffusa combustione dei cuori.
È lì che possiamo incontrare il respiro affannoso, strozzato del “futuro”, materia in subbuglio, che, indocile, immisurabile, sguscia via. Le nostre lingue lente, impacciate, stentano ad acchiapparlo, se non nel tempo breve di una domanda, proiezione di dubbi pressanti, quella formulata da Débora Danowski e Eduardo Viveiros de Castro: “Esiste un mondo a venire?”.
La domanda non è di oggi. Nasce nel cuore della Modernità, fra le sue pieghe, quando si stanno appena abbozzando le premesse di quello che da qualche tempo chiamiamo “Antropocene”.
“Una convulsa febbre si è impossessata della sostanza intera”, dice John Donne in Anatomia del mondo. Il poemetto è del 1611, lo stesso anno in cui Shakespeare dà vita a La tempesta, gli stessi anni in cui Keplero e Galileo sovvertono il cielo (il Sidereus Nuncius è del 1611). E di una tempesta si tratta, o di una deflagrazione che manda “tutto in pezzi, scomparsa ogni coesione e ogni rapporto”, “qualunque forma noi vediamo è discordanza e rozza incongruenza”.
Negli ultimi passaggi di L’anatomia del mondo, Donne rivela quanto “storpio e zoppo” sia diventato il mondo. Svanita ogni “rotonda proporzione”, ogni geometrica armonia, sono state intaccate le radici della vita, infettata la sua fonte. Il Mondo gli appare come una distesa inaridita, è spettro, è “tomba”:
“Le nuvole non concepiscono pioggia oppure
non versano, al tempo della nascita, balsamici rovesci.
L’aria non siede più sulla terra come madre
per covare le sue stagioni e far nascere ogni cosa.
Le primavere erano culle universali ma sono tombe,
e falsi concepimenti riempiono tutti i grembi”.
Il mondo-tomba di John Donne è oggi una Babele in fermento assediata dalla paura della “fine”, un calderone ribollente di idiomi divergenti, di pensieri in scomposto movimento, “storpi” e “zoppi” come il Mondo da cui emergono. Ma cercano aria, respiro.
“Dovremo imparare di nuovo a respirare”, ha detto Jean-Luc Nancy, in un’intervista agli inizi della pandemia. Come bambini: con un respiro si entra nella vita e se ne esplora il ritmo; con un respiro si allontana la morte.
Questo è il gesto di Thomas Bernhard, e oggi va ritrovato. Il respiro, è un suo romanzo breve di bruciante intensità, che si muove a partire da questo dichiarato presupposto: “Il malato è un veggente, nessuno possiede un’immagine del mondo più chiara della sua”.
Poco più che ragazzo, Bernhard viene ricoverato in sanatorio: tisi, fase terminale. Nessuna speranza. Siamo in Austria, nei primi anni dopo la seconda guerra mondiale. La medicina è ancora in trincea: folle di malati in attesa di un verdetto, diagnosi rapide, e, più o meno, nessuna cura. O ce la fai, o sei spacciato; o sei in grado di rimetterti in piedi, o soccombi. Thomas è “dato per spacciato”: la morte gli fa la posta, lo incalza, gli è quasi addosso.
Accade qualcosa. Steso sul suo letto, come in un pericoloso avamposto, in un via vai di bare di zinco e corpi prosciugati che vanno perdendo la loro dignità di viventi, lo attraversa un pensiero che ha le parvenze di un’ossessione: “Volevo vivere, tutto il resto non aveva importanza. Vivere, vivere la mia vita, viverla come e fino a quando mi pare e piace”:
Thomas estrae allora dal suo sfinimento il diamante di una decisione: respirare. E sarà meno di un respiro, un sibilo sommesso, uno sbuffo d’aria destinato a perdersi nell’enorme stanzone.
Ma è così che si lascia alle spalle il “trapassatoio”, schiva l’ingresso nella stanza della morte, dove suore, medici e infermieri, ammucchiano, con fare sbrigativo, i vivi-morti. Basta arrendersi alla propria stanchezza, concedere un po' di riposo al corpo sfibrato, e la voragine del “trapassatoio” si spalanca. Suore, medici, infermieri, i guardiani dell’Ade, braccano il suo respiro, lo misurano, ne spiano le interruzioni, i colpi a vuoto, pronti ad afferrare il giovane malato che sta scivolando nel nulla, e chiudere la pratica. Il registro dei morti, l’elenco delle esistenze arrese, viene scrupolosamente aggiornato.
Il corpo sfiancato del giovane Bernhard non appartiene più alla vita, sta precipitando altrove. La gloria del respiro si è oscurata, è una candela fioca la cui debolissima luce si va smorzando. Una fiammella tremolante. Sarebbe forse più facile, e meno doloroso, darsi al “trapassatoio”, cedendo al cadavere che avanza in lui a passi spediti.
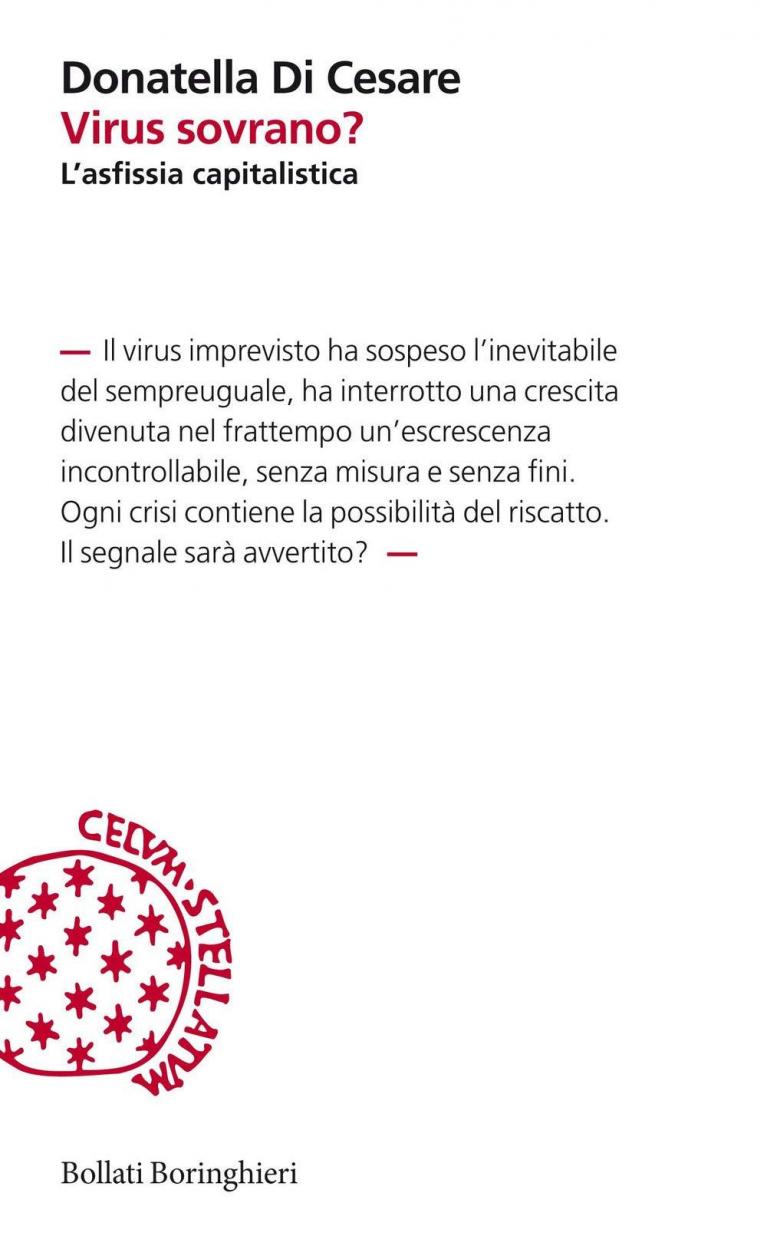
Ma la vita devia, salta, procede a scatti. Esce dal solco già tracciato, smentendo il suo naturale epilogo. Ed è uno scatto il gesto di Thomas, un miracolo fiorito dalla nera disperazione della sua spossatezza. Poco dopo aver ricevuto l’estrema unzione, inaspettatamente, racimola l’ultimo resto d’aria, lo raschia dal fondo dei suoi polmoni, per mostrare ai guardiani dell’inferno la ferma volontà del suo respiro, inconfondibile segno del suo essere vivo. È vivo non solo perché respira, ma perché vuole respirare. Nel respiro Bernhard dà fiato al suo futuro.
“Non avevo voluto smettere di respirare come l’altro davanti a me, avevo voluto continuare a respirare, e continuare a vivere. Dovevo assolutamente convincere la suora, che di sicuro era in attesa della mia morte, a farmi prelevare dalla stanza da bagno e riportare nella camerata, e dunque dovevo continuare a respirare. Se la mia volontà avesse ceduto per un solo istante, non sarei vissuto un’ora di più. Stava a me la scelta se continuare a respirare oppure no”.
Sta a noi la scelta. Attraverso il desiderio e la volontà di respirare passa la vita degli anni a venire. Volerci vivi, dirci vivi, non smettendo di respirare, è la strada per metterci fuori dal “trapassatoio”. Appena qualche passo. Potrebbe bastare. Un sibilo, uno sbuffo d’aria.
Non sarà facile: manca l’aria, i polmoni sono ingombri di sostanze tossiche, il mondo ne è avvolto, come da una calotta oppressiva e soffocante. Tanto più oggi, nel tempo di una pandemia che si manifesta come una catastrofe del respiro. Il coronavirus, dispoticamente insediato nelle nostre vite, è solo l’ultimo passaggio di una storia ben più lunga. È come se tutta la nostra storia, scandita dalle onde di un contagio universale, confluisse nell’imbuto oscuro di questa patologia. Non è un episodio, è il punto in cui si raccolgono i guasti della nostra storia.
“La modernità è stata una guerra interminabile contro la vita – ha scritto Achille Mbembe (in “Il diritto universale di respirare”, in Il lavoro culturale.org) – … La principale proprietà di queste guerre contro la vita è quella di togliere il respiro”. Mbembe si chiede se siamo poi “così lontani dal tempo in cui ci sarà più anidride carbonica da inalare che ossigeno da respirare?”. Quanto siamo lontani dal generale soffocamento, e quanto futuro ha dunque il respiro? Ci sarà consentito di compiere il gesto di Thomas Bernhard, voler respirare, o non risulterà sufficiente la disperata mobilitazione di una residua forza individuale?
“Se deve esserci una guerra – dice Mbembe –, questa non deve essere tanto contro un virus, ma contro tutto ciò che condanna la maggior parte dell’umanità alla cessazione prematura della respirazione, tutto ciò che attacca fondamentalmente le vie respiratorie, tutto ciò che sulla lunga durata del capitalismo avrà confinato dei segmenti interi di popolazioni a una respirazione difficile senza fiato, a una vita pesante. Ma per uscirne, è ancora necessario capire la respirazione al di là degli aspetti puramente biologici, come quello che ci è comune e che, per definizione, sfugge a tutti i calcoli. In questo modo possiamo parlare di un diritto universale di respirare”.
Raccolgo altri pensieri.
“L’attacco è sferrato nell’aria”, scrive Donatella De Cesare in Virus sovrano? L’asfissia capitalistica, steso nei mesi più virulenti della pandemia. “Subdolamente il virus mira al fiato, toglie il respiro, e provoca una morte orribile. È il virus dell’asfissia”.
Il collasso respiratorio dispiega tutte le sue potenzialità distruttive, non resta confinato nello spazio della vita individuale, si sviluppa in “convulsione planetaria”, nella “tetanizzazione del mondo”. Va dunque oltre se stesso, la pandemia assume tratti psichici, la vulnerabilità che essa ha provocato accumula paure che sembravano sopite. C’è da chiedersi se le nostre democrazie traballanti, stressate, saranno in grado di contenere gli effetti dirompenti di questa rovinosa “pandemia psichica”.
Volere il respiro, volere la vita, come Thomas Bernhard ci ha ricordato, e dunque rompere l’anello del soffocamento, bucare la lastra dell’asfissia, è il primo passo, il più difficile. Il futuro comincia qui. E non è scontato.







