Non è tempo di ospitalità / Restare nel posto sbagliato
È notte inoltrata e bisogna tornare in albergo nella 96th west, in Upper west side. Siamo in Lower Manhattan e New York si è rilassata almeno un po’ a quest’ora. Non si capisce mai se questo fatto tranquillizzi o metta più ansia. Il modo migliore per andare a riposarci ci sembra la metropolitana; meglio ancora la linea veloce. La giornata è stata impegnativa e una doccia e una stanza sono una meta agognata. Il tempo di salire e prima ancora di sedersi tra qualche volto stanco il treno balza in avanti veloce, troppo veloce ci sembra. Un presagio. Quando siamo alla nostra fermata, quella più vicina alla meta, infatti, il treno non ferma e scopriamo che sarà Strivers’ Row la prima fermata. Non possiamo che restare, prima sul treno e poi per un lungo quarto d’ora sul marciapiede della stazione attendendo la corsa per tornare indietro. Non ci guardano bene, almeno così ci sembra, le poche persone che sono in stazione: siamo intrusi, diversi, non graditi, in un posto sbagliato, eppure non possiamo che restare. Che strana sensazione di estraneità per una permanenza forzata si può vivere in uno dei luoghi più cosmopoliti del mondo!
Solo chi conosce il piacere forse nevrotico del rinvio può comprendere come possa accadere di restare nel posto sbagliato. Perché fare subito una cosa che si può tenere in attesa, in salamoia o in quarantena, se si può godere del piacere di dirsi: ma dài non la faccio adesso, la farò domani, e intanto mi godo la sospensione e la distensione del momento? È vero che siamo animali fatti di movimento, ma è altrettanto evidente che la noia della stanzialità spesso ci cattura almeno quanto l’avventura. La noia, sì, proprio la noia. Avete mai visto un computer annoiarsi? Avrete forse visto un animale non umano sbadigliare, ma non sappiamo se per noia. Noi invece sappiamo cos’è la noia e, anche se ne abbiamo una considerazione non proprio positiva, le dobbiamo molto. Senza noia e senza il suo sodale ozio, non saremmo capaci di riflettere né di sospendere l’appartenenza tacita a situazioni che, seppur si presentano rassicuranti, possono diventare pericolose. Diciamolo, restare suscita una peculiare sensazione di sicurezza. A spostarsi chissà cosa potrebbe accadere. Per quanto faticosa o noiosa la situazione è comunque già nota. Non si resta in un luogo o in una situazione solo fisicamente. Può accadere di restarci anche solo con l’immaginazione, il desiderio o la nostalgia, e poi magari rimanerne profondamente delusi se si torna davvero, verificando che cosa ne è stato di quel posto che avevamo trattato con la formula musiliana: ieri sarà quel che domani è stato, facendogli significare quel che non era più. Insomma siamo spesso intempestivi, come emerge dalla fine speculazione antropologica di Franco La Cecla, che dopo essersi occupato di andare nel posto sbagliato si domanda cosa succede quando ci capita di Restare nel posto sbagliato (Milieu edizioni, 2017).

La Cecla è un esploratore della contemporaneità da vertici, artefatti e situazioni che sono quasi sempre caratterizzati da una notevole originalità. Può trattarsi di una speculazione sul malinteso o su “a’ lapuzza” che, per chi non lo sapesse, è il mezzo (l’Ape) della Piaggio che popola, più di ogni altra entità umana e non, l’isola di Stromboli, per la gioia e la disperazione acustica e prossemica degli umani turisti e residenti. In una gara con Procida sarebbe difficile individuare un vincitore. In questo libro sul restare intempestivo La Cecla coglie i caratteri di un’esperienza che difficilmente qualcuno ha evitato di fare o non ha fatto. Si tratta di un momento nella vita di ognuno di noi in cui avvertiamo il bisogno di andare, cambiare aria, cercare altrove. Di queste situazioni, forse le più insinuanti sono le meno eclatanti. Non quelle in cui si evidenzia palese l’opportunità di cambiare e di andare via. Bensì quelle che iniziano con una cosiddetta sensazione, una specie di sesto senso, qualcosa nell’aria, che inizia a farti sentire stretto il posto dove sei. “Agium” era il posto per i latini, appunto; ne deriva che il dis-agio è relativo al sentirsi almeno leggermente fuori posto. In quel caso la questione cruciale diventa il tempo. Da qui la questione dell’intempestività. E la tempestività, si sa, è una cosa seria. Sbagliare il tempo di una battuta a teatro può rovinare un effetto comico o drammatico, come magistralmente emerge in una commedia di Eduardo in cui un suggeritore sbaglia il tempo durante le prove di una compagnia comica scalcagnata.
“A suo tempo!” sarà l’ingiunzione del capo comico quando il suggeritore redarguito chiede quando deve suggerire la battuta. Noi, poi, la tempestività la reifichiamo con le nostre menti compensative e allora inventiamo il ruolo del destino per spiegare la contingenza per cui la famosa tegola è caduta dal cornicione proprio mentre passavamo di là. Un’autocentratura persino un po’ narcisistica se si pensa che a quella tegola, al vento che l’ha smossa o al muratore che l’ha montata male, la nostra testa non doveva interessare poi tanto. A domandarsi perché restiamo o andiamo si presenta un’ampia varietà di risposte possibili. Possiamo essere stanchi di una situazione che è latente, che si trascina da tempo, o di un luogo che ci sembrava attraente ed è diventato noioso e faticoso da vivere. Lì abbiamo provato a restare ma non ce la facciamo più. Eppure qualcosa ci trattiene. Ci annoiamo con un partner ma non ci passa neppure per la testa di dirglielo: come potremmo mai iniziare; quali sarebbero gli effetti; e poi siamo sicuri che si tratta di noia? E intanto restiamo lì per verificare, spesso, che era il posto sbagliato. Non è necessario andare in un altro paese per sentirsi nel posto sbagliato. Può capitare, infatti, di sentirsi intrappolati nel proprio paese di origine, che può diventare patrigno o rivelarsi deludente o addirittura pericoloso per la nostra situazione o condizione di vita. A ben vedere La Cecla, con la leggerezza che caratterizza le sue narrazioni, ci pone di fronte a un cambiamento storico abbastanza profondo: la trasformazione della capacità dei luoghi di ospitare e generare senso di appartenenza. Se c’è una esperienza che si mostra in una crisi profonda oggi, è quella dell’ospitalità.
Quello che è stato un valore addirittura sacro nell’antichità, e anche in tempi recenti sta diventando ostilità diffusa verso ogni altro che non sia rigorosamente “dei nostri”. Un valore di tale portata che si sfarina, indica una vera e propria crisi di civiltà. L’appartenenza si specializza e inchioda alcuni ai luoghi, fino al punto da far vivere l’appartenenza come una costrizione, mettendola in crisi per un’altra via. Mentre colloca tutti gli altri fuori da ogni gioco possibile. In altre situazioni siamo noi stessi a cambiare, a non sentire più un luogo come il nostro e a percepire di non avere più niente a che fare con quella situazione. È come se il luogo si stancasse di noi e noi di lui e tutto questo può riguardare anche una casa nella quale abbiamo vissuto per anni e che ci fa sentire a un certo punto come recita il titolo di un bellissimo libro di Bohumil Hrabal: “Inserzioni per una casa in cui non voglio più abitare”. Nel libro di La Cecla, i racconti scritti e vissuti tra la Tunisia, il Kenia, il Brasile e altri luoghi, ci portano in un arcipelago di situazioni le cui dinamiche interiori sono abbastanza note e costituiscono esperienza comune. Soprattutto quando riconosciamo una situazione in cui appare evidente che sarebbe stato meglio partire, ma non avendolo fatto, ci siamo ritrovati in eventi che hanno finito per prendere una piega problematica per noi.
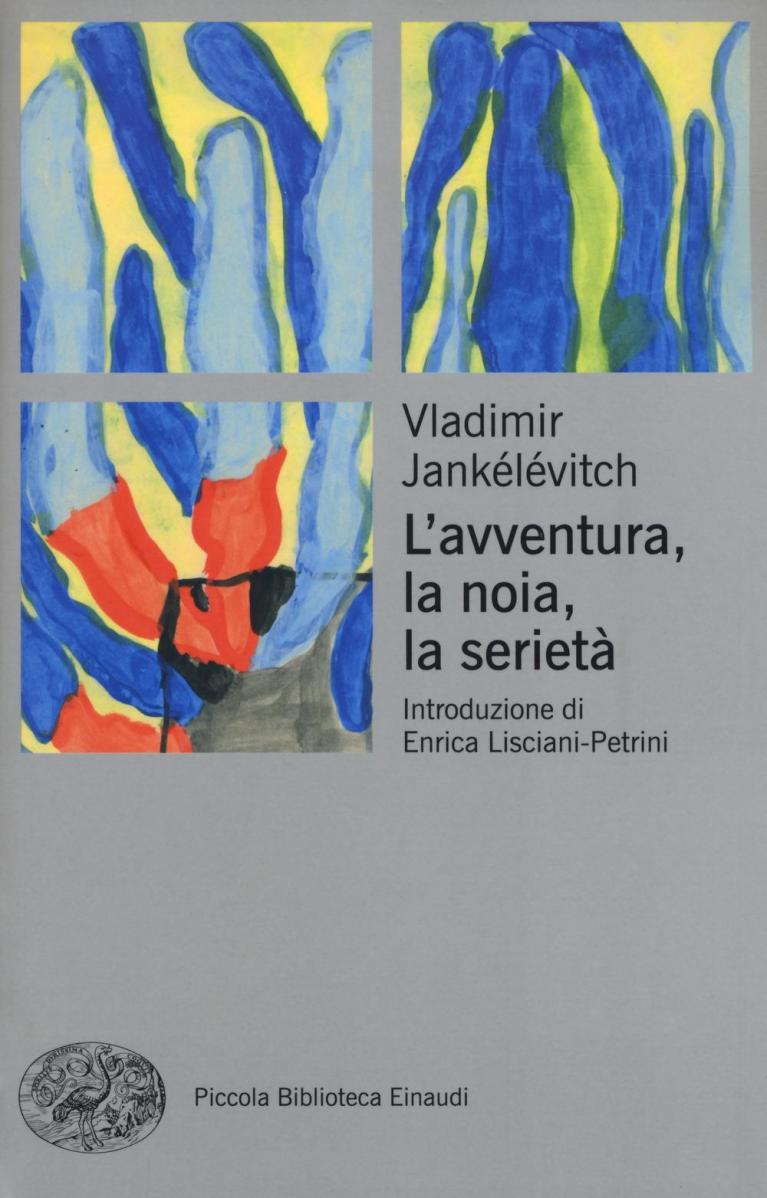
La serietà del vivere, alla cui grevità conviene sempre rispondere con una certa ironia, si alimenta continuamente, a ben pensarci, di avventura e di noia. Esiste, in fondo, tra la noia e l’avventura una sodale affinità. “L’uomo muore dalla voglia di fare ciò che teme di più”. A scriverlo è Vladimir Jankélévitch in L’avventura, la noia, la serietà, Einaudi, Torino 2017. Se il timore può impedire l’azione o addirittura paralizzare, lasciandoci nel consueto rassegnato e noioso, il desiderio di avventura pare stimolato soprattutto da ciò che sfida il nostro timore e la nostra paura. Un’ambiguità, come riconosce Jankélévitch, che ci è connaturata, che è costitutiva di noi. D’altra parte noi siamo quelli a cui il mondo non basta mai così com’è né come ci si presenta e se restiamo nel posto sbagliato è anche perché cerchiamo di far essere quel posto ciò che non può essere e di fargli dire ciò che non può dire e forse non dirà mai. Siamo quelli, tra gli animali, capaci di ragionamento ipotetico e di pensiero simbolico e il simbolo non è un semplice e accidentale rivestimento del pensiero, ma il suo organo e la sua condizione, necessari ed essenziali. Per via simbolica creiamo il nostro Umwelt, il nostro ambiente, di cui diventiamo parte creandolo: quell’ambiente è soggettivo e non accessibile a una misurazione diretta, anche se è oggetto della molteplicità condivisa che la nostra intersoggettività e la nostra risonanza incarnata generano, pre-intenzionalmente e pre-linguisticamente. Appartenendo tacitamente ad ogni ambiente che creiamo, in modi più o meno intensi, quegli ambienti ci vincolano e può essere impegnativo non restarne in qualche modo coinvolti o invischiati. Accade però che la stessa comunità che sembrava la nostra casa possa rivelarsi illusoria o addirittura pericolosa, e che lo stesso partner che ci sembrava definitivo possa mostrarsi fasullo.
La Cecla si concentra sull’intempestività e sul ruolo che ha nelle nostre vite e, quando si chiede perché non agiamo in tempo utile e giusto, scrive:
“Siamo rimasti proprio perché non c’erano segni che saremmo dovuti partire. L’indomani si profila inaspettato, volge ciò che sembrava favorevole nel suo contrario. E non è dato accorgerci quando la trasformazione avviene. È l’esperienza del giocatore che avrebbe dovuto alzarsi prima dell’ultimo giro di carte o avrebbe dovuto abbandonare il tavolo del casinò con l’ultima vincita. Quella dell’amante che non ha saputo aspettare o che ha atteso fin troppo, quella del pugile che avrebbe dovuto abbandonare il ring o del calciatore che avrebbe dovuto ritirarsi in tempo”.
E aggiunge: “Può anche essere un’esperienza meno puntuale: quella di chi è rimasto in un posto che sembrava proprio quello migliore in cui restare e questa grande familiarità si trasforma nell’“unheimlicheit” freudiano, nel perturbante, carattere proprio e nascosto di tutto ciò che ci è talmente domestico, familiare da trasformarsi un giorno in qualcosa di mostruoso”.
I racconti contenuti nel libro di La Cecla creano un mosaico dell’intempestività, ma anche una traccia molto efficace della crisi dell’ospitalità dei luoghi e delle situazioni. Ogni racconto ha a che fare con il disagio, con quella condizione di vergogna, d’imbarazzo, di vertigine, di inadeguatezza che sta alla base del movimento che ci fa scivolare dal nostro restare all’accorgerci che qualcosa non funzionava proprio.
Eloquenti almeno quanto i racconti sono le immagini contenute nel libro, che configurano un vero e proprio repertorio psico-antropologico del disagio, della noia e dell’avventura presenti in ogni attesa e in ogni scoperta di aver sbagliato ad attendere.
Lo stesso autore nella terza parte del volume connette la questione del restare nel posto sbagliato alla noia e alla sua incidenza nelle scelte: “Una delle conseguenze del restare nel posto sbagliato è la noia. Un sentimento tampone che succede al fastidio, all’insofferenza, al non poterne più. A un certo punto si installa questa indifferenza, questo presente passato che non aspetta altro che il ritorno di cose, persone, posti conosciuti. La noia non è sempre la conseguenza di un contrasto tra noi e la situazione. A volte arriva prima che noi possiamo averne coscienza”. La noia può essere però, allo stesso tempo, la molla per andarsene da quel posto sbagliato in cui siamo inopinatamente rimasti.
Curiosamente ma molto efficacemente La Cecla conclude il suo libro con un antidoto alla preoccupazione di chi resta o teme di restare nel posto sbagliato e sembra dirci che solo chi fa della certezza la ragione dei propri comportamenti non rischia quell’esperienza. Allora chiama in causa un suggerimento originale: “scambiarsi verbi difettivi”: “Per ‘scambiarsi i verbi difettivi’ bisogna trovarsi dalla parte di chi non fa una teoria del proprio comportarsi perché quello che lo spinge non è un presupposto, ma lo stupore dell’aspetto inedito e sorprendente della vita”.







