Le scuole antropologiche francese e americana / Le foreste non pensano
Sarebbe bello se lo facessero, ma no, le foreste non pensano. Certamente non lo fanno nell’unico modo che potrebbe toccarci, cioè somigliandoci, attenuando quel senso di solitudine cosmica in cui la metacognizione, che caratterizza la nostra specie, ha imprigionato Homo sapiens in un universo spaventosamente silenzioso. Possiamo allora esplorare il funzionamento del sistema nervoso dei vertebrati e perfino immaginare un bosco come se fosse un grande cervello verde, ma è un abisso pieno di metafore quello che ci separa da loro, dal loro atto di essere, dal loro essere, forse, consapevoli di esistere nel mondo. E non è un guasto dei tempi, o la perdita della magia, o il disincantamento della modernità, perché è sempre stato così, fin da quando in una grotta del Paleolitico superiore un essere umano ha dipinto un animale, sperando che fosse qualcos’altro, cominciando a raccontarlo come se avesse un’anima, come se fosse una persona, come una donna o un uomo o un bambino dentro una pelle di bestia. La nostra specie gioca al gioco dello specchio imperfetto da decine di migliaia di anni, e questo gioco ha prodotto racconti complessi come l’animismo, il totemismo, i mostri e gli dei, perché a stare da soli con quello che c’è già non siamo proprio capaci. Dobbiamo immaginare altro, dobbiamo immaginare l’altro, e allora facciamo pensare le foreste per rivivere la meraviglia, per farci compagnia.
La nostra epoca, quella antropocenica, è devota al saccheggio immateriale delle culture native in cerca di indebite trasfusioni di immaginario, anche l’antropologia sta cambiando sensibilità e, entrando nell’età della post-complessità, si rende permeabile a infiltrazioni irrazionali, a una specie di realismo magico, ma sappiamo che per un lungo periodo, per oltre un secolo, l’etnografia ha affondato le sue radici nel razionalismo del Settecento, e il suo statuto epistemologico, oscillante ed elastico, certo, è stato comunque per molto tempo quello di un movimento consapevole verso la scienza, l’aspirazione a gettare sulle culture altrui uno sguardo da vicino (con il cuore) e da lontano (con la mente) in grado anzitutto di capire, non di credere. L’antropologia, però, sappiamo anche questo, non può aspirare a essere scienza, non può sperare di trovare conferme in impossibili sistemi di verificazione, tutto quello che può limitarsi a fare è inventare e argomentare dei modelli plausibili, ragionevoli non razionali, e questa sua ambiguità epistemologica la rende fragile e ricca, penetrante ma anche penetrabile da tutti i bias cognitivi che ci spingono invariabilmente a tradurre il casuale in causale. Questa oscillazione multistabile ha generato correnti disciplinari che sembrano reagire le une alle altre, in una strana storia delle idee che somiglia molto al doppio legame batesoniano: irrigidimenti, sensi di colpa, livelli impliciti ed espliciti in conflitto tra loro, blocchi e, ovviamente, schizofrenia: l’antropologia come relazione emotiva tra gli antropologi, e tra gli antropologi e il loro oggetto di studio.
Ci sono due libri recenti che raccontano questo fermento ambiguo su sponde opposte dell’Atlantico, come se il mare incarnasse la metafora dialettica di due tradizioni diverse e parallele che hanno fatto di tutto per tradire sé stesse. Da un lato la scuola americana di Boas (Charles King, La riscoperta dell’umanità. Come un gruppo di antropologi ribelli reinventò le idee di razza, sesso e genere nel XX secolo, Einaudi 2020) dall’altro gli allievi di Mauss e Rivet in Francia (Renzo Guolo, I ferventi. Gli etnologi francesi tra esperienza interiore e storia 1925-1945, Mondadori 2021).
Leggere in tandem questi due “romanzi” di metantropologia significa entrare nel laboratorio interiore dove le idee, fortemente contaminate da sentimenti ambigui, frustrazioni, rivalità, complessi e passioni, prendono un corso storico che chiamiamo “ricerca”, un termine che dietro lo spesso filtro accademico andrebbe invece declinato (anche) in chiave esistenziale. Ma la riumanizzazione/rinarrazione di due zone cospicue dell’antropologia novecentesca da parte di King e Guolo è soprattutto un dono di pensiero per continuare a riflettere sulle questioni di metodo, sull’impossibilità di escludere dal resoconto etnografico l’autoracconto soggiacente dell’etnologo, la vibrazione dell’occhio di chi osserva, il rumore bianco del corpo che distorce i risultati della mente. E mentre l’antropologia, conoscendo l’altro, moltiplicando i dati sulla variabilità delle culture umane, iniziava una lotta onesta e bellissima per smontare categorie patriarcali e finzioni di potere, allo stesso tempo moltiplicava al proprio interno la schismogenesi, con dinamiche di sottomissione e ribellione accademica, umana, ideologica in cui le idee, la cosiddetta scienza, la tensione alla verità oggettiva, ne vennero fuori segnate, a volte addirittura ammaccate. Così, ad esempio, il rapporto tra Margaret Mead e “Papà Boas”, o tra i due antitetici Marcel, Mauss e Griaule.
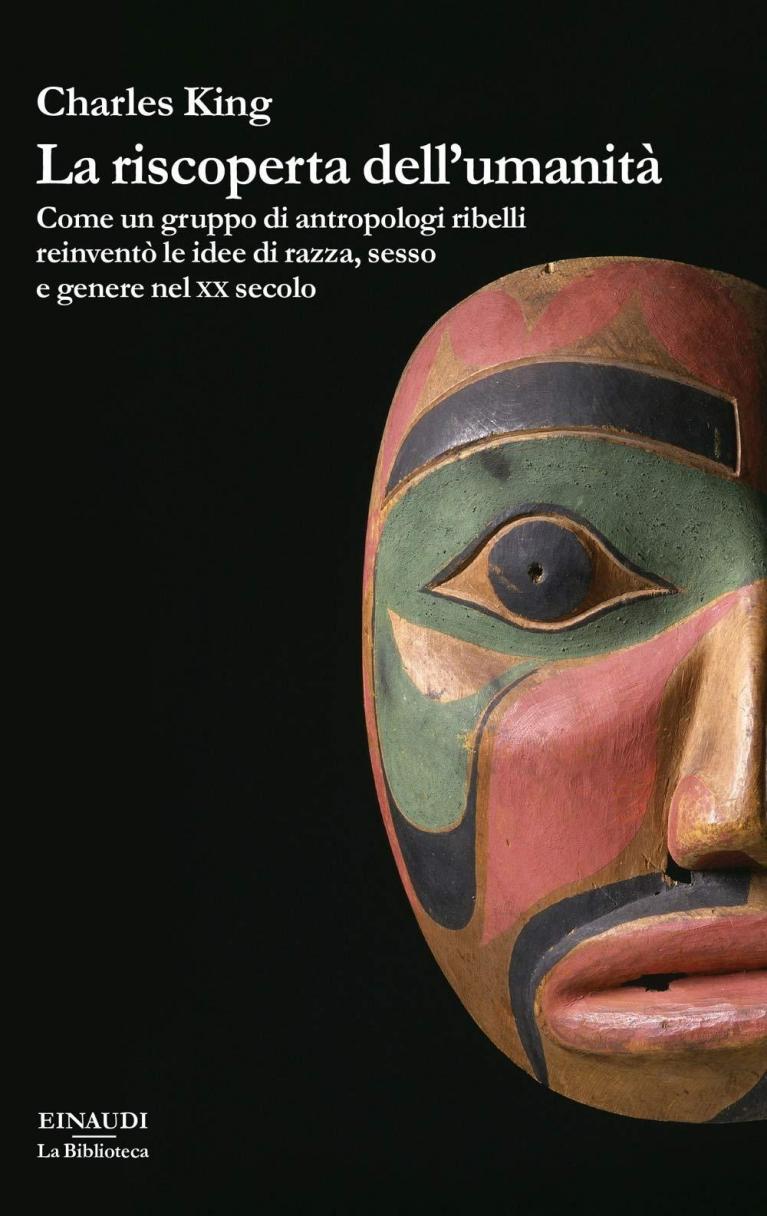
“È vanitoso come un pavone e pacchiano come una battuta da bar”, così confida Ruth Benedict a Margaret Mead a proposito di Bronisław Malinowski. “È una cagna abominevole schiacciata su una metafora ripugnante, il simbolo di tutto ciò che detesto di più nella cultura americana contemporanea” scrive Edward Sapir a Ruth Benedict dopo aver letto L’adolescenza a Samoa di Margaret Mead. E Mead, rispondendo a un articolo di Sapir che la attaccava, osserva che la gelosia è molto diffusa tra gli uomini anziani poco dotati (in senso sessuale). Ma, dice King, “I dispetti e i tradimenti, le scappatelle clandestine e le ostilità furiose, le amicizie granitiche così come le rivalità più torbide facevano parte dei seminari serali a Grantwood tanto quanto i verbi dei Dakota e le maschere della Nuova Guinea.
Ma che discutessero di sesso, di successo o di qualsiasi altro aspetto della vita sociale, Boas aveva insegnato ai suoi studenti a resistere alla tentazione dei grandi schemi teorici o delle conclusioni definitive” (p. 272). E in Francia? “Ciò che mi separa da Griaule è che viaggia, comunque, per mestiere […] se il viaggio dovesse continuare così, in modo poco avventuroso, sino a Gibuti, riterrei responsabile Griaule di avermi fatto perdere due anni e non lo perdonerei mai”, così Michel Leiris che, dal canto suo, con un tuffo emotivo molto poco professionale, romperà i rapporti con Ambibé Babadyi perché si era sentito “tradito” nel rapporto di confidenza etnologo-informatore, dal momento che il vecchio dogon gli aveva nascosto l’esistenza di una maschera rituale molto importante. Griaule avrebbe invece scoperto il segreto grazie a un altro informatore, e allora accuserà non troppo velatamente Leiris di aver “coccolato, pagato, onorato” Ambibé, di cui si era “tollerato perfino il suo sonno sulla chaise longue degli interrogatori, così come la sua condotta da bevitore al mercato”. Giudizi, polemiche, rancori, permalosità, code di paglia. Per non parlare dei saccheggi di feticci bambara estorti ai villaggi allo scopo di completare le collezioni museali parigine.
Quello che resta impresso (a parte un’aneddotica gustosa) leggendo King e Guolo sull’etnologia nella prima metà del Novecento in Occidente, un edificio intellettuale un po’ grottesco, in bilico tra glorie e monumenti della ricerca e pettegolezzo privato, è la conferma dell’irriducibile vocazione antropologica per la complessità, una necessità virtuosa generata da premesse epistemologiche e umane che a ogni incontro felice, a ogni antipatia, a ogni passaggio di testimone generazionale sembrano impennarsi in una specie di deriva esperienziale, esistenziale, sperimentale, che fa di questa disciplina una geniale indisciplina ribelle.
Mentre insomma il bazar delle culture sta alimentando oggi un’etnofiction tossica in cui le foreste ci parlano all’orecchio, i giaguari svezzano sciamani autoproclamati e l’anima degli animali fa scrivere saggi brillanti tra una mensa universitaria e un ricevimento studenti, tornare alla storia dell’antropologia significa capirne (e accettarne) le due tensioni, significa non farsi prendere la mano dalla nostalgia e dalla solitudine di specie. Soprattutto, significa rileggere in chiave narratologica il presuntuoso o generoso o avventuroso desiderio di comprendere l’altro, desiderio che, quanto più ha voluto innalzarsi a scienza, tanto più ha generato antropofiction e storytelling. Perché l’ipotesi ancora tutta da verificare ma in qualche modo ironica e promettente è che l’etnologo, a Gibuti o nel metrò, strutturalista o marxista, neurocognitivo o evolutivo, sia una scatola di Schrödinger. Le osservazioni etnografiche che farà non saranno mai uno stato puro, e il sé e l’altro, a dispetto delle scelte di stile o di scuola, saranno sempre miscelati con uguale peso. L’unica cosa di cui siamo certi è che il racconto etnografico, vivo o morto, è un gatto immaginario e paradossale che si fa molto amare.







