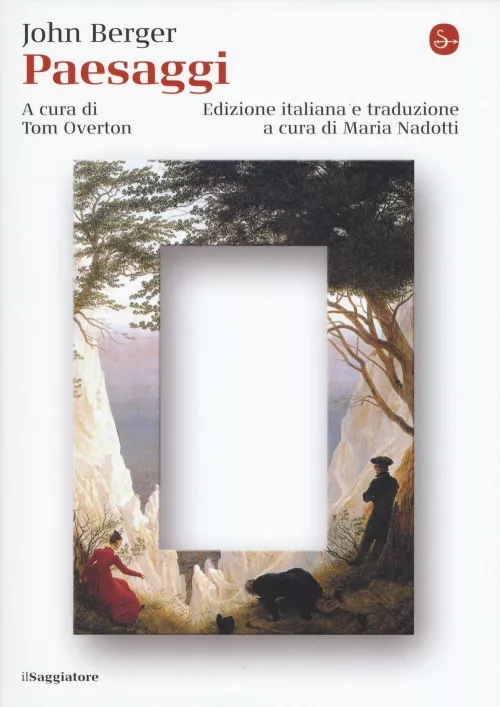Ritratti / “In-tra-fra” John Berger
In
Il brulichio incessante della piazza di Cracovia, dove le vite di individui indistinguibili si intrecciano senza intralciarsi e «si incrociano senza incontrarsi», tutti integrati e impastati all’«indivisibile mondo reale e al singolare mistero della propria esistenza» e delle sue infinite possibilità.
Inizia qui, in una piazza di Cracovia, il primo dei trentasette saggi dei Paesaggi di John Berger (edito da «Il Saggiatore», tradotto e curato da Maria Nadotti con un’introduzione di Tom Overton e l’aggiunta, rispetto all’edizione inglese del 2016, di tre testi- Leopardi, Disperso al lago di Cape Wrath e L’infinità del desiderio) che fa da complemento a Ritratti (pubblicati sempre da «Il Saggiatore» nel 2018, in cui venivano proposti diversi scritti che, presi nell’insieme, costituiscono una sorta di autoritratto dello storyteller ).
Se affermando che «è ormai inconcepibile ammettere che l’identità di un uomo possa essere adeguatamente definita conservandone e fissandone l’immagine da un unico punto di vista», Berger sembra suggerire l’inadeguatezza e l’insufficienza della “forma ritratto”, il titolo Paesaggi (sebbene non sia stato ideato dall’autore né voglia imporsi, afferma Tom Overton nell’introduzione, come «definizione rigida»), sembra indicare la necessità di uno sguardo allargato, diffuso e indefinito che abbracci la pluralità del mondo che, come la sostanza corporea spinoziana, «non può che essere concepita come infinita, una e indivisibile». Laddove il ritratto, insistendo sul primo piano, separa quest’ultimo dallo sfondo (e, interrompendo l’interazione con quel che si cela dietro, costruisce uno spazio immobile, inaccessibile, incarnazione dell’inabitare e dell’inabitato), «a volte un paesaggio», ci dice l’autore in A Fortunate Man, «pare meno lo sfondo della vita di chi ci abita che un sipario dietro al quale hanno luogo le loro lotte, le loro conquiste e i loro infortuni».
È proprio “in”, “tra”, “fra” questo sfondo «composto da domande apertissime», in questo spazio infinito e indivisibile che si colloca lo sguardo di Berger, sempre pronto a insinuarsi negli spazi interstiziali e apparentemente inessenziali in cui si infiltra la vita, per integrarsi, impastarsi a quest’ultima e, come direbbe McLuhan, «incorporare tutta l’umanità in noi». E lo fa attraverso una scrittura interrotta, piena di intromissioni ed erranze incerte atte a preservare il mistero insito nell’indivisibilità indistinta delle cose; una scrittura che non impone ma insinua e si insinua “in-tra-fra” il mormorio incessante dell’esistenza, dove «il verbo insinuare (introdurre in una curva) [viene inteso] in senso positivo: per suggerire anziché imporre», per evocare anziché indicare, per lasciar intravedere l’intrecciarsi inesausto che informa la vita degli individui.
In questa prospettiva, anche l’arte diventa sostanza inseparabile e indistinguibile dalla vita: ne viene invasa, travolta, inondata. Da qui l’insistente interesse per l’irreversibile rivoluzione innescata dal cubismo (magistralmente narrata nel saggio Il momento del cubismo, contenuto in Paesaggi) che ha «infranto l’illusionistico spazio tridimensionale […] ne ha interrotto la continuità» per mostrarci l’interconnessione tra le cose e indicarci la paradossale indivisibilità del molteplice poiché, l’incompletezza insita in ciascun frammento, induce lo sguardo a insediarsi nella totalità della superficie pittorica (unica e indivisibile) e a insinuarsi negli intervalli che intercorrono tra una cosa e l’altra.
Tra
«Ai cubisti interessava l’interazione tra gli oggetti», ci dice Berger, perché «lo spazio tra gli oggetti è parte della struttura quanto gli oggetti stessi»: trasformazione spaziale che tradisce il cambio di «rapporto tra sé e il mondo», il tramonto della prospettiva tradizionale e il farsi strada di una «prospettiva nomade», transeunte che travolge il soggetto, lo attraversa e lo trascina con sé “in-tra-fra” il trascorrere della vita. Così lo sfondo (o paesaggio) inizia a premere verso l’esterno, a trapelare attraverso la trama, lasciandoci intravedere lo spazio vuoto tra la folla in transito che attraversa la piazza di Cracovia.
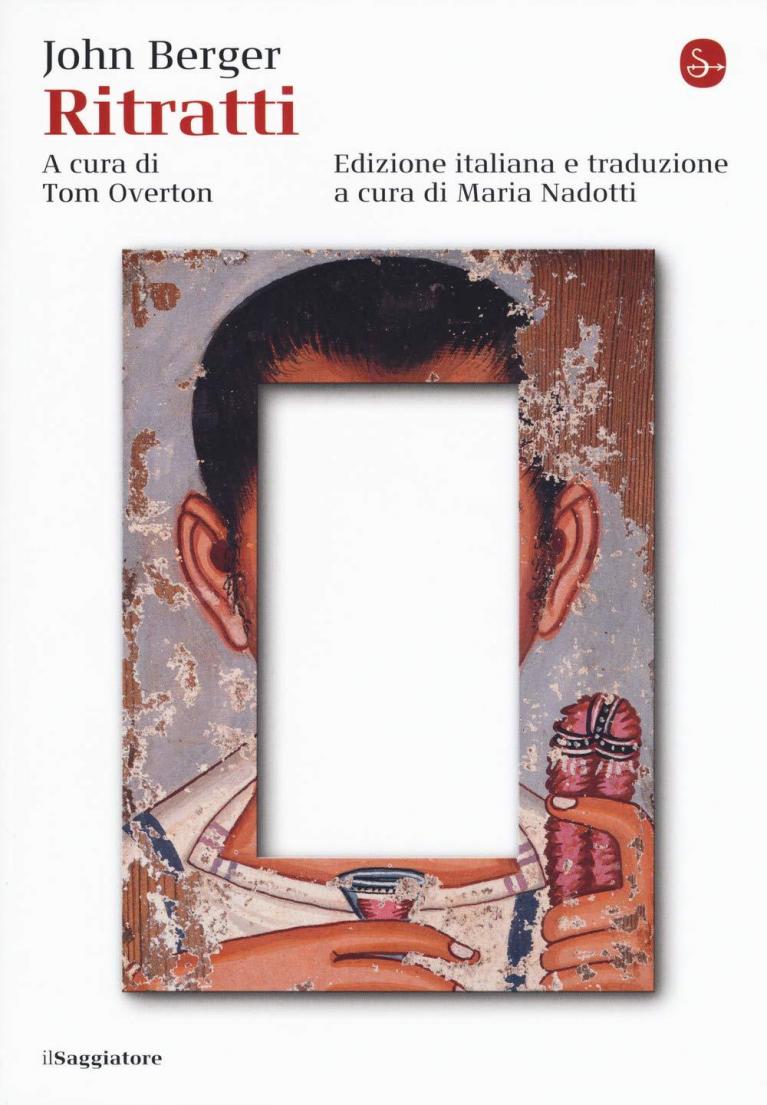
Da qui l’attrazione per i disegni, per quella trama di linee tracciate sulla carta attraverso le quali trapela il foglio, il bianco, lo sfondo. Perché è tutto lì il loro segreto, scrive in Disegnare sulla carta (Paesaggi): «il loro segreto è la carta. La carta diventa quel che vediamo tra le linee». Allora bisogna entrare in quegli «spazi sfuggenti», attraversare l’intreccio di segni per accedere all’invisibile, al mistero che si nasconde dietro, perché «dietro il pigmento della tela c’è quel che conta, e corrisponde a quel che sta dietro le palpebre degli occhi chiusi», tra l’oscurità delle tenebre, tra quel che viene tenuto in serbo e che trapela, traspare, transita attraverso la superficie.
«Se pensiamo alle apparenze come a una frontiera», dice l’autore, «possiamo dire che i pittori siano alla ricerca dei messaggi che li attraversano: messaggi che vengono da dietro il visibile»: tutta la storia dell’arte è una storia di questo attraversamento, del trapelare di quel che si è sottratto alla luce. A partire dalla grotta di Chauvet (prima traccia dell’arte di cui tratta Berger nel primo saggio di Ritratti) , dove «tutto il dramma […] si condensa in un’apparizione che è passata attraverso la roccia per manifestarsi» e tutto il mistero traspare dal buio retrostante, da quelle tenebre che «di tanto in tanto ci troviamo tutti ad attraversare» e che sono «l’interno da cui tutto proviene»; fino alla «sottigliezza pellicolare» degli strati di pittura di Mark Rothko che, «accesi da quel che c’è dietro», lasciano trasparire l’invisibile retrostante. È questo mistero che perdura attraverso il tempo, nonostante le trasformazioni e transizioni storiche: il mistero di quel che cade fuori dalla visione, di quel che si è sottratto allo sguardo, che trascende e trapassa la materia inerte dell’apparenza e si cela «dietro gli occhi e attraverso il corpo».
E poiché l’unico modo per mostrare è tenere in serbo e nulla trapela se è tutto dato (così come «il mondo degli umili si mostra nascondendosi»), allora l’unico modo per ritrarre è ritrarsi, nel senso del tirarsi indietro (ed è in questo senso che lo intende pure Jean-Luc Nancy in L’altro ritratto), sottrarsi, nascondersi e sparire dietro all’opacità della scrittura, perché «attraverso la scrittura non osserviamo la realtà come se la vedessimo attraverso un vetro sporco o pulito di una finestra, le parole non sono mai trasparenti», ma trasmettono, agiscono e trasformano grazie al loro trattenere e trattenersi, grazie al loro tenere in serbo: il mistero della scrittura, la sua forza, «non è nelle parole, ma, [ancora una volta], nella sua pagina», in quel che sta dietro.
Il bisogno di questa trasparenza opaca – che, come la trasparenza del pigmento di Monet, trasforma la «veridicità ottica» in un’«immagine di vagabondaggio» perché, scrive Berger in Ritratti, «la sua inconsistenza rende impossibile trovarvi rifugio» – si traduce in una scrittura in cui ogni racconto è una transumanza, un attraversamento, una migrazione e, siccome «siamo troppo informati su ciò che di continuo traversa lateralmente la trama», allora bisogna lasciarsi trasportare da questa scrittura sempre in transito, senza centro o migratoria, dove «migrare è sempre smantellare il centro del mondo, per entrare in un mondo perduto e disorientato di frammenti».
È questo stesso senso di transumanza che attraversa e traspare dai paesaggi: luoghi misteriosi e «paurosi perché prevedono uscite ed entrate», luoghi aperti e incontrollabili, perché in loro tutto è in transito e nulla viene trattenuto, dove nulla è visto ma tutto è intravisto, dove proprio grazie all’intravedere (inteso come il vedere “in-tra-fra” le cose, l’infiltrarsi e insinuarsi tra la trama del mondo) e all’inafferrabilità del transeunte trapela il mistero dove si cela l’infinità dell’invisibile.