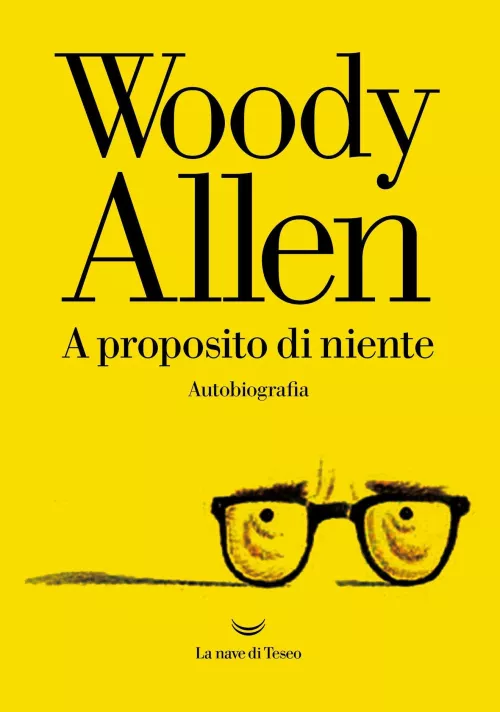A proposito di niente / La versione di Woody
Il titolo della autobiografia di Woody Allen, A proposito di niente, uscita in questi giorni dopo bizzarre peripezie editoriali per i tipi di La nave di Teseo, gioca su un doppio senso alquanto evidente: niente – perché non sono mai avvenute, perché egli è innocente – sono le tristi vicende che lo hanno, nel 1992, messo al centro di un caso di molestie sessuali, niente è la vita, l’intera esistenza dell’universo destinata a dissolversi nella polvere senza lasciare traccia. Di modo che l’una consapevolezza diventi modellino dell’altra: A proposito di niente è il teorema che si compiace di verificare la corrispondenza fra infinitamente grande e infinitamente piccolo, i fattacci personali dell’autore e gli ingranaggi che regolano il funzionamento del mondo, riconducendoli a una medesima regola sulla quale, fin da bambino, egli ha scelto di scommettere.
Allo stesso tempo, A proposito di niente è la pervicace affermazione di un’autonomia dell’autore dalle sue opere. Da cui il posto che la sua autobiografia merita: la storia di Woody Allen non era stata finora raccontata come si deve e il libro a questo serve. Succede così che egli si diverta a sfatare alcuni miti intorno alla sua persona, come, per esempio, quello di essere un intellettuale. Ci tiene a precisare, allora, di non essere mai stato nella sua vita né un lettore forte né uno spettatore compulsivo. Ci fa la lista di tutti i libri che non ha letto e di tutti i film che non ha visto. E sono molti. Ci confida di aver assunto pose da bohemien solo per far colpo sulle ragazze, le borghesi “vestite di nero” della controcultura newyorkese che tanto gli piacevano. Di essere stato un appassionato sportivo, altro ambito della sua vita che, non adattandosi al personaggio imbranato e cerebrale da lui incarnato, difficilmente è stato oggetto di attenzione da parte di un pubblico più ampio della sua cerchia di conoscenti. Eppure a Brooklyn, più che per i suoi film, i vecchi amici lo ricordano ancora per le sue gesta sulla base. Tutto ciò a riprova di come, nel volume, ci sia spazio per una narrazione fresca, inedita, ricca della vita del regista più misantropo e riservato della storia del cinema. Sono proprio le sue improbabili inclinazioni a far meglio comprendere un tratto che mi è sempre sembrato fondamentale della sua poetica artistica.

Allen da ragazzo, anni ’40.
Già a partire dalle prime pagine del libro, Woody Allen si rappresenta come un curioso ragazzino rapito da mille passioni, dalle storie di gangster (che egli conosce a menadito) all’illusionismo, dalle grandi ballad di Gershwin, Cole Porter, Jerome Kern o Rodgers & Hart fino al jazz di New Orleans, dal cinema hollywoodiano (egli impara ad amarlo grazie alla cugina Rita) al baseball e al tennis e perfino alla cucina. Di tutte queste passioni egli non si limita a piluccare qua e là ma si interessa a tal punto da volerne esplorare il versante fattivo, mettendosi alla prova ora come mago, ora come musicista, come atleta e perfino come cuoco.
Ognuna di queste attività rappresenta un pezzo dell’immaginario di Woody. Loro minimo comune denominatore è la dedizione che esse richiedono: esercitarsi nella pratica concreta di un’“arte” è l’unico modo di riuscire a saggiare l’opportunità che essa possa essere da lui usata come linguaggio, strumento attraverso cui dar forma ai propri demoni, al proprio mondo poetico. Con il dovuto disprezzo, si badi bene, per ogni tecnicismo: a fare di Sidney Bechet Sidney Bechet non è chissà quale virtuosismo tecnico ma la sua feconda capacità, l’originalità del gesto creativo, il genio che non si può imparare da nessuno. È così che ogni volta, di fronte alla molteplicità dei suoi interessi, egli pur accarezzando l’idea di diventare un professionista, non arriva fino al punto di trasformarvisi: c’è sempre qualcosa che lo trattiene dal definirsi come tale. Perfino la sua attività di regista viene compresa in questo vortice di passioni “non professionali”: egli, come un dilettante, è insicuro delle sue inquadrature, odia occuparsi di dettagli tecnici (“So che bisogna togliere il tappo dell’obiettivo prima di riprendere qualcosa, ma le mie competenze tecniche finiscono qui”) e, forse per questo, preferisce occuparsi di ciò che veramente conta: scrivere.
A questa passione per il dilettantismo fa, infatti, il paio il primato della scrittura. Woody Allen è, infatti, innanzitutto uno scrittore (“sono un pessimo studente, lo ammetto, ma una cosa ho sempre saputo fare: scrivere”), un inventore di mondi, uno che preferisce l’isolamento alla vita vera, i sogni e le illusioni alla trivialità del reale. La scrittura tiene insieme in una trama ognuna delle arti praticate da Woody, le traduce vicendevolmente, si intrufola in esse e ne tira le redini, lasciando ad altri il dominio tecnico del “come si fa”, nella convinzione che, prima di tutto, venga la poetica, il famoso “che fare”. E di questo “che fare” Woody Allen ha una padronanza precisissima, allo stesso tempo autoriale e strategica, muovendo le tante muse che costituiscono il suo discorso verso un unico obiettivo narrativo che non può che fare la differenza. Nell’arte di Woody Allen, è la precisione dell’intreccio, il suo esito narrativo a muovere lo spettatore, anche se l’inquadratura può non essere quella giusta.

Allen al lavoro nel suo studio, 1967.
La prima parte della sua autobiografia, allora, non fa altro che indicarci dove guardare: la New York anni ’40 della sua giovinezza, i tanti criminali da strapazzo (primo fra tutti il papà) che gli sfarfallano intorno, le strade di quartiere di Brooklyn, lo stupore della sua prima volta a Manhattan, i film di Bob Hope, le sue prime volte come illusionista, stand up comedian, musicista di jazz, autore televisivo, vanno via tutte d’un fiato. Ritroviamo molte di queste suggestioni nei suoi film. Come si diceva, non come autofiction, ma al contrario come ambientazioni, orizzonti poetici da piegare alle necessità della prossima storia. Non è, nei film di Woody Allen, un singolo personaggio a dire di lui, sono le nostalgie, la caratterizzazione delle sue strampalate maschere, il loro essere legate da un comune destino poetico, che egli dirige come un deus ex machina: dimostrare l’inconsistenza dell’esistenza in nome del primato delle illusioni, che prendono vita attraverso la scrittura.
Per ottenere un simile risultato, nell’organizzazione del lavoro, Woody ci vuole, certo, del metodo. I risultati non arrivano, infatti, a caso. Bisogna presidiare il campo, pronti a cogliere ogni occasione si presenti al proprio cospetto: “se l’ottanta per cento della vita è non mancare agli appuntamenti, l’altro ottanta per cento […] è fortuna”. Non si può dire che Allen si risparmi, se è vero che ancora studente delle superiori egli venga arruolato da un’agenzia di p.r. di celebrities per scrivere battute. Da lì in poi sarà un andirivieni di opportunità che egli mostrerà di onorare presentandosi a tutti gli appuntamenti. Lungo il suo cammino egli incontrerà tanti maestri che prenderanno genuinamente a cuore le sue sorti, aprendogli le porte dello show business. D’altra parte, con i suoi committenti sempre più danarosi imparerà presto a esibire la sua “disgustosa sicumera” sul versante della direzione artistica (su cui non si tratta), per lasciare ogni altro dettaglio alla negoziazione.
Parallelamente, alla sua vertiginosa ascesa artistica viaggia il racconto della sua ricca vita sentimentale che segue le tappe della sua formazione. Con Harlene, la prima moglie, egli si sposa giovanissimo. Sarà proprio grazie alla benestante studentessa che egli potrà sperimentare l’indipendenza economica ed esistenziale, mettendo su casa per la prima volta. C’è poi Louise Lasser, consorte in seconde nozze, bellissima attrice, anche lei colta ed elegante rampolla di buona famiglia. La loro relazione verrà segnata dalla malattia mentale di lei e si consumerà – fra “tormento ed estasi”, repentine euforie e strazianti cadute depressive – stancamente fino al divorzio. In mezzo, arriva Keaton (che lui ama chiamare per cognome), la mitica Diane protagonista di Io e Annie e di alcuni fra i più bei film di Woody. Con lei la relazione durerà poco ma la loro amicizia è destinata a durare tutta la vita. Il racconto delle avventure fra donne e show business è pienissimo, rocambolesco al punto giusto, godibile, la parte migliore del libro, come si sostiene in una sorta di curiosa auto-recensione che il libro offre di se stesso verso la fine: Allen è pieno di affetto e nostalgia per le sue donne con cui si vanta di essere ancora in contatto (“Le donne della mia vita sono state tutte dalla mia parte: Harlene, Keaton, Louise, Stacey”).

Allen con Diane Keaton nel 2017.
Arriva quindi il turno di Mia Farrow. Ed è qui che si capisce come tutto il senso della vita di Woody Allen – oggetto della narrazione – vada riconfigurato in funzione della disavventura su cui sarebbe stato destinato a incappare. Nell’economia del racconto, la vera battaglia, la vera prova glorificante viene da questo sfortunato incontro. È questo niente che dà senso a tutto. Ed è su questo niente che Allen, narrativamente, vuole giocarsi la partita. Tanto che la sua intera esistenza così come è stata raccontata fino a metà libro viene riconfigurata in funzione di questo momento. Non c’è un apice della sua carriera, non c’è una svolta che possa, nel racconto, far pensare che la sua vita potesse aver finalmente trovato un senso, un compimento. Tutto fila liscio, lungo una linea conseguente per cui perfino Io e Annie o Manhattan passano senza che il nostro Allen personaggio si guardi, nemmeno per un attimo, indietro. La vera impresa eroica deve ancora venire, il vero capolavoro – del resto Allen lo ha sempre dichiarato – egli deve ancora girarlo. Di fronte a ciò che sta per essere riferito, allora, il racconto della vita fin qui svolto viene riconfigurato come antefatto, da mettere sul piatto della bilancia in qualità di contrappeso all’attacco di un inaspettato avversario. È così che la narrazione autobiografica rivela il proprio ruolo nell’economia del testo: essa offre l’intera esistenza di Woody come prova della implausibilità delle note accuse di molestie sessuali rivoltegli dalla ex moglie Mia Farrow.
La biografia fino a questo punto raccontata (siamo a circa duecento delle quattrocento pagine del libro), con trasparenza e dovizia di particolari, risulta, infatti, funzionale alla costruzione del simulacro di un narratore che quando sarà costretto ad affrontare la propria disavventura, avrà già costruito un solido patto di veridizione con il lettore, risultando ai suoi occhi pienamente credibile. Il senso complessivo di A proposito di niente, allora, si può leggere all’interno di una tale strategia di costruzione della credibilità: tutto il testo è costruito con l’obiettivo strategico di portar il lettore a credere al narratore, al suo dir vero. E, allora, vale la pena riflettere su come, ovvero attraverso quali procedure retoriche, questo effetto venga perseguito. Si diceva, per esempio, che l’intera narrazione biografica fin qui svolta viene utilizzata a questo fine. È lo stesso narratore a mettere in luce l’asimmetria fra le enormità delle accuse e il resto della vita del cittadino Allen: non si tratta di una vita tutto sommato regolare? Potrebbe mai quella fin qui descritta essere la biografia di un molestatore di ragazzine? La banalità del racconto di vita di Woody viene utilizzata come argomento contro le letteralmente incredibili accuse rivoltegli da Mia Farrow e dal figlio Ronan.
Un altro strumento retorico di fondamentale importanza utilizzato dal narratore in questo frangente è il fatto che questo stesso narratore si impegni a dipanare un racconto coerente dei fatti, offrendo una spiegazione plausibile della razionalità del proprio comportamento di fronte all’imperscrutabile stravaganza dei fatti. Al narratore occorre, insomma, spiegare come possa un uomo maturo essersi trovato in una situazione del genere, nel ruolo di chi prima seduce e poi sposa la figlia della propria compagna molto più piccola di lui (ma non minorenne) e che poi avrebbe, addirittura, rivolto le proprie attenzioni mostruose anche alla di lei sorella, di cui egli stesso, era – per averla adottata – il padre. La ricostruzione che di questo garbuglio fa Woody Allen ottiene di nuovo l’effetto di legittimare la sua versione, risultando perfettamente credibile: egli sostiene di non aver mai avuto un rapporto filiale con Soon-Yi, la figlia adottiva della sua compagna, prima di frequentarla, una volta che la relazione con Mia Farrow era già entrata in crisi. Il loro innamoramento, quindi, si può spiegare come l’incontro fra due persone che appartengono a una medesima cerchia ma sono estranei l’uno nei confronti dell’altra e che, quindi, costruiscono il loro legame da zero. D’altra parte, le molestie sessuali nei confronti della piccola Dylan sarebbero avvenute successivamente alla scoperta da parte di Farrow della relazione, proprio a casa della Farrow, luogo che, come il lettore può presumere, non doveva essere per lui dei più accoglienti in quel periodo e che, quindi, sarebbe apparso a chiunque inadatto per commettere un misfatto di quella portata.

Allen con Moses, Mia, Ronan (in braccio) e Dylan Farrow, intorno al 1987.
Il racconto, ci tiene a precisare il narratore, è portato avanti citando testimonianze e resoconti di soggetti terzi: un tale modo di procedere ottiene l’effetto retorico di rafforzare ulteriormente la credibilità del racconto, ancorandola a un quadro condiviso e pubblico (per lo più documentato dagli atti processuali). Tutto converge verso la conclusione che la storia delle presunte molestie sessuali a lui addebitate sia da ricondurre a una vendetta della compagna per lo scandaloso tradimento di cui egli si era reso artefice. Dylan Farrow – sette anni al momento dei fatti –, nella versione di Woody, sarebbe stata plagiata da Mia a ritenere di essere stata molestata, nonostante le testimonianze dei presenti (il figlio Moses, i ricordi di Soon-Yi) e, soprattutto nonostante i tribunali avessero chiaramente indicato l’inconsistenza dell’accusa, facendo decadere il caso. Rimane a questo punto l’inspiegabilità della reazione così violenta e prolungata negli anni di Mia Farrow e del figlio Ronan: perché un odio così profondo per una relazione che, per quanto poco opportuna, era stata scelta da due adulti consenzienti? Anche questo aspetto viene affrontato da Allen che dipinge Mia e la sua famiglia come psicologicamente instabile (adotta un numero impressionante di figli, li tratta come domestici senza dignità, li umilia e punisce corporalmente, adotta comportamenti inappropriati nei loro confronti etc.). Il racconto della personalità deviante di Mia Farrow è costellato dal rimorso del senno di poi: “Avrei dovuto intuire che aveva avuto tre figli suoi e poi ne aveva adottati altri quattro? E perché? Era insolito, ma non preoccupante. Forse uno più perspicace di me avrebbe colto il segnale di qualcosa che non poteva definirsi semplicemente ‘insolito’. Ma quando guardavo quel faccino alla luce di una candela tendevo a non pensare a queste cose”.
Esplicitare questo tipo di rimestamenti serve retoricamente a coprire una falla della sua versione: egli, come attore razionale, avrebbe dovuto accorgersi di questa stessa instabilità ma essendo innamorato la sua percezione lo porta a sottovalutare tutti i segni del disastro. La sua ingenuità da innamorato è – dentro il racconto – credibile anch’essa. Accanto a questa discolpa si innesta, però, un'altra isotopia, stavolta eroica. La cui struttura è quella della più classica delle favole. Se è, infatti, vero che il caso domina lo scoccare della relazione fra Woody Allen e Soon-Yi, ben presto egli realizzerà come la donna da lui amata fosse a tutti gli effetti stata resa prigioniera dalla madre adottiva sua carnefice. Woody chiede primariamente il riconoscimento di una tale fatica eroica, pagata a caro prezzo con il pubblico ludibrio e l’ignominia, aver ovvero salvato la sua Soon-Yi da una condizione di prostrazione che le impediva di esistere e di affermare la propria personalità. Allen ricorda come Soon-Yi venisse in famiglia considerata come una “ritardata”, una zavorra da trattare senza affetto né rispetto. Averla strappata dalle grinfie di Mia avrebbe significato a tutti gli effetti liberarla: non è un caso che, dopo di ciò, ella abbia potuto mostrare al mondo di che pasta era fatta, laureandosi a pieni voti, prendendo un master alla Columbia e realizzandosi come persona e come moglie. Per questo Woody Allen la ama ed è questo il suo vero orgoglio: aver riconosciuto il suo valore prima di ogni altro ed essere stato conseguente passando all’azione, contro ogni calcolo e convenienza. Egli ha combattuto e ha salvato la sua principessa, ha vinto nonostante il valore del suo gesto abbia mancato ogni riconoscimento pubblico. A lui, del resto, sarebbe bastato sapere di essere nel giusto, continuando a occuparsi dei propri casi, senza tenere nel minimo conto la sua reputazione rovinata. La ricompensa per la sua titanica impresa gli arriva, infatti, comunque; nonostante politici, attori e uomini di spettacolo senza scrupoli dichiarino di non voler avere più niente a che fare con lui. Essa è rappresentata dalla fine delle sue peregrinazioni amorose in nome di una ritrovata stabilità emotiva, dalla fedeltà di Soon-Yi, dalla loro felicità di coppia, dalla fine del rocambolesco e dall’avvento di una rassicurante routine, nella vecchiaia.

Allen con Soon-Yi Previn, alla fine degli anni ’90.
Il matrimonio inaugura, insomma, l’instaurazione di un nuovo ordine, di un nuovo equilibrio destinato a durare per tutta la vita. Allo stesso tempo, segnando definitivamente la fine della vita di Woody Allen che di lì in poi diventa tanto noiosa da leggere per il lettore quanto felice da vivere per il suo autore. Le successive duecento pagine della biografia sono, difatti, un susseguirsi di veloci commenti sui film, con qualche aneddoto su attori, fatti e circostanze notevoli ma niente di più. La vera vita di Woody, fuori dagli aneddoti da dietro le quinte, ci dice, invece, dell’ordinaria amministrazione della felicità:
Soon-Yi e io ci alziamo insieme abbastanza presto, verso le sei e mezzo. Facciamo colazione e un po’ di esercizio fisico. Lei è molto portata e, tra tapis roulant, yoga, gyrotonic, palestra e pilates, è in forma come un Navy Seal. Io faccio il tapis roulant e uso le fasce elastiche per mantenere un fisico degno di una statua di Giacometti. Dopo il tapis roulant, Soon-Yi si occupa delle faccende famigliari, delle ragazze, della scuola, dei campi estivi, delle collaboratici domestiche; controlla le bollette, risponde alle telefonate, organizza le cene. E trova il tempo di leggere il “New York Times” quasi per intero. Ciascuno dei due non fa che ritagliare articoli che pensa possano interessare l’altro. Io scrivo, poi pranziamo insieme e cerchiamo qualcosa di nuovo su cui discutere. Dopo pranzo io continuo a scrivere mentre lei, se è libera, va con un’amica a una mostra o magari al cinema, oppure facciamo una passeggiata. Poi si mette alle orecchie le cuffie che usano gli addetti di scalo negli aeroporti e io faccio esercizio con il mio clarinetto. Spesso vediamo amici a cena o, se stiamo a casa, lei legge e io guardo lo sport in televisione o Un tram che si chiama desiderio, se passa su Turner Classic Movies.
La celebrazione di tale banale rituale quotidiano, da più di venticinque anni a questa parte è, se a questo punto davvero ce ne fosse bisogno, l’estrema conferma dell’innocenza di Woody Allen.
Leggi anche:
Gabriele Gimmelli, Buon 80, Woody. Quasi una commemorazione
Gabriele Gimmelli, Dobbiamo bruciare Allen?
Francesco Mangiapane, Allen: il cliché è un atto politico