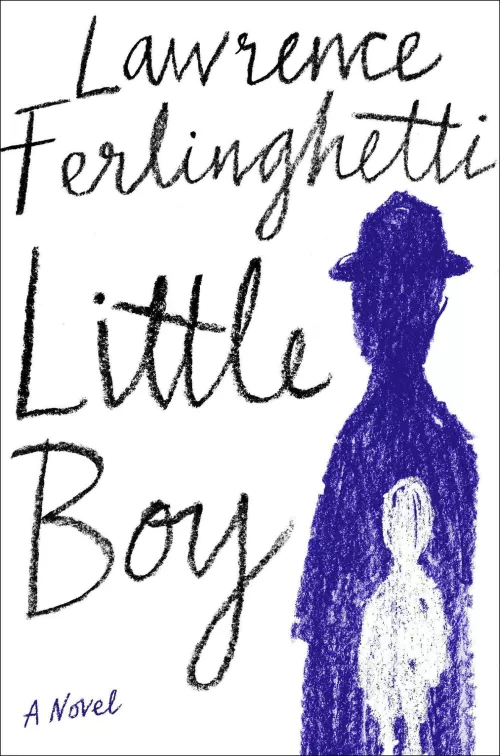Un’autobiografia mancata / Lawrence Ferlinghetti, Little Boy
No, no, no, Lawrence, questo non ce lo dovevi fare. Hai compiuto cent'anni, ti è toccata l’incredibile fortuna, alla tua età, di avere ancora la testa lucida e la mano che corre sulla tastiera, che cosa ti impediva di scrivere semplicemente la storia della tua vita, solo i fatti, bastavano quelli e l’avremmo letta più che volentieri? Perché non ci hai raccontato davvero la tua giovinezza strana, di orfano italiano sballottato tra famiglie francesi e americane, dei tuoi anni a Parigi da studente alla Sorbona, del tuo ritorno in America, della fondazione di City Lights su quell’angolo di Columbus Avenue a San Francisco, di tutti i tuoi incredibili incontri? È vero, sei il Ringo Starr della Beat Poetry, quello che da solo magari non era niente di speciale, ma al momento giusto stava nel posto giusto, e non basta la fortuna, ci vuole il talento di capire che qualcosa sta succedendo e che anche tu la fai succedere, ti vogliamo bene per questo, non lo sai?
Perché invece hai voluto darci un libro come questo Little Boy (trad. di Giada Diano, Firenze, Edizioni Clichy, 2019, pp. 240), che ci fa rimpiangere tutto quello che avresti potuto fare invece? Inizia come l'autobiografia che doveva essere, ma subito, non appena Little Boy diventa un po’ grandicello, perde fiducia nella vita che sta vivendo e comincia ad aggrapparsi ai libri altrui. Doveva essere la storia di un’esistenza straordinaria, invece è una seduta spiritica in cui tu, Lawrence, tenti di evocare i fantasmi di Proust, Joyce, Beckett, St. Vincent Millay, Thomas Wolfe, di tanti altri che nomini ossessivamente senza mai farli tuoi, rovesciando nomi, nomi e ancora nomi addosso al povero lettore, giochi di parole fintamente eruditi, minuscoli, scolasticissimi riferimenti che si riconoscono subito, per non dire di un po’ di Budda qua e un pizzico di Gesù Cristo là, tutto l'armamentario del Beat peggiore, del Ginsberg scoppiato quando voleva farci credere di essere ancora l’ombelico del mondo, tutte le furbizie che si mettono in atto al posto di scrivere sul serio.
Ma tutto va più o meno bene fino a pagina 41. Dopo, cominciano i guai (posso solo rivolgere i complimenti alla traduttrice, che non aveva un compito facile). Nello spazio di due pagine, affollati come in ascensore, stanno il Bardo di Avon, Marcel Proust longtemps, je me suis couché à la bonne heure, il nastro di Krapp, “nei corridoi del tempo il dialogo eterno Sì Ciao ciao Ci risiamo mamma mia il passato ancora con noi riecheggia”, Platone, Baudelaire mon semblable, mon frère, Beckett e il Principe Ham che sta per Amleto-Prosciutto (originale battuta, vero? Era dalla quinta ginnasio che non la sentivo). Seguono Thorstein Veblen, i diamanti De Beers, una tirata contro internet, facebook e wikipedia, il caschetto di Louise Brooks, Kerouac ubriaco, Ginzy (Ginsberg) che corre dietro a qualche giovanotto a cui proporre la sua terapia di conversione gay (ma non sono descritti, sono solo nominati), il fiume Liffey e Buck Mulligan con problemi di erezione, Mao-Tse-Tung mouse-say-tongue, perfino ou sont les neiges d’antan, profondissime domande rivolte a Sartre (“Come fai a sapere che non è tutto un sogno?”) nonché il Subcomandante Marcos che passa per caso e viene a dire scusate ma questa è una rivoluzione.
Dov’è finito Little Boy? Non c’è più, si è disintegrato in un pulviscolo di strizzatine d’occhio come Robert De Niro in Brazil che scompare nel mulinello dei giornali spinti dal vento (lasciate una citazione anche a me). Lawrence, non volevamo sapere quanto ti piace citare i titoli dei libri che vendi nella tua libreria – perché lo fai male, perché il peggior studente di creative writing si vergognerebbe di scrivere tutti questi “eccetera”, “e via dicendo”, “e viceversa” e “mamma mia” che dovrebbero fare tanto scrittura automatica e stream of consciousness.

A pagina 120, e dico 120, ecco che si apre uno squarcio. Siamo nel 1944, Little Boy è nella U.S. Navy, è il D-Day davanti alle spiagge della Normandia, ci siamo, ce n’è voluta ma ci siamo arrivati, adesso Lawrence ci racconterà l’epica di quel giorno come lui l’ha vissuta, la faccia dei suoi trentatré commilitoni a bordo del cacciasommergibili, le loro parole, i loro silenzi, i loro gesti. Macché, Lawrence trova subito il modo di tirar fuori l’Enrico V e la battaglia di Agincourt. Io continuo a sperare, ma spero per niente, i ricordi di guerra durano quattro pagine giuste, subito dopo riprende la rissa dei titoli e dei nomi e siamo daccapo con il Liffey, Stephen Dedalus, il “folle Rimbaud” e il dubbio molto serio: ma quello di René Daumal sarà il Monte Analogo o il Monte Monologo? Si lamenta, il Centenario, del mondo che va a schifio, ma lo sappiamo anche noi, Lawrence, che il mondo va a schifio. Non potevi, proprio tu, dirci qualcosa di diverso da quello che ci ripete ogni conversazione, ogni editoriale, ogni talk show, ogni twitter sulla faccia della terra?
Bisogna arrivare alle ultimissime pagine per ritrovare un po’ di calma, un briciolo di buon senso, anche se appesantito da altri stanchi cameo di Proust e Breton un tanto al chilo (fuggevole apparizione di Nadja, mancava solo lei). Suona sincera, suona vissuta, ma è veramente troppo poco. L’incredibile è che Ferlinghetti abbia pubblicato nel 2020 un libro che sembra una parodia di Tarantula di Bob Dylan, che già a sua volta era una parodia del Beat, con la differenza che Dylan la scrive nel 1965 quando capisce che il suo destino è comporre canzoni, non diventerà mai uno “scrittore” e si congeda dall’istituzione letteraria con un anti-libro che sa di essere tale anche nella sua bruttezza, mentre Little Boy vorrebbe essere proprio “il” libro, la parola fine della lunga avventura della Beat Poetry in tutta la sua furibonda gloria e infinita sciatteria, e non fa che battere disperatamente alle porte della Letteratura, che non gli aprono, non gli aprono proprio.