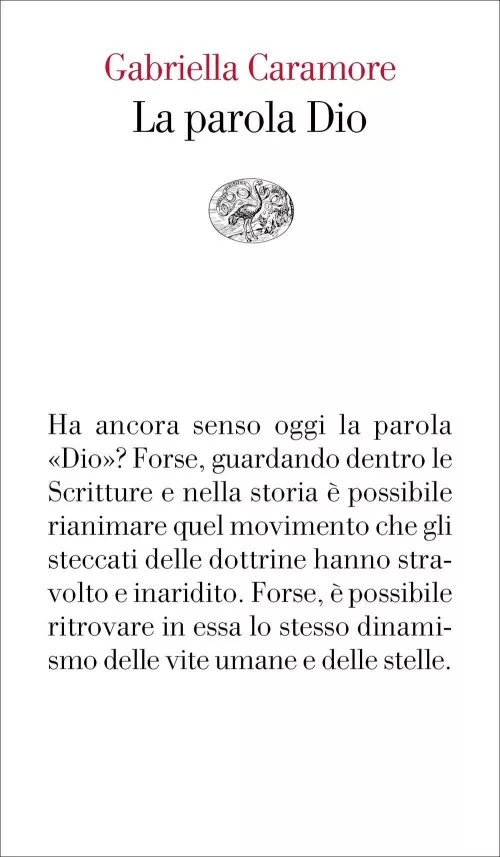Tenere aperto il mistero / Dialogo su Dio
Gabriella Caramore ha insegnato alla Sapienza di Roma, ha scritto molti libri – La fatica della luce, Pazienza e, insieme a Maurizio Ciampa, Croce e resurrezione – e ha curato e condotto per molti anni – dal 1993 al 2018 – una trasmissione di Radiotre, Uomini e profeti, trasmissione che potremmo definire profetica. L’Italia è un paese di tradizioni cattoliche, e sappiamo che “cattoliche” vuol dire molte cose differenti. Ma l’Italia è sempre stata spartita da due forme di clericalismo: i religiosi non parlavano il linguaggio dei laici e i laici non si interessavano di religione, e anzi credo anche oggi rimanga una grande ignoranza su questa realtà antropologica. Già da questo punto di vista credo che questo libro, La parola Dio (Einaudi), sia importante, perché Gabriella Caramore intreccia, con grande abilità, cose profonde a nozioni di base. Ad esempio già nelle prime pagine sottolinea come il nome Dio non si dica in un solo modo: nella Bibbia ebraica Dio si dice in molti modi, non può essere esaurito. E il Nome al di sopra di ogni nome è il nome impronunciabile che non può essere detto. Uomini e profeti quindi ha parlato di religione da parte non solo di credenti ma anche di persone niente affatto “religiose”, ha rotto una barriera invisibile ma molto forte, spingendo sul dibattito inter religioso, e ha contribuito a far nascere un dialogo, un confronto. Questo è quello che poi noi, a Philo, intendiamo con spiritualità laica, una spiritualità che non è proprietà di nessuno; anche un ateo, come la storia del pensiero ci insegna, può essere fortissimamente “spirituale”.
Romano Madera: La parola Dio: ma cosa “diavolo” intendiamo con questa parola? E soprattutto: oggi ha ancora un senso parlarne? Quale senso può avere nel nostro interrogarci oggi?
Gabriella Caramore: Tocchi il punto centrale. Ho sempre considerato questo libro come un libro che si sta facendo, che non ha un punto conclusivo. Un libro provvisorio, in fieri. D’altronde, il pensiero su Dio è inevitabilmente un pensiero fluttuante, ondivago. L’importante è tenere desto il movimento del pensiero. Che cosa “diavolo” è oggi questa parola “Dio”, tu chiedi. È posta bene la questione. In primo luogo a me sembra che in questa fase della nostra storia sentiamo il bisogno di ridefinire tutto. Tutto quello che sta emergendo, la crisi del contemporaneo che stiamo vivendo, era già presente, evidentemente, sotto traccia. Ma questo momento particolare, indotto dalla pandemia e dalle conseguenze economiche e strutturali del nostro sistema sociale, ha messo in luce i punti critici del nostro mondo e, insieme, la fatica che fa il linguaggio a stare dietro a queste crisi e alla nostra esigenza di capire. La domanda dunque è se in questa emergenza la parola “Dio” è una parola che ha ancora senso interrogare o se è parola che molti di noi ritengono superata, usurata, ridotta ai margini. Io credo che siano vere entrambe le cose, è vero che una grande parte di mondo – soprattutto del mondo occidentale, ma non solo ormai – non sente più il bisogno di parlare di Dio, ma è vero anche che le religioni esistono, sono numerose, numerosi gli appartenenti a ciascun credo: si fanno sentire, talvolta esercitano un potere, talaltra in forme aggressive e violente, altre volte sono portatrici di linguaggi sommessi e silenziosi, piccole realtà marginali. Di tutto questo dobbiamo tenere conto. Quando uno dice “Dio” sembra che ci si riferisca a qualcosa che appartiene a un linguaggio comune. Ma non è così. Intanto perché ha innumerevoli significati per ciascuna persona, ma, se guardiamo storicamente, per ciascuna religione, vediamo che sono innumerevoli i modi di intendere questa “parola”. Vi è qualcosa che noi occidentali chiamiamo “Dio” e che altri chiamano con altro nome. Basta pensare a quante modulazioni ha avuto la parola “Dio” dentro alla storia cristiana e al pensiero cristiano, quanti percorsi diversi, quante formulazioni. È chiaro, noi dobbiamo capirci dentro le formulazioni che il linguaggio offre, per cui diamo nomi “semplici” a cose più complesse dei nomi che le rappresentano. Ma oggi bisogna, forse, provare a decostruire quella che noi riteniamo un’ovvietà, provare a capire come è diventata un’ovvietà e se possiamo darle un contenuto un poco più complesso, come forse merita.
Quali strumenti abbiamo per fare questo? Abbiamo la conoscenza della storia: che va dalla complessità della figura del divino nell’ebraismo, alla visione del Dio cristiano, alla figura di Gesù di Nazaret, che è stato inteso come il figlio di Dio, il profeta, l’interprete dei profeti, alle piccole comunità che si sono costituite, all’adesione dei cristiani all’Impero, e poi via via nei secoli tantissime storie diverse all’interno delle quali ciascun credente si è situato in una maniera differente. Ci troviamo in una sorta di labirinto e cosa possiamo fare per non perderci in questo labirinto? Da un lato partire dalle Scritture, che sono state a lungo ignorate o mal comprese, o non abbastanza studiate all’interno della storia cristiana, dall’altro tener conto di come si è evoluta la storia. Adesso la situazione è più dinamica, ci sono tanti gruppi di studi biblici, ma non è sempre stato così, e se noi andiamo a vedere dentro le Scritture troviamo che il testo ci offre una mobilità infinitamente maggiore rispetto a quanto poi le comunità religiose hanno cercato di fare. Non dobbiamo essere moralisti e dire che le Chiese hanno rovinato tutto, dobbiamo capire che in gran parte gli errori sono stati compiuti per cercare di tenere coesa una comunità: per questo si sono stabiliti dei principi. Ma la vita scorre, passa, si trasforma. Spesso le comunità religiose hanno cercato di tenere ferma questa vita.
Se invece andiamo a guardare dentro le Scritture stesse troviamo una varietà e una mobilità di significati che non autorizza una staticità di interpretazione del nome di Dio, ma invece sollecita una ricerca del significato che generazioni e generazioni di credenti hanno voluto cercare per indicare qualcosa di enorme e incomprensibile che sta sopra, o al di là, delle vicende della vita umana.
Ci sono pagine molto belle a questo proposito nel tuo libro, pagine nelle quali si racconta cosa vuol dire Elohim, El Shadday, tutti i diversi nomi che il testo biblico usa per avvicinarsi a questo impronunciabile, a qualcosa che non è esaurito dai nomi. C’è un’altra cosa molto interessante che il libro suggerisce: “nessun timore a mettersi in cerca dei significati della parola ‘Dio’. Sapendo però che lo si deve fare con accortezza, mettendosi sulla scia di una tradizione, di maestri, di studi. Ma accordando un minuscolo credito anche al proprio personale sforzo di un incessante interrogare. Se i nomi di Dio sono tanti, questo accade perché, al fondo, vi è un nome nascosto che le nostre lingue non riescono a formulare, e che il pensiero arranca a voler definire. La stessa cosa si può dire delle immagini di Dio. Nessun Dio può essere visto. Forse non c’è neppure nessun Dio a cui sia sensato dare questo nome. Eppure tante sono le immagini che narrano Dio. Proprio per questo, come vi è un divieto relativo al pronunciare in maniera falsa e vana il nome di Dio, ve ne è uno, parallelo, che vieta di farsi immagini di Lui. Forse per proteggere la sua nascosta presenza in noi”. Tu, con questo elegante “minuscolo credito al proprio personale sforzo”, richiami a una lettura responsabile e critica.
Sì, dico “minuscolo credito” perché ovviamente non bisogna essere presuntuosi e credere di avere le chiavi di quel che si legge. La tradizione ci fornisce già abbondantemente innumerevoli strumenti di conoscenza. E tuttavia sta anche in ciascuno di noi la responsabilità di esprimere, anche silenziosamente, anche non clamorosamente, nel chiuso della propria stanza, il proprio pensiero o il proprio sentire – che poi sono la stessa cosa – su questa immagine di Dio. È una responsabilità perché nel nome di Dio sono stati compiuti i più efferati delitti e nel nome di Dio sono state compiute anche le azioni più belle. Forse un punto di partenza potrebbe essere cercare di capire che cosa ha tenuto insieme questa ricerca dell’umano, che cosa ha unificato nella storia umana questi cercatori di Dio, o, come li chiama André Neher, “i rabdomanti della luce”. Bisognerebbe andare a tentoni a cercare qualcosa, una piccola luce appunto, che possa illuminare il cammino. Da una parte potrebbero cadere le immagini troppo rigide di Dio che abbiamo ricevuto, e dall’altra potremmo ritrovare quei chiaroscuri intorno al nome di Dio che riflettono i chiaroscuri della vita. Le immagini che sono state date di Dio sono tantissime – Dio violento, che condanna, che consola, il Dio che solleva il povero dalla polvere, che abbatte i troni dei potenti –: a quale credere? I fondamentalisti di tutte le parti chiamano a sé l’immagine di Dio. Abbiamo visto in Francia una recrudescenza dell’islamismo violento e assassino, di fronte al quale non possiamo che piangere e manifestare la nostra protesta. Ma non dobbiamo dimenticare che c’è anche un fondamentalismo cristiano, forse in questo momento meno violento, ma che comunque sostiene il suprematismo bianco fomentatore di odio (per non parlare di come si è manifestato nei secoli passati). Allora è vero, mi sembra, che occorra guardare con responsabilità e cautela questa parola “Dio”, per capire come possa essere non di ostacolo, ma di soccorso al mondo.
Questo elemento del “soccorso al mondo”, così come la citazione insistita su “tirare giù i potenti dal trono” si tratta di citazioni dei profeti della Bibbia ebraica, e anche del Magnificat di Maria di Nazareth, straordinario testo profetico. Volevo leggere un pezzetto per far innamorare del libro anche l’orecchio; sono parole su Maria di Nazareth e Anna, la madre di Samuele, che citano a loro volta la Bibbia ebraica, e che si rifanno alla tradizione profetica, che è una grande riserva critica. Prima abbiamo parlato di una lettura critica con il minuscolo apporto nostro – e anche questo è molto biblico, Abramo è uno che discute con Dio – e ora abbiamo questa questione della passione profetica, che è quello che dal nome Dio possiamo ricavare per la nostra vita sulla terra: “Proviamo a considerare, invece, quella ‘passione’ del profeta che lo spinge a uscire dalla propria ritrosia con un atto di coraggio e di generosità: è evidente che i popoli precipitano verso la rovina se si corrompono, se si illudono di possedere una forza che non hanno, se non guardano con lungimiranza, e se non hanno dalla loro un senso della giustizia e del diritto. Il profeta non fa il ‘servo sciocco’ del potere. Osa dire quello che gli altri per viltà non dicono. Osa denunciare. Osa essere critico, non ossequioso, osa smascherare, non occultare. Questa è la verità che ci mostra, a cui dobbiamo prestare attenzione”.
Ai profeti mi sono appassionata forse anche a motivo del titolo della trasmissione, “Uomini e Profeti”, ma forse anche per la difficoltà che si incontra leggendoli. Vi si trovano prospettive che a prima vista sembrano inaccettabili per la contemporaneità. La pretesa di essere portavoce della parola del Signore, la pretesa di conoscere la verità, la visione punitiva delle colpe dei popoli, una visionarietà che oggi può apparire ingenua. Ma se noi proviamo a riconsiderarli, tradurli nel linguaggio del nostro tempo, vediamo che forse oggi la profezia ha molto da insegnarci. Innanzitutto il profeta è persona di coraggio, responsabilità, dedizione. Fa qualcosa che non è per sé stesso ma per la comunità, per il “popolo”. E ha il coraggio di contraddire i potenti, di rischiare la propria vita, anche se non ne avrebbe proprio voglia. Di questo ci parla oggi il profeta: della responsabilità. Allora sì, se facciamo uno sforzo per capire i testi profetici nel loro linguaggio simbolico, se possiamo leggere i profeti e ascoltare il loro linguaggio visionario, possiamo capire che quello che prevale è la responsabilità nei confronti della comunità. Il profeta, poi, per il fatto di annunciare la parola di Dio, dice la verità: anche la parola verità ci mette oggi in questione. Oggi sappiamo che la verità non ci appartiene, che non possiamo raggiungerla, che tra noi e la verità ci sono abissi di universi da sondare. Però c’è anche il coraggio della sincerità, e questo è già molto, è qualcosa che possiamo capire e fare nostro. Inoltre, anche dire la visione implica coraggio.
Può sembrare una favoletta quella del lupo che pascolerà con l’agnello e le spade trasformate in aratri. Però è una possibilità nella vita degli esseri umani, rovesciare le visioni correnti è una possibilità che è stata data qui e là nella storia. Ecco allora che l’utopia può farsi progetto: non ci arriveremo, ma possono aprirsi piccoli varchi in cui qualche cosa sia realizzabile. Un altro elemento che dobbiamo oggi interpretare è il fatto che il profeta lavora per il “popolo”: è chiaro che oggi noi non possiamo più guardare a un unico popolo come destinatario di una parola di Dio, ammesso che possiamo parlare di Dio in questi termini. Oggi siamo tenuti a guardare a un’universalità dei popoli. Ma appunto, se invece di “popolo” consideriamo la comunità di viventi, e questo possiamo farlo, perché nei profeti troviamo questo allargamento, possiamo assumere tutta la forza, la dirompenza, il coraggio, la visionarietà dei profeti e tradurla in termini contemporanei. Questo mi pare un possibile uso delle Scritture che in gran parte sono invece state imbrigliate dentro norme morali, regole di vita, catechismi, principi di autorità.
Tu infatti parli della grande utopia: questo rapporto tra il profetismo e la possibilità visionaria, utopia non come qualcosa da realizzare nell’immediato – altrimenti si fanno disastri – ma come orientamento, criterio. E tornando alla questione della parola “Dio”, c’è un fatto indiscutibile, che “Dio” è una parola. Ma che razza di realtà si può pensare per questa parola? Le parole producono fatti, trasformazioni, e dunque mi pare che nell’insieme del libro – e il libro finisce così – ci sia un’idea forte che lo attraversa: Dio ha tanti nomi ma in fondo è un nome impronunciabile. Il libro si chiude in un nome che non ha nome. E questo lo diceva anche un grande mistico cristiano, cattolico, moderno: Thomas Merton. Diceva che il nome di Dio è x. La tua idea è di far vedere che se rovesciamo il modo con cui abbiamo chiamato in tanti modi Dio, otteniamo qualcosa che forse ci dice di più sulla realtà della parola. E cioè: Dio è giustizia, Dio è misericordia, Dio è amore, Dio è insieme. Rovesciamo, piuttosto: la misericordia è Dio, l’amore è Dio, il bene è Dio, il mistero è Dio. Il mistero è un nome che non ha nome. Tutto questo possiamo rapportarlo a qualcosa che ci riguarda intimamente, come suggeriscono queste parole del tuo libro: “Certamente c’è una domanda di salvezza che non è comprimibile. Chi è nel dolore o nel bisogno estremo invoca una risposta. Che venga da Dio o da un essere umano non sta qui la differenza. Chiunque ci tragga in salvo, per un momento, è Dio. Talvolta la salvezza viene. E rinasce il giorno. Altre volte la risposta non arriva, arriva solo il silenzio e la sconfitta. Ed è notte e fine di ogni cosa”. Tra l’altro per coloro che si riferiscono al cristianesimo, è interessante ricordare che Gesù vuol dire Dio salva, il significato è: chi ti porta salvezza? Questo è Dio.
Nel caso di Gesù: chi ti porta salvezza? Questo è un uomo. Un uomo che ti viene incontro e dunque lì, in quella umanità che si fa incontro, può stare la salvezza. Io credo che questo rovesciamento sia anche qualcosa di semplice da pensare. Se si continua a parlare di Dio come un soggetto, se si continua a dire che “Dio è giustizia”, “Dio è misericordia”, “Dio è amore”, in fondo lo si rende un oggetto dei nostri pensieri, dei nostri credo, delle nostre illusioni. Ne facciamo un “complemento oggetto”, qualcosa di astratto che non parla più ai cuori e alle menti di noi contemporanei. Se invece rovesciamo la prospettiva, e proviamo a dire che a quel bisogno insopprimibile di giustizia gli esseri umani hanno provato a dare un nome grande, un nome fuori dal comune, un nome quasi irraggiungibile ma necessario che è il nome di Dio; se quel bisogno essenziale per la vita comune che è la misericordia, cioè gettare il cuore dalla parte degli infelici (Bonhoeffer diceva che, in fondo il cristianesimo è un guardare il mondo a partire dal basso) le generazioni lo hanno chiamato “Dio”; se per quell’amore che è più grande di ogni altro amore è stata usata la parola “Dio” – allora possiamo. Questo nome rimane perché ha dato corpo, ha dato visione, a queste esigenze insopprimibili dell’essere umano – giustizia, amore, libertà – che hanno poi assunto diverse forme nella storia ma che qualcuno ha chiamato con il nome più grande, con il nome di Dio.
Volevo farti commentare un inizio e una fine del libro che ritornano su questo punto ma in un modo tanto concettuale quanto narrativo. Il libro si apre raccontando un episodio che fa parte di frammenti autobiografici di Martin Buber. Buber si trova con un vecchio professore e gli legge un testo e in questo testo, alla fine della lettura, “il professore, sul cui volto si dipingeva un crescente stupore – gli occhi ardenti, la voce alterata –, chiede a Buber: ‘Come fa a ripetere tante volte la parola Dio’?”. Ci sono qui righe strepitose di Buber, una meravigliosa apologia della parola Dio, e il commento della Caramore è “si può ancora pronunciare la parola ‘Dio’ dandole un significato che vada al di là di una inerte sopravvivenza?”.

Alla fine del libro ritorna questo episodio e qui il commento è “ma nel momento dell’invocazione forse è legittimo pensare a un azzeramento di ogni memoria storica, all’assottigliamento del nome invocato, fino a dissolversi in un nome che non ha nome. Del resto, questa instabilità del nome non era suggerita anche nei testi della tradizione? Inoltre, Buber stesso ci viene in soccorso con le parole che chiudono il suo racconto: ‘La stanza si era fatta molto chiara. La luce non fluiva più: c’era. L’anziano signore si alzò, mi si avvicinò e pose la mano sulla mia spalla dicendo: vogliamo darci del tu? Il colloquio era finito. Poiché dove due persone sono veramente insieme, lo sono nel nome di Dio’. Noi potremmo provare a riprendere il pensiero di Buber e dell’anziano professore, cercando di non tradirlo, ma considerandolo, un secolo dopo, dal nostro punto prospettico appena in parte trasformato. Quando due persone riescono a incontrarsi in maniera profonda e vera, e si riconoscono l’una nel volto dell’altra come esseri umani facenti parte di una stessa avventura, comprendono che ogni itinerario terrestre va considerato alla luce di qualcosa di più grande della singolarità dell’individuo. Va considerato alla luce di quella parola, ‘insieme’, dentro la quale si snodano i percorsi delle vite umane, che non possono prescindere le une dalle altre. E che neppure possono prescindere dal sentirsi avvolte dall’immenso silenzio dei mondi sconosciuti. Ecco forse a questo essere ‘insieme’ si può anche dare il nome ‘Dio’.”
Sì, si potrebbe anche dire il contrario di quello che dico chiudendo il libro, forse quel “nome di Dio” con cui chiude Buber si potrebbe anche tradurre nell’essere “insieme” degli esseri umani. Questo essere un “tu” l’uno per l’altro è fondamentale nel pensiero di Martin Buber. Ma questo essere “insieme” di tue “tu” forse rende anche inessenziale il ricorso al nome di Dio. Ma qui si può aprire anche un altro discorso. Gran parte del percorso di questo libro è volto a considerare l’aspetto umano delle dimensioni che portano a elaborare qualcosa a cui viene dato il nome di Dio. Ma “Dio” è il nome che è stato dato anche a ciò che non conosciamo, all’inconoscibile verso cui tendiamo, a quell’anelito di ricerca che muove al desiderio di sapere, di uscire fuori da sé e dai propri confini per andare verso un altro che rimane enigma e mistero. Mi soccorre sempre il pensiero di Pascal e del suo sgomento di fronte ai cieli stellati. Oggi i nostri cieli stellati sono più profondi, più lontani, man mano che la ricerca scopre nuove dimensioni del reale per paradosso il nostro conoscere si fa più incerto. Possiamo continuare a dare il nome di Dio anche a tutto questo? Forse. Soprattutto possiamo capire che quando leggiamo i testi che lo nominano, che lo invocano, che lo maledicono, che gli rendono grazie non è a qualcosa di vuoto che si riferiscono, ma a una appassionata ricerca di un senso nelle vite dei mortali. In questo ripensamento del nome di Dio si possono ricongiungere le due dimensioni: quella volta all’umano e quella volta al desiderio di conoscenza della vastità in cui siamo immersi.
Su questo vorrei fare due osservazioni: le belle pagine a proposito del sentimento oceanico, o sentimento dell’immenso; tra queste pagine quelle sulla considerazione contemplativa da parte di una grande fisico. “Heisenberg, ancora ragazzo, già appassionato di fisica e di filosofia, una sera del 1919, a guerra mondiale da poco finita, si ritrovò nel castello di Prunn, in Baviera, con altri giovani studenti, a discutere dell’avvenire della scienza, travolto quasi suo malgrado dalle nuove scoperte e dai nuovi linguaggi. Il giovane Heisenberg è stanco, confuso, scoraggiato dalla percezione dell’assenza di un ‘ordine globale’. Ma ecco ‘nel grande cortile del castello le ombre si allungano, scese la luce grigia del crepuscolo e poi la notte rischiarata dalla luna. A questo punto, su una balconata, apparve un ragazzo con un violino. Si fece silenzio e risuonarono i primi grandi accordi in re minore della Ciaccona di Bach. Di colpo, con assoluta certezza, seppi di aver trovato il collegamento con quel centro che mi mancava. Il limpido fraseggio della Ciaccona spazzava via le nebbie mostrandomi le gigantesche strutture che fino ad allora mi erano rimaste nascoste’. Chi potrebbe dire che la Ciaccona di Bach, ascoltata in quella particolare congiuntura, non fosse una preghiera?”. E a questo volevo aggiungere una cosa a proposito della questione dell’inconoscibilità, del mistero, una considerazione di un grande teologo cattolico, Karl Rahner che, nel primo capitolo del Trattato sulla Fede, dice una cosa semplice e geniale, una cosa che rimette in rapporto tutta la modernità, lo sviluppo della scienza, con il problema Dio. Mi sembra che sia qualcosa abbastanza vicino a quello che dici tu e al sentimento di Heisenberg. Rahner teorizza una conoscenza atematica di Dio, una conoscenza che non si può costringere in un detto, in un nome, in un concetto, che non si può mettere a tema, “e, da questo punto di vista, siccome la conoscenza più si approfondisce più si approfondisce il mistero” – sia nell’infinitamente piccolo che nell’infinitamente grande – “il progredire della conoscenza aumenta il mistero”. Mi sembra che così un percorso teologico si accosti anche alla nostra percezione del cosmo, ovviamente influenzata dalla scienza contemporanea e possa accordarsi perfettamente con il progredire delle stesse conoscenze scientifiche.
Intanto voglio dire che ogni volta che leggo le parole di Heisenberg mi vengono i brividi. Sono di una tale bellezza, pensando poi al dramma che ne è seguito. Pensare a questo ragazzo che ascolta questa musica che arriva per caso nella notte e capisce cosa gli manca, di cosa è in cerca. Quanto a Rahner: quando si arriva a una conoscenza atematica di Dio forse non c’è neppure più bisogno di metterlo a tema, forse dobbiamo trovare altri nomi, tenuto ovviamente conto della molteplicità della nostra realtà, delle comunità dei credenti, delle Chiese. Però, a un altro livello, forse possiamo dire che non c’è più bisogno di mettere a tema Dio, ma di mettere a tema la conoscenza, il nostro slancio verso il desiderio di conoscere. In questo senso la musica, la poesia, sono tutte espressioni che forse non possono essere dette atematiche ma che non hanno un confine delimitato, aprono a qualcosa che non si può dire, all’indicibile, appunto. Come Dio. Certo, sono dimensioni parallele che non possono essere unificate: da un lato uno slancio verso quel che non possiamo conoscere ma non possiamo non desiderare di conoscere, e dall’altro una dimensione prettamente umana in cui c’è bisogno di libertà, giustizia e misericordia. Mettere insieme queste due cose io credo sia la scommessa più difficile ma anche la scommessa che dobbiamo giocarci, perché la religione entra nei vissuti minuti, nel quotidiano delle persone, ma è necessario tenere aperta la porta verso il mistero, altrimenti ci richiudiamo dentro e crediamo di avere la soluzione per tutto.
A questo proposito la valenza concreta nelle nostre vite è un’altra declinazione, ma forse la declinazione che può raccoglierle quasi tutte, se non tutte, di ciò che ha a che fare con il senso. Cito due cose. “Sia chi conserva la fede, sia chi se ne sente distante dovrà inevitabilmente vagliare al setaccio del tempo ciò che oggi non si può neppure ascoltare. Ma potrà farlo con serenità. Sapendo che ciò che oggi intendiamo con giustizia, misericordia, pace, verità e libertà ha la sua culla anche e proprio in quelle preghiere. Il lettore contemporaneo, poi, farà fatica a pensare che quegli esseri in preghiera si attendano veramente che le loro invocazioni vengano esaudite. Oggi ci vorrebbero anime antiche per avere la certezza di essere ascoltati. E tuttavia credo che, al fondo, si possa dire che il senso più nascosto della preghiera, nascosto come in una nube, non sia quello di attendersi la risoluzione dei propri drammi o problemi, ma la speranza di comprendere a fondo quale sia il sentiero da percorrere nella vita”. Mi permetto un breve commento: i due termini ebraici per dire “peccato” si possono tradurre con “sbagliare la strada, non colpire l’obiettivo”, non trovare il sentiero giusto da percorrere nella vita. E infatti scrive Caramore citando Heschel “questo ci permette di chiarire che cosa è essenziale e che cosa non lo è per ciascuno di noi. Certamente per Heschel Dio non è un nome, ma una realtà. Solo quando quel nome è vissuto come realtà, e non come proiezione idolatrica della mente – penso si possa dire così –, esso orienta le vite verso il bene”. Il mio accento cade su “orienta” e su “il sentiero da percorrere nella vita”: potremmo dire allora che il problema di Dio o non Dio – possiamo chiamarlo come ci pare – è che non possiamo evitare il problema buttando via la parola. Dio o non Dio, il problema è: quale è il sentiero da percorrere nella vita? E questo ci accomuna tutti. Solo per questo vale la pena interrogarsi. In qualche modo la parola Dio credo che contenga in modo eminente, nella storia dell’umanità, questo problema.
Sì. Il sentiero da percorrere nella vita. Qui torniamo all’elemento della libertà e del rischio. Nessuno ce lo dice, neppure i comandamenti ce lo dicono, sono indicatori di cammino dentro cui ci può stare di tutto. Cito un detto dei Padri antichi della tradizione rabbinica che dice “non sta a te compiere l’opera, ma non sei libero di sottrartene”. Figuriamoci se tu, piccolo essere umano, puoi arrivare al compimento di un’opera, però hai la responsabilità di fare fino in fondo tutto quello che puoi fare.
Ci sono appartenenze, ciascuno si ritrova nella sua storia e nella sua tradizione, ma forse non si tratta nemmeno più di costruire il dialogo tra le religioni, anche perché una religione è un insieme di tali tante e diverse identità che forse il nodo deve esser spostato. Ciascuno lavori dentro la dimensione in cui gli accade di vivere, con il proprio bagaglio culturale e umano, ma il problema è cercare un minimo comune denominatore di tutta l’umanità: cosa sono i diritti, cosa i doveri, quale è il compito verso l’umanità – come avrebbe detto Simone Weil che non amava il binomio diritti doveri perché troppo burocratico. Ognuno deve portare il proprio contributo, c’è un compito che abbiamo verso ogni essere umano, un compito che è dare pane, casa, cibo, bellezza, conoscenza, libertà, dignità. Lavorare su questi. È utopia? Certo, ma non siamo liberi di sottrarcene. Poi vanno bene le preghiere, il dialogo inter religioso, ma ho l’impressione che a volte questi siano contenitori, certo contenitori più sani dell’inimicizia, ma non è dentro questi nomi che troviamo il momento unificante. Il momento unificante si trova in basso, partendo dalla comune umanità che viviamo, e allargherei questa umanità al vivente, al rispetto per gli animali, per le piante, per la terra.