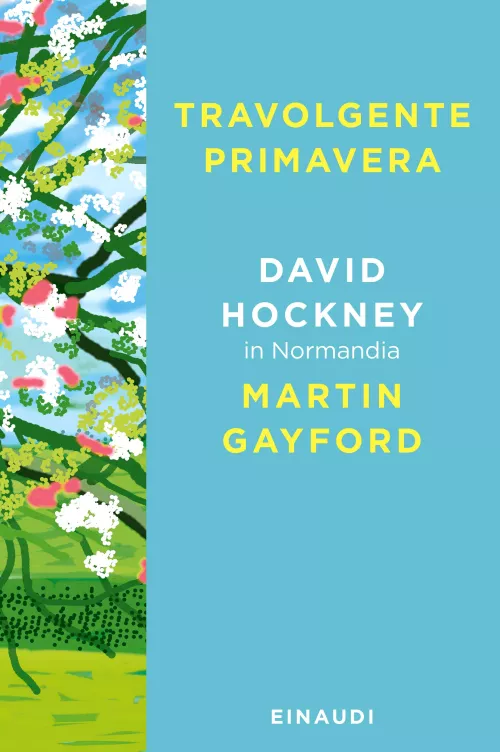Hockney barocco
Pavel Florenskij è stato un prete, matematico, ingegnere e scienziato russo, nato a Evlach nella Russia zarista nel 1882 e morto a Leningrado sotto lo stalinismo nel 1937. Tutti gli appassionati di arte, letteratura ed estetica lo dovrebbero conoscere, perché a lui si deve una revisione della prospettiva rinascimentale, o lineare, fondata sull’idea della simultaneità dei piani, per cui l’occhio non guarda un’immagine fissa, ma si sposta continuamente nello spazio, come avviene nelle icone russe medievali. Le idee tradizionali di spazio e tempo oggettivi e misurabili venivano messe in crisi, alla luce delle nozioni di «corrugamento» e «curvatura», che sono i luoghi dove spazio e tempo s’interrompono per la presenza delle cose, manifestazioni del divino, che impongono la scissione tra il prima e il dopo, tra il qui e l’aldilà, tra l’esteriore e l’interiore: «quella di Florenskij – ha scritto il grande storico delle religioni e studioso di mistica Elémire Zolla – è un'estetica nata sul ciglio della voragine, dopo di essa l'arte sarebbe sparita, sostituita da esposizioni di sterco, balbettii, installazioni».
Fuori dai radar del mondo dell’arte contemporanea in quanto espressione di tutto ciò che deve restarne escluso (cristiano, profetico, irrazionalista e ascetico), Florenskij si colloca in realtà in una strana posizione di confine tra lo spiritualismo russo di fine Ottocento e le avanguardie europee di primo Novecento: in dialogo profondo con Tolstoj, Gorki e Bulgakov, è stato tanto perseguitato da Stalin quanto cancellato dalle estetiche occidentali. Poteva permettersi di riscoprirlo e rilanciarlo solo un artista ottantaduenne, tanto affermato da aver conseguito il record del prezzo più alto per una vendita all’asta di un vivente: David Hockney, che da anni si diverte a scandalizzare i benpensanti del mondo dell’arte con le sue provocazioni, immediatamente consacrate e incredibilmente redditizie, all’insegna di quella totemizzazione commerciale che è ormai la guida dei miliardari che fanno affari con l’arte. Può goderne gli effetti positivi ed evitare di farsene imprigionare, Hockney, perché è ormai oltre e al di sopra, al punto da potersi comprare in pochi mesi una villa in Normandia per farne il centro della sua ispirazione artistica, come racconta il suo fedele compagno e osservatore Martin Gayford, il suo Boswell, dicono gli inglesi, memori del grande biografo James Boswell, che seppe raccontare nei minimi dettagli la vita dello scrittore Samuel Johnson.
A (e con) Hockney Gayford ha già dedicato due libri e mezzo (A Bigger Message del 2011, A History of Images a quattro mani con lui nel 2016 e Modernists and Mavericks del 2018), ma farne solo un pigmalione sarebbe ingeneroso, nonostante l’abitudine sempre più frequente dei critici di associarsi come vestali ai grandi artisti per viverne di luce riflessa: non è questo il caso, però, perché Gayford ha una sua storia autonoma di critico d’arte prima dell’incontro con Hockney e perché il suo dialogo col pittore anglo-californiano è in realtà molto di più che un lavoro su e con Hockney. Si tratta infatti in primo luogo della storia di un’amicizia, fondata su complicità intellettuali e segni di appartenenza, ma anche su episodi di condivisione e confronto, al punto che di vera e propria autofiction si potrà parlare, in quanto Gayford è narratore e personaggio anziché solo critico. Questa modalità, d’ispirazione proustiana, di fare critica e storia attraverso le vicende personali è senz’altro legata alla svolta verso l’aneddotica di gran parte della cultura accademica anglosassone, ma ha il grande pregio di immergere la critica nel vissuto anziché ammantarla di presunzioni di oggettività e discernimento: la critica si fa onnivora a partire dal presente, che è il suo unico punto di vista, totalizzante e abbacinante.
Torniamo a Florenskij: è da qui che il libro più recente (Spring Cannot Be Cancelled, appena uscito da Einaudi come Travolgente primavera nella traduzione italiana di Chiara Stangalino) prende le mosse, perché tutta la storia verterà sullo sguardo, com’è inevitabile e doveroso quando si tratta di un artista visivo. In Normandia, nella villa acquistata all’improvviso da un pittore ottantaduenne (oggi ottantacinquenne), prende corpo, grazie anche all’isolamento provocato dalla pandemia, un’esperienza estetica che rimette in gioco la concezione dello spazio, a partire da quello studio dell’artista (tra studiolo e atelier) che ha tanto segnato la storia della cultura occidentale: un luogo immersivo, dove l’artista si vede in mezzo alle sue creazioni, perché questo lavoro, dice Hockney, non può farlo se non chi ama i risultati di ciò che fa.

Quest’inciso, «dice Hockney», rivela l’andamento umorale, da scrittura romanzesca, dello stile di Gayford, che sembra narrare in terza persona, al passato, quasi cronachisticamente, ma all’improvviso fa venir fuori la testimonianza in prima persona, dalla voce di chi sta dentro al racconto, fino a mescolare sorprendentemente i linguaggi, dalle email che i due si sono scambiati fino a lettere, affermazioni apodittiche, pezzi di dialoghi e citazioni d’autore isolate.
È così che un libro apparentemente antipatico, perché nato dalla storia di un miliardario che s’incapriccia di un luogo e se ne compra una porzione, diventa improvvisamente simpatico, perché questa storia si anima, incontra scelte e proiezioni di vita, si fa storia dell’arte, confronto e dialogo col passato e col presente, riflessione critica, proposta interpretativa, bisogno di senso e ricerca di consenso. I due attori principali, Hockney e Gayford, che parlano attraverso internet con in mano una birra e un calice di vino rispettivamente, lasciano la loro postazione narcisistica di privilegiatissimi altoborghesi per diventare protagonisti di un confronto serrato su quello che l’arte è stata e può diventare.
A partire, appunto, da quello sguardo che Florenskij libera dall’obbligo di guardare dritto, dentro l’immagine, per spostarlo di continuo attraverso l’immagine, radendone i bordi, approfondendone i dettagli oppure semplicemente oltrepassandola con l’immaginazione. Un altro mondo si dischiude, per cui dai salotti dei due amici entriamo nelle immagini di cui sono intrisi i loro confronti.
Spazio e tempo sono perciò i due veri protagonisti del libro: «È per questo che ho sempre detestato il comunismo: – dice a un certo punto Hockney – l’idea di dover sacrificare il presente nel nome di un futuro meraviglioso. Ma come fai a sapere che sarà meraviglioso? Nessuno lo sa. Bisogna vivere nel qui e ora». A parte che ad annientare la vita nel nome dell’attesa è probabilmente più il consumerismo che il comunismo, è tuttavia in questo rifiuto di ogni dimensione messianica, dell’eterna speranza come dell’eterno presente, che sta l’idea centrale dell’arte come capacità di vedere l’imprevisto nel disordine: citando il poeta barocco Robert Herrick, «un laccetto trascurato, nel cui fiocco / intravedo un garbo selvaggio / mi ammalia di più, che quando il tocco / è troppo esatto, in ogni sua parte» (da Delight in Disorder). Barocco è certo termine che non è facile accostare a Hockney, con la sua gioia del disegno e del colore, ma è forse l’unico modo, alla luce della lezione di Benjamin, di riattivare Florenskij in una prospettiva meno spiritualista e più esistenzialista, in quella dialettica tra ambizione del quadro alla fissità e rifiuto del mondo a farsi catturare che è la costante della storia dell’arte vista da lui, fondata sul flow, il flusso, che è l’immersione totale in ciò che si fa: come quando Monet cercava di fare ciò che Eraclito riteneva impossibile, accedere allo stesso momento due volte.
Non più a Herrick, ma a George Herbert, altro poeta barocco, Hockney si rivolge verso la fine del libro, per rendere esplicita la sua ossessione di come rappresentare qualcosa che oltrepassa lo sguardo (da The Elixir):
Un uomo che guarda un vetro
Può fissarvi sopra il suo sguardo
O, se vuole, può guardarvi attraverso
E spiare così il cielo.
Realtà transizionale, il vetro, che riassume quello che l’arte, per Hockney, è sempre, se è tale: un processo di traduzione. Mi rendo conto di aver parlato finora più di letteratura che di arte, più di poesia che di immagini, ma è il paradosso della critica d’arte, quello di commentare l’opera visiva o musicale con le parole anziché con altre immagini o suoni: di immagini però il libro è intessuto, perché sono le immagini, delle opere di Hockney o di quelle di artisti del passato, a definire lo spazio del libro, la sua cornice mentale, nell’ambizione a costruire un libro che include un mondo da vedere che al mondo esterno rimanda ancora, in un inesauribile e infinito gioco di specchi. Il rischio è forte e vale la pena correrlo: che Gayford prevalga su Hockney, la parola domini l’immagine e la spiegazione cancelli la suggestione. Forse, però, si potrà rispondere con una di quelle osservazioni che rasentano l’ovvietà, tra il sofisticato e l’inequivocabile, come pretende lui, del protagonista del libro:
Se ci pensi, l’acustica di una registrazione è diversa da quella della stanza in cui ti trovi quando la ascolti, e sei quindi in una situazione ben diversa. Senz’altro questo crea una distanza.
Distanza è altra parola-chiave, che impone il passaggio, la presa di coscienza e l’assunzione di una posizione. Pieno di letteratura, tra Flaubert, Proust, Joyce e Barnes, di musica, da Tiomkin a Prokof’ev a Wagner, ma soprattutto di quadri, da Rublëv e Hobbema a Picasso e Munch, questo libro si può leggere saltando le pagine, guardando le immagini, entrando nel diario dei due amici, o spiluccando qua e là, perché è una biografia intellettuale, un’autobiografia di un’amicizia, una tac di due cervelli in sintonia, e un fuoco d’artificio di frammenti poetici. Ne viene fuori una falsità enorme: che tutta l’arte si riassume nell’esperienza di Hockney; ma non sono forse proprio le falsità ciò che più ci attira nei libri?