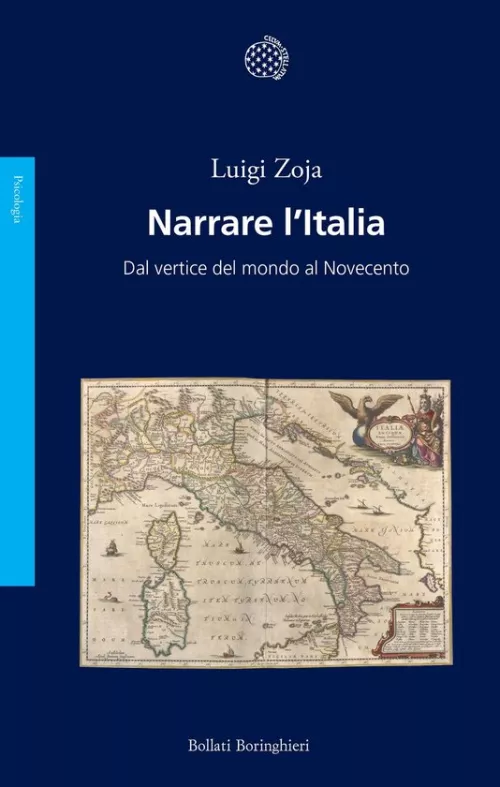Luigi Zoja: l’Italia sul lettino
In un rapido scambio epistolare che gli storici degni di questo nome dovrebbero avere sempre presente, a Renato Serra che sosteneva l’impossibilità di tradurre la storia in narrazione per evitare di snaturare l’autonomia dei fatti attraverso la logica del racconto, Benedetto Croce replicava che la storia non si trova «fuori di noi», ma «dentro di noi», rivendicando l’unità dello spirito come misura della presa di coscienza della storia stessa, che può essere raccontata proprio in quanto sempre e comunque tende al presente.
All’assunto crociano sembra tornare ora Luigi Zoja, psicanalista junghiano, con un libro che di crociano, va detto subito, non ha nulla (ma con Croce è opportuno confrontarsi perché da lì discende il fatto che psicanalisi e storia non siano andate mai molto d’accordo, in Italia): un’esplorazione a tutto campo della storia d’Italia, al fine di comprendere come ciò che chiamiamo «Italia» si radichi nell’insieme delle narrazioni che la caratterizzano. Narrazioni che sono rappresentazioni emotive della collettività anziché ricostruzioni storiche, tuttavia, perché il racconto della storia è manifestazione dell’inconscio collettivo, dove si annidano quegli archetipi che soli spiegano l’assunzione di un’identità comune, al di là delle individualità. Zoja mette l’Italia sul lettino per proporre una prospettiva terapeutica fondata sull’organizzazione della memoria: per liberarla dall’«inflazione psichica», che porta l’individuo ad espandersi verso la rappresentazione di un consenso di cui l’interprete e il garante è lui stesso (legata soprattutto ai culti della «grande Italia»).
Il libro ripercorre quindi la storia d’Italia (affidandosi soprattutto alle ricostruzioni degli storici più autorevoli nel dibattito pubblico, da Denis Mack Smith a Mario Isnenghi, Alberto Mario Banti ed Emilio Gentile) «dal vertice del mondo al Novecento», secondo uno schema narrativo consolidato: dal Rinascimento, considerato l’età d’oro della civiltà italiana, al presente della Repubblica, perennemente in crisi. Nulla di nuovo da questo punto di vista, con la rivendicazione di stereotipi noti e discutibili, come il paradigma della decadenza dopo l’età dei Comuni e delle Signorie, la cancellazione totale del barocco, il tema del ritardo della modernità, il fastidio per il peso del passato, la denuncia del fallimento dello Stato unitario costruito dal Risorgimento e sfociato nel fascismo, la rivendicazione di un’antistoria delle identità plurali e federali, sostenute dall’umiltà che è insieme il radicamento nella terra (humus in latino) e un valore morale (nel passaggio di testimone da Virgilio a Dante, raggiungendo Pasolini), fino alla demolizione del mito degli «italiani brava gente»: eppure è proprio l’uso dello stereotipo come manifestazione di una costruzione narrativa che rivela l’origine dello stereotipo stesso a dare senso a tutta l’operazione, che va alla ricerca non della storia d’Italia, ma di un inconscio collettivo degli italiani alla luce del modo con cui la storia d’Italia è stata raccontata, ricevuta, percepita e divulgata.
Al centro ci sono due strutture narrative portanti: la «leggenda nera», che consiste nella denigrazione dell’avversario presunto al fine di rivendicare la propria giustezza, e le «narrazioni assolutorie», che mirano a giustificare i difetti e le colpe attraverso la diminuzione della loro importanza storica. Al primo versante appartiene la costruzione antiasburgica operata dalla propaganda ottocentesca e ribadita dalla storiografia successiva, mentre nel secondo si collocano le varie percezioni di Mussolini come sostanzialmente innocuo. Proprio qui è probabilmente la chiave del libro: tra coloro che fraintesero la pericolosità e la violenza del Duce ci fu Carl Gustav Jung, alla cui teoria psicanalitica l’autore si rifà ampiamente per formazione, militanza e ideologia. Jung contrappose all’«inconscio … di tipo femminile» di Hitler il «temperamento latino e molto virile» di Mussolini, alla nullità umana del primo, «tutto maschera», la forza individuale e il «senso di vitalità» del secondo, all’instabilità emotiva dei tedeschi lo «spirito di equilibrio» degli italiani. Sembra quasi che Zoja abbia scritto l’intero libro per correggere e riequilibrare quel giudizio, visto che al fascismo è dedicato il capitolo più lungo, e decisivo, del libro (66 pagine, di contro alle 43 del secondo per lunghezza, dedicato alla Repubblica e intitolato Dopo gli eroi). Poiché la prospettiva narrativa implica una relazione fra paziente e terapeuta, Zoja si mette in gioco in prima persona, intervenendo autobiograficamente e sviluppando un racconto non solo in ordine cronologico, ma anche spesso fondato su nessi di tipo associativo, umorale e autocentrato.
Certo è che il libro fornisce una guida non solo alla storia d’Italia, ma all’italianità tutta, con una ricchezza di particolari, un dialogo fittissimo con la bibliografia critica e una dovizia di interpretazioni originali da spingere il lettore a chiedersi se sia andata veramente così: siamo sicuri, in altri termini, che la pretesa di neutralità psicanalitica non nasconda un’impronta ideologica? Come sono state e sono ideologiche le grandi narrazioni storiografiche dell’identità italiana e della storia italiana, non è legittimo pensare che lo sia anche il lavoro di Zoja? La posizione a favore del federalismo, l’ostilità verso l’inno di Mameli, l’avversità a Gioberti, la professione di antifascismo, la rivendicazione dell’umiltà sono davvero radicate nell’inconscio collettivo o rispondono a scelte valoriali?
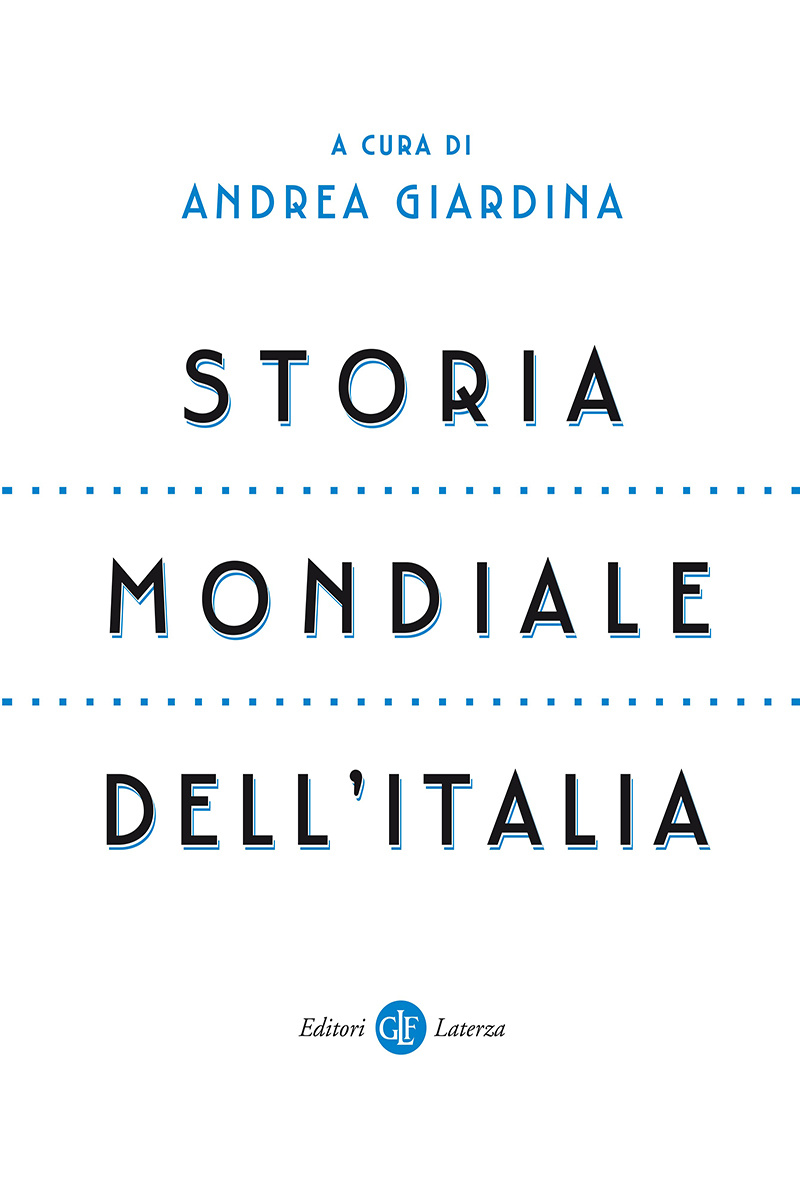
Del resto, uno dei rischi di un lavoro come questo è la neutralizzazione dei soggetti, avvolti da quell’anonimato collettivo che si cela dietro l’espressione (inesorabile astrazione, ma come evitarla?) «gli italiani»: eppure le rappresentazioni emotive che si traducono in narrazioni implicano una collusività, che sta nell’interesse comune delle parti in gioco. Quali sono queste parti? Zoja sottolinea ripetutamente l’esclusione popolare dalla costruzione dei processi storici collettivi, ma il meccanismo con il quale l’invenzione ideologica della narrazione rispecchia un patrimonio inconscio resta oscuro. Se, come ha scritto Giuseppe Tomasi di Lampedusa, alla nascita dell’Italia fu presente «una fata cattiva di cui però non si conosceva il nome», è forse di questa fata, uno spirito inidentificabile, che Zoja sta andando alla ricerca? La psicologia delle masse ha bisogno di sostanziarsi di discorsi, persone e soggetti, che a volte si perdono nella messe di narrazioni dispiegate.
Si resta perplessi, insomma, di fronte a una ricostruzione della narrazione dell’Italia come manifestazione del suo sostrato psicologico collettivo che ignora quello che è il veicolo fondamentale tanto di deposito quanto di costruzione dell’immaginario: la letteratura. È ben noto quanto la critica recente abbia insistito sulla centralità della letteratura nella costruzione della nazione: se Alberto Asor Rosa è arrivato a dire che «senza la letteratura italiana non ci sarebbe stata l’Italia», Giulio Ferroni ha ulteriormente rimarcato che la letteratura «ha dato voce a un riconoscimento dell’Italia e degli italiani». È vero che Zoja sottolinea, piuttosto passivamente, il mito di Dante (che «padre della lingua italiana, e quindi della Nazione», in congiunzione, divenne prima di tutto in un discorso mussoliniano del 27 giugno 1932), la funzione del melodramma, il ruolo civile della poesia di Foscolo, Leopardi e Manzoni, isolando i grandi temi di lunga durata della lamentazione storica, a partire da Petrarca e Machiavelli, e del culto della guerra e della morte, fino a Carducci e Pascoli, ma qualche riconoscimento in più al percorso di costante interazione tra funzione propagandistica e rispecchiamento sentimentale del discorso poetico avrebbe probabilmente dato forza e fascino ulteriori al suo progetto. Narrazione, infine, è termine peculiarmente letterario, sia pure declinato in chiavi storiografiche e psicanalitiche.
Libro totale, quindi, che si muove tra spazi culturali diversi, all’incrocio tra psicoanalisi, storia, antropologia, etnologia, arti della parola, musicali e visive, con l’ambizione enorme di dare risposte a domande che hanno attraversato un po’ tutta la vita culturale nazionale, come hanno cercato di fare, in tempi recenti e da angolazioni diverse, Andrea Giardina nel coordinamento della Storia mondiale dell’Italia (Laterza) e Franco Benigno e Igor Mineo nell’introduzione al volume collettivo L’Italia come storia (Viella). Collocandosi accanto a questi libri, Zoja fornisce prima di tutto una biblioteca ideale dell’italianità che diventerà punto di riferimento collettivo per tutti coloro che vogliano occuparsi di storia d’Italia, identità e carattere, unità e disunità. Più che insistere sull’utilità o meno delle costruzioni onnicomprensive, come faceva Christian Raimo in un libretto troppo radicalmente intitolato Contro l’identità italiana (Einaudi), ma utilissimo per smontare e decostruire esposizioni e ideologie egemoni, sarà ora opportuno verificare i fili che si diramano dalla quantità delle narrazioni che Zoja ha dispiegato sul tavolo di questo monópoli degli italiani: sono fili da sgrovigliare, riannodare, sbrogliare e riallacciare a ripetizione, per capire che è dentro una ragnatela culturale che siamo impigliati, anziché integrati in una narrazione finalisticamente orientata e in un sistema coerentemente compatto. Turgido, ipertrofico, dispersivo e strabordante, ma anche, proprio perciò, capace di convogliare le diversità, arricchire il pensiero e sviluppare la critica, Narrare l’Italia evita accuratamente generalizzazioni, definizioni e classifiche per costringerci a un confronto davvero a tutto campo.
L’«idea d’Italia», esplorata anni fa da Francesco Bruni in un altro librone fondamentale (il Mulino), si arricchisce ora di una dimensione che esula dall’ideologia a favore della narratologia psicanalitica: un sistema di relazioni, come il Duomo di Firenze su cui il libro si conclude, radicato nel territorio e parte di un insieme. Se il Croce delle Recenti controversie intorno all’unità della storia d’Italia riconosceva l’importanza dei miti nell’azione politica e sociale, ma metteva in guardia contro la loro utilizzazione nel campo della storia, dal momento che «sobbollono dei peggiori istinti della disumanità, della prepotenza, della violenza, della distruzione, della barbarie, dell’antistoria; e con questi sentimenti tonificano in torbida immaginazione le storie dei popoli», il libro di Zoja potrà costituire un buon punto di partenza per restituire all’immaginario collettivo la sua funzione storica e ricostruire l’incidenza della dimensione emotiva e delle costruzioni discorsive nella fondazione dei processi di massa. Qui soccorre davvero Jung, col suo avvertimento contro le «pericolose identità della coscienza soggettiva con la coscienza collettiva»: «una identità del genere produce infallibilmente una psiche di massa con la sua inarrestabile tendenza alle catastrofi». Meglio soli che male accompagnati, si potrebbe concludere con un altro luogo comune, ma soprattutto meglio individui distinti che tifosi acritici; oppure, come dice Zoja, meglio brontoloni che integrati o indifferenti.