Una riflessione psicanalitica / L’allucinazione della guerra
Se si rileggono le riflessioni di Freud sulla guerra e la morte pubblicate nel 1915, nella drammatica congiuntura legata allo scoppio della prima guerra mondiale, non può sfuggire come il loro punto di partenza sia costituito dalla coincidenza che egli stabilisce tra lo “straniero” e il “nemico” (Cfr. S. Freud, Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte). Questa coincidenza non è solo storica ma ontologica; nella concezione freudiana in questa coincidenza si rivela una verità fondamentale che caratterizza la forma umana della vita: il mondo straniero – “fonte di enormi quantità di stimolazioni” – non può che essere avvertito dall’apparato psichico come un fattore di perturbazione, come una minaccia nei confronti della sua inclinazione rigidamente omeostatica. Per questo, se continuiamo a seguire Freud, “l’odio è più originario dell’amore” poiché l’odiato, l’estraneo e il nemico sono, nel loro fondo, la stessa cosa.
Questo comporta riconoscere che la tendenza primaria della pulsione non sia affatto quella che favorisce l’espansione della vita, quanto piuttosto quella di una strenua difesa della vita dal rischio insormontabile che la vita stessa comporta. In altre parole, la tendenza primaria dell’umano non può non essere paranoica: il mondo in quanto fonte di stimolazioni ingovernabili appare innanzitutto come una minaccia per il funzionamento dell’apparato psichico. Di qui, come Freud si esprimerà in Al di là del principio di piacere, il paradosso per il quale la “protezione” dagli stimoli conta assai di più della loro “recezione”. In gioco è quella che nelle sue Considerazioni attuali sulla morte e sulla guerra Freud definisce l’ambivalenza fondamentale che caratterizza i nostri rapporti con il prossimo: Eros sospinge verso l’Altro, ma l’Altro in quanto straniero è vissuto come una minaccia incombente. Questa ambivalenza contraddistinguerebbe persino le relazioni con l’Altro più prossimo, con i “nostri cari”.
L’eccessiva preoccupazione per la loro salute, come l’intenso cordoglio che può accompagnare la loro perdita, non sono privi di un paradossale senso di colpa che segna il fatto scabroso che dietro l’attaccamento eccessivo per i “nostro cari” vi sia un innominabile voto di morte. È quello che ci ha ricordato l’esperienza drammatica della pandemia: senza l’Altro la nostro vita perde senso, ma la prossimità dell’Altro può essere fattore di morte e di malattia. Il distanziamento diviene così quella misura preventiva che evita il rischio della contaminazione e dell’invasione dei nostri confini. Non a caso è proprio la paura della vita ad essere il fondamento di quella pulsione securitaria che Hobbes situa alla radice dello Stato moderno e, più in generale, del patto sociale: lo stato di natura della “guerra di tutti contro tutti” – la paura della morte – genera la necessità di un potere che garantisca la protezione della vita.
Nondimeno la pulsione securitaria può assumere le forme di una pulsione aggressiva. L’azione militare viene spesso invocata da chi la innesca, come sta avvenendo anche nel caso della guerra in Ucraina, come un’azione eminentemente difensiva. Tendenzialmente è sempre nel nome della difesa della propria sopravvivenza – integrità, sovranità, identità – che si scatenano le guerre. Anche la necessità più chiaramente espansionistica (si pensi alla Germania nazista) è stata storicamente giustificata come una necessità interna che risponde all’esigenza primaria dell’autoconservazione di un proprio spazio vitale. Franco Fornari in La psicoanalisi della guerra, pubblicato nel 1966 in piena guerra fredda e minaccia atomica, aveva definito la guerra come una “elaborazione solo paranoica del lutto”.
Mentre il lutto implica un dolore e uno sconforto profondi legati alla perdita di un oggetto amato – una persona cara, un ideale, un territorio, ecc. – e si configura come il difficile e tortuoso lavoro della sua elaborazione simbolica, la paranoia, al contrario, è un modo per rigettare sullo straniero o sul nemico la responsabilità di questa perdita al fine di negarne l’esistenza. Esemplare è l’analogia, prelevata dalla ricerca etnologica sulle tribù primitive, proposta da Fornari: se accade che in una tribù muoia improvvisamente il figlio del re, anziché elaborare questo lutto atroce – psichicamente indigeribile – si preferisce scatenare una guerra contro la tribù confinante attribuendo al suo sciamano la responsabilità di quella morte.
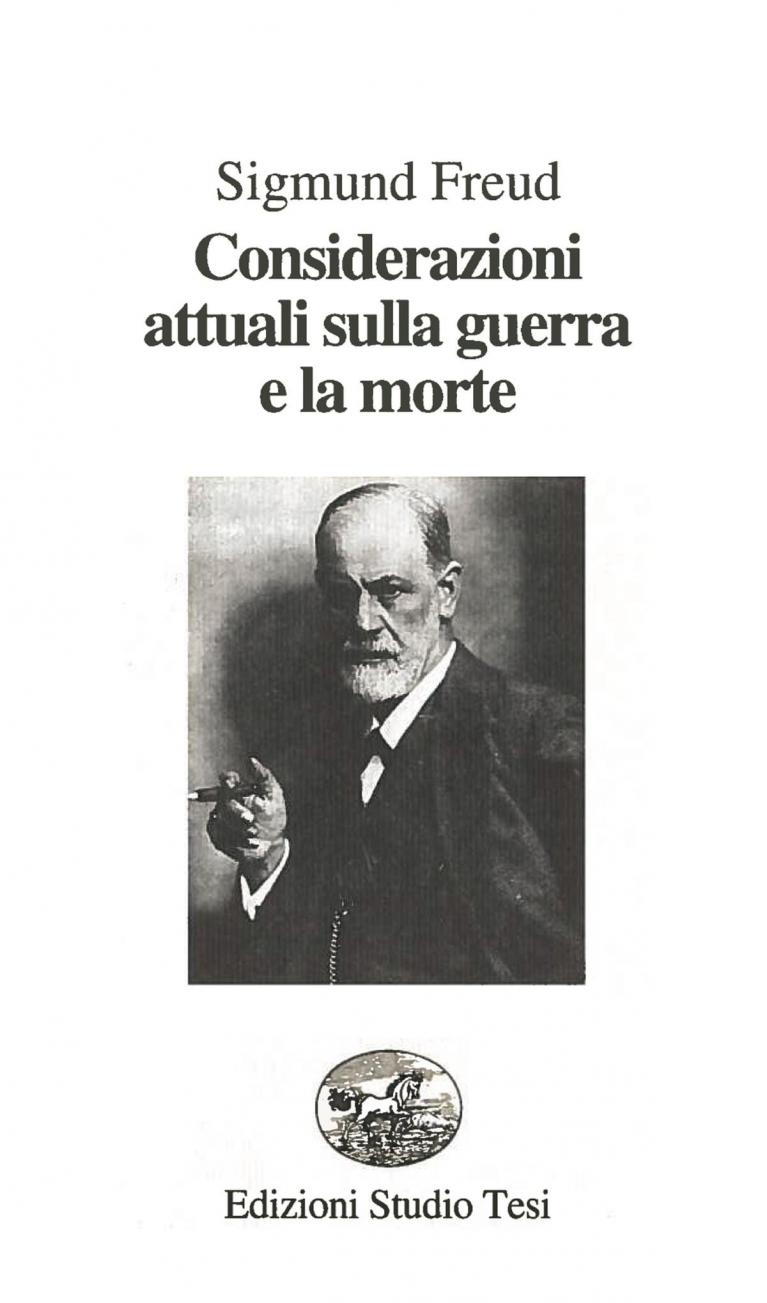
Al posto del lavoro doloroso del lutto si scatena così la violenza della guerra: il dolore interno per la perdita irreversibile del figlio del re si trasfigura in una pulsione aggressiva rivolta all’esterno, diretta verso la tribù nemica. In questo senso la guerra condivide lo stesso statuto psicotico dell’allucinazione: il pensiero persegue la “via più breve” evitando quella “più lunga” come esigerebbe invece il tortuoso e doloroso cammino simbolico del lutto.
L’allucinazione della violenza coprirebbe il buco apertosi nel reale a causa dell’esperienza irreversibile della perdita. Alla “via lunga” della diplomazia e della mediazione della parola si preferisce quella breve di una soluzione (la guerra) che vorrebbe abolire ogni interlocuzione. La legge allucinatoria della forza militare si sostituisce a quella dialettica della parola. È proprio per questa ragione che ogni democrazia porta nel suo cuore una profonda esperienza collettiva del lutto. Quale? Non esiste una sola lingua, non esiste un solo popolo, non esiste una sola interpretazione della verità. La vita della democrazia resta sempre incompiuta – imperfetta, insatura, incompleta – poiché il suo compimento abolirebbe il lutto che ne costituisce il fondamento. La perdita della Cosa sancita dall’esistenza della Legge della parola impone, infatti, all’umano la perdita di ogni ideale di totalità. È dal lutto di questa perdita che sorge la vita della democrazia o, se si preferisce, l’esistenza della democrazia non può che realizzarsi come un lavoro del lutto che rammemora il carattere irrecuperabile di quella perdita.
Al contrario, tutti i regimi non democratici sono tendenzialmente sospinti verso la guerra come alternativa paranoica al lavoro del lutto perché perseguono una realizzazione della Verità che esclude forzatamente la divergenza e il pluralismo imposti dalla Legge della parola. Per i regimi dittatoriali e non democratici, infatti, l’esistenza dello straniero coincide, come spiegava Freud, con quella del nemico. Il moto acefalo della pulsione esclude la democrazia perché esprime un regime dell’Uno che vuole se stesso, dunque che esclude l’Altro. La guerra tende ad annichilare l’ostilità del mondo esterno – la sua radicale alterità – mirando a uniformare la vita in un solo mondo. A un pensiero democratico dell’integrazione si sostituisce quello autocratico della scissione; all’arte della diplomazia e della mediazione quella del sopruso e della potenza bellica. Non è forse quello che sta accadendo anche in questa ultima atroce e sanguinosa guerra? Anziché procedere nell’elaborazione collettiva del lutto per la perdita dell’ideale della grande Russia e del suo sconfinato Impero, per la perdita dei territori dovuta all’inarrestabile attrazione dei popoli verso la libertà e la democrazia dopo lo smembramento del Patto di Varsavia, anziché accettare, appunto, il lutto necessario della democrazia (non esiste un solo popolo, una sola lingua, una sola Verità), il miraggio autocratico di Putin resta fatalmente nostalgico, ancorato all’idea di un Impero separato dal mondo che egli intende restaurare nelle sue fondamenta.
Con la complicazione ulteriore che il suo rifiuto del lutto necessario della democrazia non provoca solo l’aggressione di un paese (l’Ucraina) considerato come un proprio territorio ingiustamente perduto, ma evoca la minaccia del ricorso all’arma atomica. È la radice autodistruttiva del narcisismo umano sulla quale la psicoanalisi ha sempre scabrosamente insistito: l’estrema affermazione della propria potenza di controllo – la bomba atomica – coincide con l’estremo rischio di perdita di ogni controllo; l’annientamento brutale dell’Altro coincide con il nostro autoannientamento. Distruttività e autodistruttività sono sempre legati come il recto e il verso di uno stesso foglio. È quello che si palesa drammaticamente nella bomba atomica: l’immenso potere di questo ordigno di guerra, mentre assegna una potenza illimitata a chi lo detiene, lo lega nello stesso momento a un fatale destino di auto-annichilimento. Lo strumento onnipotente della distruzione rivela la sua cifra pienamente autodistruttiva. È la vocazione profondamente suicidaria di ogni narcisismo maligno: l’affermazione illimitata di se stessi coincide con la propria autodistruzione. È la più grande follia dell’umano che la Torah non a caso descrive come la follia di assimilarsi a Dio.
Nel rivendicare la proprietà della bomba atomica e la sua potenza l’uomo non si erge forse a padrone assoluto del mondo? Se Freud aveva messo in luce come in ogni guerra la morte esca oscenamente dall’oblio a cui la costringe la vita ordinaria, seminando angoscia e rivelando la nostra castrazione strutturale, nella minaccia atomica non è solo lo spettro della nostra morte a venire evocato, ma la fine del mondo in quanto tale. Se agli occhi di Freud la prima guerra mondiale aveva animato la più radicale angoscia di castrazione confrontandoci crudelmente con il nostro destino mortale, la condizione della guerra atomica attiva un’angoscia psicotica.
La possibilità di una declinazione atomica della guerra non ci fa solo sentire impotenti – accade nello scoppio di ogni guerra convenzionale –, ma mette a rischio, come avviene in un delirio psicotico di “fine del mondo”, la nostra stessa sopravvivenza sul pianeta. Per questa ragione può essere più difficile metabolizzare il terrore di questa guerra che non quello legato alla pandemia. Quest’ultima non ha abolito, infatti, misure di controllo, di protezione e di difesa che dipendono dalla nostra volontà. Ma nella guerra atomica la nostra volontà viene radicalmente deposta, poiché siamo costretti a sperimentare la condizione psicotica di essere ridotti a oggetti inermi della volontà di godimento dell’Altro. Volontà ineffabile, capricciosa ed enigmatica, che destituisce la nostra iniziativa di qualunque potere. La follia dell’Altro prenderebbe così l’ennesima e terrificante rivincita sulle rivendicazioni impotenti della nostra autonomia.







