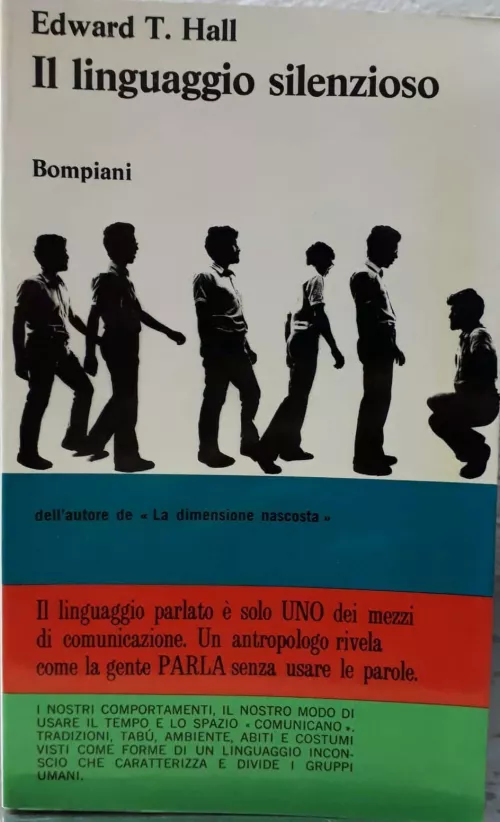Speciale
Coronavirus / L’arte della prossemica
“Una società lasciata a se stessa non mostra alcuna tendenza naturale a progredire […]; per smuoverla almeno un po’ occorre che essa riceva una moltitudine di piccole scosse che rappresentano i contatti fra le differenti nazioni […] Il progresso umano può esistere solamente nella misura in cui tutti i differenti centri della cultura umana hanno dei contatti fra loro. Le società isolate sono società inerti, soltanto le società in contatto fra loro progrediscono”. Così il giovane Claude Lévi-Strauss in una delle sue prime uscite pubbliche, Parigi 1937, adesso nel libretto Da Montaigne a Montaigne: il contatto, la relazione, la reciprocità sono alla base d’ogni cultura umana.
A distanza di quasi ottant’anni sembra fargli eco uno dei principali antropologi odierni, lo scozzese Tim Ingold, che in Siamo linee (appena tradotto da Treccani) scrive: “ci sarebbero buoni motivi per supporre che nell’aggrapparsi – o, più prosaicamente, nello stringersi l’uno all’altro – stia l’essenza della socialità: una socialità, naturalmente, che non si limita all’umano, ma si estende alla vasta gamma di creature che si aggrappano e delle persone o delle cose a cui si attaccano”. Come dire che, se pure siamo esseri filiformi (linee, appunto), il nostro destino sociale è quello di abbarbicarci l’un l’altro, di intrecciarci di continuo formando grovigli, nodi, reticoli: da cui l’esistenza dei gruppi sociali, delle collettività organizzate, delle culture. Anche qui il predominio basilare del legame, del rapporto vicendevole.
L’emergenza del nuovo, micidiale virus che sta colpendo, a ritmi sfasati, mezzo mondo (o forse tutt’intero), porta e riflettere su questo genere di convincimenti – i quali, sino a pochissimo tempo fa, consideravamo niente più che ragionevoli, indiscutibili. Ma che ne è del contatto ai tempi del contagio, come dire del coronavirus (pardon, Covid19)? e con esso della socialità, delle culture, di quel vivere insieme che consideriamo – a ragione – umano e non solo? Molto poco, a prima vista. La possibile contaminazione impone una presa di distanza, un regime topologico di sicurezza minima, dunque un riassesto complessivo delle relazioni spaziali fra individui singoli o intere società.
In molti, in questi giorni, parlano di uno spegnimento della socialità dovuto alla progressiva eliminazione dei contatti fisici, causata dal panico da infezione o da espresse disposizioni di legge. Almeno un metro l’uno dall’altro, dicono esperti e loro avatar, che sarebbe la distanza supposta necessaria per evitare – o quanto meno scoraggiare – il diffondersi del virus. Ma c’è chi preferisce evitare del tutto i contatti: niente baci, strette di mano, abbracci, pacche sulle spalle, effusioni d’ogni tipo. Tutti rigidi, tutti frigidi. E niente assembramenti in aule scolastiche o universitarie, teatri e cinema, ascensori e ristoranti, ospedali, palestre e così via. Da sostituire alla bisogna con relazioni interpersonali mediate da adeguate tecnologie comunicative, dal banale telefonino ai servizi di delivery prenotati on line fino alle più sofisticate applicazioni smart per un e-learning tanto forzato quanto benedetto.
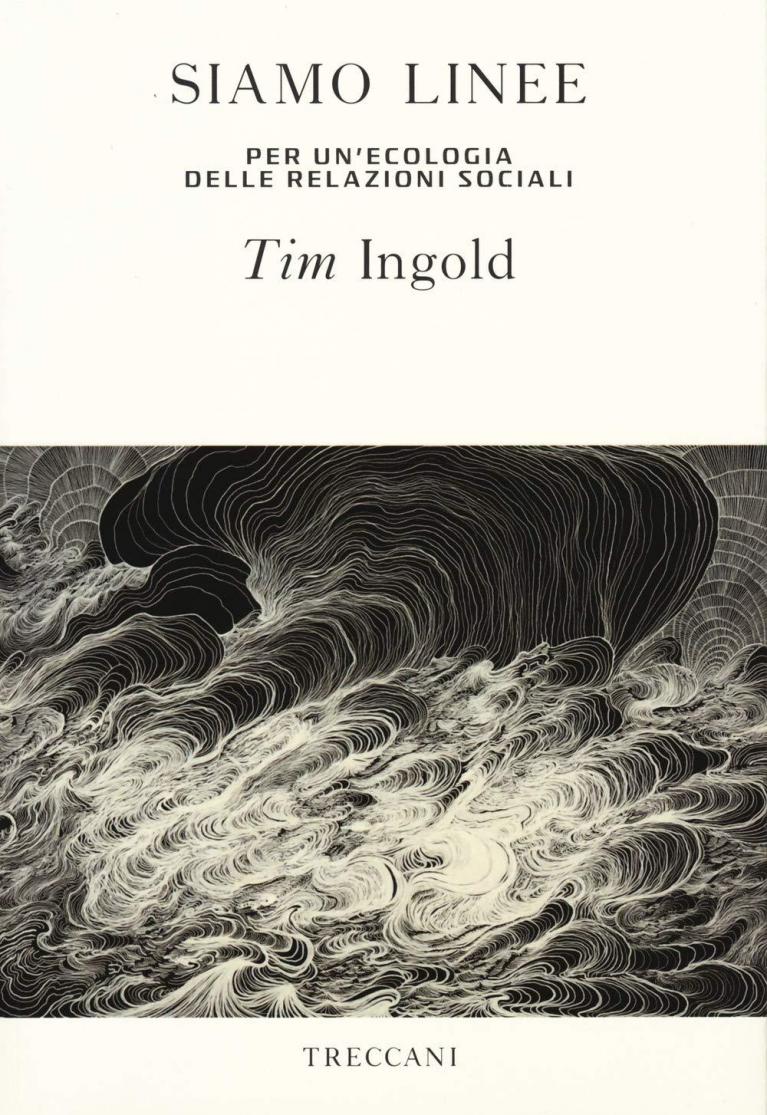
Così, non è mancato chi ha indicato il solito complotto del capitale per ingabbiare le masse controllandone a menadito gli spostamenti sul territorio. E chi ha profetizzato l’apocalisse prossima futura dovuta a una biopolitica sparizione della corporeità per opera di una tecnologia disumanizzante. L’eliminazione dei contatti porterebbe alla disgregazione sociale. Niente più amori giovanili nei corridoi scolastici, strusci al centro commerciale, carezze clandestine negli anfratti dell’ufficio. Per non parlare delle assemblee di fabbrica, delle adunate di piazza, dei rave notturni nei terrain vague periferici. Nessuna sardina potrebbe oggi sopravvivere al timore da pandemia.
Ecco, insomma, riemergere la vecchia idea che oppone la fisicità alla digitalizzazione, il corpo alla tecnologia, il reale al virtuale, l’esperienza diretta a quella mediata. Stereotipo duro a morire. Pronto anzi a risorgere nella bocca del solito apocalittico in servizio permanente effettivo. Pensiamo ogni volta d’aver mostrato e dimostrato come queste opposizioni siano più caricaturali che altro, dato che la mediazione è sempre e dovunque, ma – sembra – invano.
Potrebbe allora venirci in soccorso (lo ha indicato giorni fa Paolo Fabbri al Tg1) la vecchia prossemica, studio antropologico delle distanze fra le persone e dei loro relativi significati prospettato negli anni 60 del Novecento da Edward T. Hall in libri dimenticati come Il linguaggio silenzioso o La dimensione nascosta che mai come oggi varrebbe la pena riaprire. Termini come ‘vicino’ e ‘lontano’, diceva Hall, sono del tutto relativi, dato che cambiano non solo a seconda delle relazioni che intercorrono fra le persone ma anche a partire dalle culture in cui costoro si trovano a vivere. I territori del sé, come poi li ha chiamati Erving Goffman, mutano parecchio e senza sosta: c’è una distanza critica (l’amore o la lotta), una personale (la confidenza amicale), un’altra sociale (al lavoro o fra estranei), un’altra ancora pubblica (con icone dello spettacolo o uomini politici). Il problema è che queste distanze non si possono misurare una volta e per tutte: basta viaggiare un po’ per rendersene conto. È noto per esempio che negli Stati Uniti la distanza media fra persone è enormemente superiore a quella che esiste fra le popolazioni mediterranee e, soprattutto, fra gli arabi. Così, quando noi europei andiamo in America ci sembra che le persone, allontanandosi sistematicamente dal nostro corpo, vogliano schizzinosamente evitarci, mentre se andiamo nel Maghreb, dove la gente ci sta a pochi centimetri, crediamo che tutti vogliano farci delle profferte sessuali. I codici culturali regolano anche questo genere di situazioni: basta saperli padroneggiare per adattarci al meglio un po’ dovunque.
Sappiamo inoltre, da McLuhan a Baudrillard a Meyrowitz, quanto i media, vecchi e nuovi, abbiamo lavorato per modificare non tanto le distanze fra le persone quanto i loro significati. Oggi una star del cinema o un uomo politico entrano a casa nostra regolarmente attraverso lo schermo televisivo: stanno con noi a una distanza personale, fanno parte della nostra famiglia (al punto che, se ci capita di incontrarli per strada, tendiamo a salutarli affettuosamente). E, d’altra parte, se i social network si chiamano così è perché non negano la socialità ma ne instaurano un’altra, diversa quanto si vuole, ma pur sempre tale.
Tornando alla nostra situazione contingente, il tema da discutere non è l’abolizione del contatto – e del contratto – sociale ma la forte modificazione delle distanze fra le persone. Abolita la distanza critica, tutte le altre, come per un effetto domino, si trasformano a loro volta. Esigendo nuove codificazioni, attendendo nuovi significati. Più che lamentarci per la fine dello struscio o inneggiare al dominio del virtuale, solita sterile dialettica, meglio monitorare le semantizzazioni possibili delle nuove distanze che si sanno imponendo fra noi. Non sappiamo bene cosa accadrà, ma possediamo i mezzi per pedinare la nascita, l’affermazione e la trasformazione delle ulteriori forme prossemiche che il maledetto virus – o chi per lui – ci sta imponendo. Magari dando qualche suggerimento, proponendo qualche correttivo, avanzando qualche critica sensata. Provando a ripensare le quarantene come opportunità.