Pelle, un mostruoso mistero
Quando sei il bersaglio non sai mai perché il destino ti abbia tirato il colpo, e nemmeno “chi” sia questo destino che ti manda la sciagura. E in fondo neanche te ne importa, perché da quel momento in poi ciò che conta è il danno che hai ricevuto, il male che ti fa, il tuo danneggiamento. Uscirne diventa il tuo scopo, innanzitutto. Il perché e il percome vengono dopo. Se poi a essere colpito è un lato manifesto della tua persona, qualcosa che il mondo intero non può non vedere, e tu non ce la puoi fare a celarlo perché proprio l’evidenza è la sua cifra, allora diciamo che sei fottuto.
Liberartene è l’on-off della tua esistenza. Non basta, c’è anche il lato beffardo: se a essere preso di mira è l’involucro primario che ti contiene, ciò attraverso cui tu tocchi il mondo e il mondo tocca te, fin dal primo istante di vita, diciamo che la sfida diventa addirittura paradossale. È questa la condizione di chi si ammala di psoriasi, una variante delle patologie dermatologiche che una volta veniva chiamata “la malattia dei sani”, quasi fosse una parvenza di malattia, una di quelle cose che non ti uccidono, ma si limitano a… rovinarti la vita. Costruirci una storia e tentare in qualche modo di sublimare questo dolore personale è stata la sfida dello scrittore spagnolo Sergio del Molino con il suo Pelle (Sellerio 2022, pp.281). Sotto specie narrativa quella di del Molino è una sorta di storia dell’umanità che ha come chiave la pelle, appunto, e la pelle malata in particolare.
Prima di seguire il “racconto” conviene però soffermarsi sull’aspetto con cui giocoforza abbiamo a che fare in quanto esseri umani, sì perché la pelle non è un inerte rivestimento esterno, ma un’essenziale interfaccia che funziona allo stesso tempo come dispositivo di input e output (“siamo touch come i nostri schermi” dicevo tempo fa ragionando sulla superficie). Da qui, dalla superficie, alla profondità interiore il passo è breve, molto breve.
Come dice Didier Anzieu nel suo celebre Io-pelle (vedi qui Pietro Barbetta), la pelle è per il corpo ciò che l’Io è per la psiche, pelle e Io contengono la massa vitale di cui siamo fatti. Stiamo parlando dei due involucri fondamentali “attraverso” i quali possiamo stare al mondo. E quando questi involucri si deteriorano il nostro stare al mondo può complicarsi fino a essere compromesso. Dunque ammalarsi alla pelle in modo incontenibile può diventare un fattore dirompente che si abbatte anche sulla psiche.
“Si potrebbe scrivere una psicostoria della pelle”, dice lo psichiatra Vittorio Lingiardi nel suo bell’inventario della “cultura cutanea” (Siamo amici per la pelle. Ecco perché, “Sole24ore” del 11 agosto 2020). La pelle è un contenitore primario, il nostro vestito di scena, un sensore sommo che “contiene” ogni possibilità di contatto, affettivo, traumatico, conoscitivo. Osservarla nel suo versante “psichico” permette di capire le implicazioni possibili della patologia della superficie, che tutto è tranne che superficiale.
Sergio del Molino ne fa addirittura un criterio di lettura dell’umanità, un particolare punto di vista, da mostro: “Siamo dei gran noiosi, noi mostri, sempre a piangerci addosso chiusi nelle nostre torri e nelle nostre segrete, degli egocentrici, sempre a lamentarci dello schifo che il mondo prova per noi” (p.32).
Vuole raccontarla la sua vita “deforme”, che il suo piccolo figlio ne abbia una documentazione sensata, scritta di prima mano dal suo papà; vuole che lui dica “i mostri non esittono”, lo vuole fare prima che arrivi “Il Medioevo della pelle”, l’età di mezzo in cui il bambino crescendo si distaccherà dal padre e il padre non potrà più toccarlo sulla pelle per abbracciarselo e baciarlo. Ma non vuole ridurla a una storia di debolezza, di penosa trafila sanitaria, di ferite schifose. Vuole parlare dell’umanità, folta, che è costretta a indossare la maschera del mostro. Una storia personale proiettata su quella di tutti coloro che con la pelle hanno dovuto avere a che fare, i malati e i loro vicini.
Stalin, per esempio, immerso nella piscina super protetta a Soči sul Mar Nero che condivide la condizione di grande psoriasico con altri due fidati e temibili mostri, Andrej Vyšinskij, cinico e crudele procuratore per il quale nei processi valeva il principio che “ogni imputato è colpevole fino a prova contraria”, e Nikolaj Ežov, spietato indagatore e accusatore di Lev Trockij, premiato con il comando della polizia sovietica (p.46). Stalin assomiglia in modo inquietante alla “carta del diavolo”, la carta dei tarocchi che per prima fuoriesce dal mazzo aperto da Patricia, compagna di Università dell’autore ancora ragazzo scapestrato a Madrid.
Il diavolo, uno degli arcani maggiori, identificato con la lettera Samech dell’alfabeto ebraico, che vuole “che ci scortichiamo, che facciamo saltare le cuciture dell’abito per avvicinarci all’Innominabile senza alcuna protezione”. Sono le suggestioni di cui il futuro scrittore, mostro in formazione, si nutre agli inizi della sua disavventura fino a chiedersi: “E se esistesse qualche correlazione tra la psoriasi e il mio carattere o il mio modo di stare al mondo?” (p.56).
Lo spettro si allarga ai casi eclatanti di altri personaggi, grandi notorietà che hanno dovuto confliggere pesantemente con la malattia della superficie: a cominciare dalla regina Isabella II di Spagna che prese a frequentare il mare per curarsi la pelle trasformando così nelle splendide città di Santander e San Sebastiàn due piccoli villaggi di pescatori.
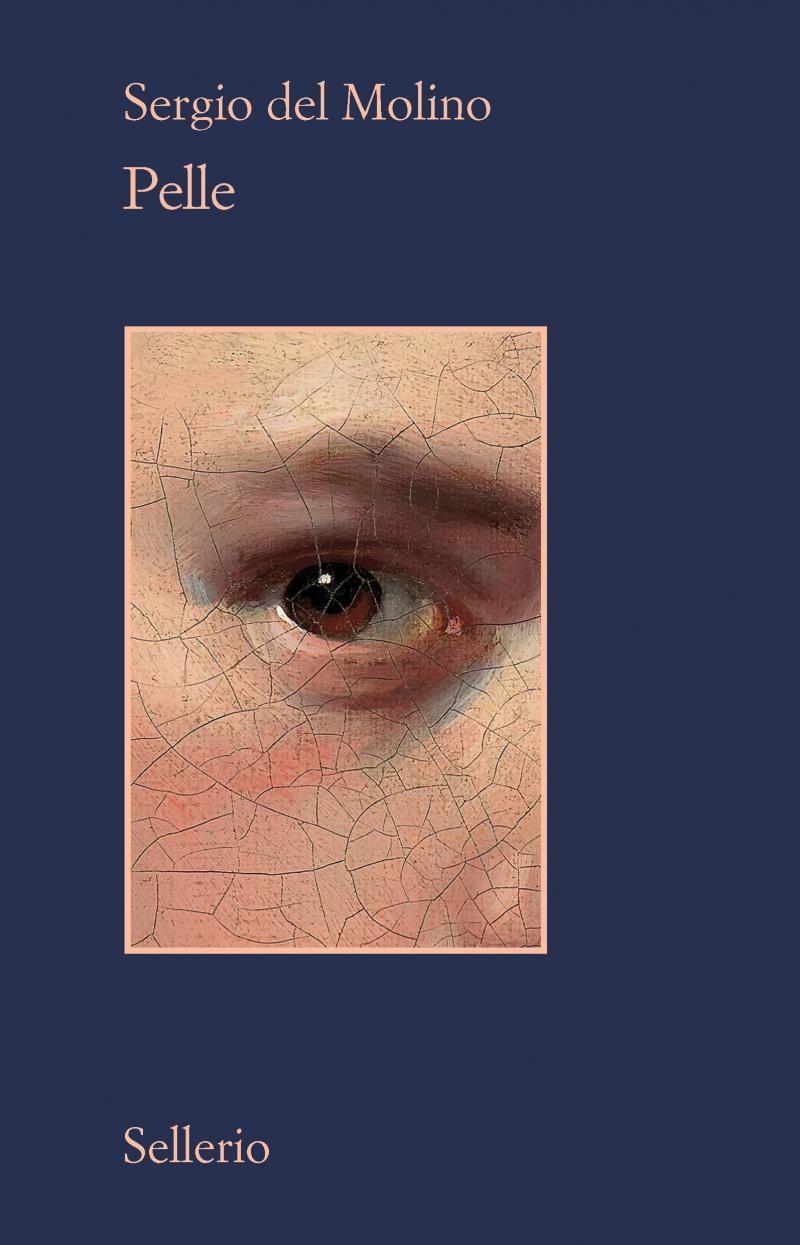
E poi John Updike, un grande scrittore che era anche un elegantone; Cindy Lauper, indimenticabile cantante di Girls Just Want To Have Fun e promotrice di azioni in favore della ricerca farmaceutica; la nuotatrice olimpionica Dara Torres, il gran criminale Pablo Escobar, la modella Cara Delevingne, la sfrontata Kim Kardashian, capace di non usare il trucco per coprire le macchie sulla pelle e di parlarne liberamente. E anche Ernst Hemingway, che con la pelle ebbe molto seriamente a che fare fino a un tumore cutaneo nel periodo subito precedente la scomparsa.
Un posto speciale viene riservato dall’autore a Vladimir Nabokov: “Se prendere mio figlio in braccio per la prima volta – dice – fece di me un ignorante che aveva bisogno di imparare a vivere fin dalle basi, leggere i libri di Nabokov mi rivelò che non sapevo nulla di letteratura” (p.217). È la storia dell’intera vita di Nabokov ad appassionare del Molino: figlio di un fervido liberale russo fatto fuori dai sovietici nel 1922, Sirin, nomignolo con cui Nabokov era noto tra gli esuli russi a Berlino, Parigi, Londra e poi negli USA, fu costretto a implorare l’opportunità di insegnare e pubblicare i suoi scritti.
Nel 1936 compare la psoriasi: per Nabokov è la condanna a diventare anche lui mostro (una sorta di contraltare del mostro Stalin, dice l’autore). Chiama la malattia “il mio Greco” per evitare il pretenzioso nome (ψωρίασις – psōríasis), e scrive alla moglie: “Tutto andrebbe bene se non fosse per la mia dannata pelle” (p.222). La vita dell’autore di Lolita è descritta nei suoi passaggi salienti, ma con questo particolare riflettore sulla sua pelle malata. A un certo punto Humbert Humbert, in una certa misura alias di Nabokov, vede se stesso come Marat nel bagno, non per caso un altro malato di pelle che, secondo i dermatologi appassionati di storia, soffriva di “dermatite erpetiforme”. Come dire: “Tutti noi che soffriamo di patologie della pelle siamo Marat nel bagno. David ci ha dipinti tutti nel suo quadro” (p.233).
Particolarmente interessante è la “Brevissima storia del razzismo”, un capitolo prezioso del libro di del Molino che andrebbe ben analizzato e poi divulgato capillarmente nei molti contesti sociali (e politici) odierni ancora troppo pieni di violente sciocchezze. Si comincia con Felix von Luschan, l’antropologo noto come l’ideatore della skin color scale, un metodo di classificazione delle trentasei possibili tonalità della pelle umana.
Una “sistemazione” dell’umanità secondo il criterio del colore della pelle che lo studioso, “l’unico antropologo non razzista in tutta Berlino” (p.89) morto nel 1924, non fece in tempo a vedere utilizzata come strumento dell’eugenetica fascio-nazista. Le tessere colorate di von Luschan divennero poi un vero atlante geografico (Razze e popoli della terra, quattro volumi UTET 1953) ideato dal friulano Renato Biasutti, docente di Geografia a Firenze che, invece, fece in tempo (morì nel 1965) a vedere il cataclisma nazista in cui anche il suo atlante, nato con intenti puramente scientifici, fu utilizzato come materiale a sostegno del razzismo.
La pelle produce melanina per proteggersi dalle radiazioni ultraviolette e di conseguenza gli individui con più melanina predominano nelle regioni vicine all’equatore, questo dice la scienza dermatologica, eppure il colore della pelle come marchio “razziale” è duro a morire e lo dimostra la storia del “Nero di Banyoles”, un “reperto” importato in Francia dall’Africa nel 1888 da un tale Francesc Darder e poi esposto dal 1916 a Banyoles (in Catalogna) in una specie di museo naturale (si badi non una chiesa cristiana o una piramide egizia) che portò il suo nome: il reperto era un uomo dalla pelle nera impagliato. Un esemplare di uomo nero.
Un simile orrore rimase esposto a Banyoles fino al 1997! E solo nel 2000 questi resti umani furono portati in Botswana per la sepoltura (una vicenda ricostruita dallo scrittore olandese Frank Westerman in El Negro e io, Iperborea 1983). Il punto di arrivo del capitolo è limpido: “esiste una sorta di daltonismo culturale quando si tratta di distinguere i colori della pelle umana” (p.115). È così che la negritudine, dice del Molino, diventa “metafora di tutte le alterità”.
Non poteva mancare in Pelle un filone “farmaceutico” che per la verità si limita all’essenziale: ciò che rendeva misteriosa la psoriasi (cause psicosomatiche, genetica… si diceva genericamente) oggi è quasi scomparso; che la psoriasi sia espressione cutanea di un insieme di patologie autoimmuni rinvia al sistema immunitario in generale che sembra non funzionare a dovere e sul quale agiscono (spesso efficacemente) i farmaci più moderni. Ma il mistero rimane, l’eziologia non è ancora ben definita, quasi che le macchie della psoriasi, dico io, costituiscano una sfida corporea al presente ossessivamente artificializzato (la bici che resiste alla cyclette…).
Ma è la storia umana di del Molino che emana calore, il gioco di sensibilità che vi proietta: il tenero incessante dialogo con il piccolo figlio, il percorso, anzi, il cammino di cura, le “stazioni” della via crucis dello psoriasico, le soste nel tragitto verso l’ospedale davanti alla statua di re Ferdinando il Cattolico in muta conversazione, le aspettative, le disillusioni, la penosa vita da reietto, costretto a collo e polsini chiusi della camicia, alle terapie costanti, l’ospedale, le infermiere, la dottoressa “motivante”, le iniezioni…
Fino all’evolversi di un racconto – in una direzione che qui non va anticipata – che ci parla del surplus di fatica di vivere di certe persone per le quali la malattia sembra quasi una camera di compensazione psichica: una nicchia umana che la psiche, in cambio di un po’ di macchiette sulla pelle, mantiene in equilibrio. È una storia di sofferenza da cui l’autore/protagonista più e più volte deve liberarsi emotivamente: “Per quanto Paul Valéry abbia scritto che non c’è nulla di più profondo della pelle, e per quanto io non smetta mai di pensarci, la pelle non dovrebbe avere tutto questo peso. Dovrebbe essere una faccenda da visagisti, non da medici. Perché non bastano le terme? Perché non mi ritiro per un po’ ad Alhama de Aragón e non mi rilasso, disteso sulla mia comoda superficialità? Nessuno dovrebbe andare in ospedale per certe frivolezze” (p.181).
Il fatto è che la sofferenza è aggrappata al ricordo, ma forse – concludiamo con l’autore – “finché li serbiamo nelle celle di vetro della memoria, i ricordi hanno la consistenza delle favole che si raccontano prima di spegnere la luce sul comodino. A rigore, non esistono. Non esistono, come i mostri. Riusciamo a sopportare il peso della memoria perché abbiamo la speranza di esserci inventati tutto” (p.258).
P.S.: Dimenticavo, anch’io sono uno psoriasico.







