Speciale
Parole per il futuro / Ridere
«L’umorismo è assolutamente indispensabile nel XXI secolo, il quale sarà umoristico o non sarà affatto»: così terminava la Storia del riso e della derisione di Georges Minois, pubblicata in Francia nel 2000 (trad. it. di Manuela Carbone, Edizioni Dedalo, Bari 2004). Siamo già a quasi un quarto del secolo, rifiuti e inquinamento non hanno fatto che crescere e noi non ci siamo adattati, come prevedeva lo storico del riso, anzi, ci siamo ammalati e non abbiamo riso. Ché poi, comico, umorismo e ridere non sono esattamente la stessa cosa, visto che televisione, facebook e instagram sono pieni di risate di falsa complicità che ci ricordano puntualmente che non c’è nulla da prendere sul serio: è un riso convenzionale, un riso senza gioia, un riso svilito, trasformato in merce.
C’è poi un riso ancora peggiore, di cui dà conto l’antropologo David Le Breton, che ha pure un nome: happy slapping, letteralmente “schiaffeggio divertente, allegro”. Consiste nel divertirsi e ridere dando ceffoni a degli sconosciuti, riprendendo il loro sgomento con il telefonino e postando le immagini su internet (ma siamo lontani da Amici miei). La pratica risale a una quindicina di anni fa ed è degenerata nelle incursioni di giovani violenti travestiti da clown, in pestaggi e violenze filmati e trasmessi in Youtube, nelle riprese di gesti nauseabondi che sfociano in una generale ilarità, fino alle giovani risate che commentano le scene orribili di torture e decapitazioni dei propagandisti di Daesch (Ridere. Antropologia dell’homo ridens, trad. it. di Paola Merlin Baretter, Raffaello Cortina editore, Milano 2019; per le risate delle aspiranti combattenti cfr. Anna Erelle, Nella testa di una jiadista, trad. it di Guia Pepe, Elena Sacchini, Maddalena Togliani, tre60, Milano 2015).
La componente aggressiva e violenta del ridere è al centro della teoria della superiorità, che risale a Platone e forse ancora prima a Democrito, il filosofo che, secondo la leggenda, ride a crepapelle dei suoi concittadini, e giunge a Hobbes, a Bergson e a Baudelaire, ribadita dalle teorie che ne ricercano l’origine biologica nell’atto aggressivo dell’animale che scopre i denti. Non possiamo negare di averlo sperimentato anche noi questo riso dello scherno nel quotidiano pettegolezzo o nelle serate in osteria. Eppure, anche se consapevole della malevolenza che può accompagnare la nostra risata, propongo ridere come parola per il futuro.
La teoria della superiorità non esaurisce infatti la parola e il concetto. Nella storia del pensiero possiamo rinvenire altre definizioni, anche se, come ha messo in rilievo già all’inizio dell’Ottocento Jean Paul Richter, ciò che fa ridere, il ridicolo, «non vuole piegarsi alla definizione dei filosofi», è un Proteo sfuggente, «persino insidioso per chi ardisce di legarlo ad una delle sue metamorfosi» (Il comico, l’umorismo e l’arguzia, trad. it a cura di Eugenio Spedicato, il poligrafo, Padova 1994). Poche righe sotto segue la critica alla definizione di Kant che nella Critica della facoltà di giudizio afferma che il riso nasce da un improvviso risolversi di una aspettativa nel nulla. Nella risata siamo cioè (ma non è Kant che parla) come quei personaggi dei cartoons che scoprono, tutto d’un tratto, di camminare sospesi nell’aria, poi precipitano e si rialzano intatti, con un senso di sgravio e di liberazione (Andrea Tagliapietra, Tipologia del riso, “Fillide” 5, 2012; cfr. anche: Non ci resta che ridere, Il Mulino, Bologna 2013). Questa teoria del sollievo ritorna in Il motto di spirito di Freud che considera il Witz un risparmio sul dispendio psichico richiesto.
Teniamo però conto dell’avvertenza di Jean Paul che sottolinea la pluralità irriducibile delle figure del comico e ci permette di ricorrere anche alla teoria dell’incongruenza, che oggi appare predominante negli studi analitici, ricordando il ridere stupito di Abramo e Sara di fronte all’incongruità della promessa divina di far avere loro un figlio in età avanzata, ma forse anche la definizione di Aristotele del comico come errore indolore. La tesi viene approfondita nel Settecento contro Hobbes: il fatto di sentirci superiori alle ostriche – scrive Hutcheson – non è sufficiente a farci ridere, mentre la causa del riso può derivare dal contrasto tra idee di grandezza e sublimità che si rovesciano in idee di bassezza e mediocrità.
Nel caso del comico e dell’umorismo, utilizzare diverse teorie non è superficiale ecclettismo, ma appare necessario per la complessità degli atteggiamenti umani che lo caratterizzano: ridere è linguaggio del corpo e, nello stesso tempo, è fenomeno culturale che può declinarsi in centinaia di modi, come dimostrano gli elenchi dei diversi idiomi della risata, dei diversi modi di sorridere, delle diverse modalità fisiche, delle diverse emozioni, che aprono il libro di Terry Eagleton Breve storia della risata (trad. it. di Denis Pitter, Il Saggiatore, Milano 2020). L’impossibilità di una definizione univoca non esclude un’indagine sui concetti imparentati di comico, umorismo, grottesco, satira, invettiva, facezia, scherzo e via dicendo, e nemmeno sui concetti opposti di pianto e di tragico. Si tratta anzi di una vera e propria estetica dell’umorismo che Carlo Dossi propone come nuova letteratura e che ritorna in Palazzeschi e Gadda.
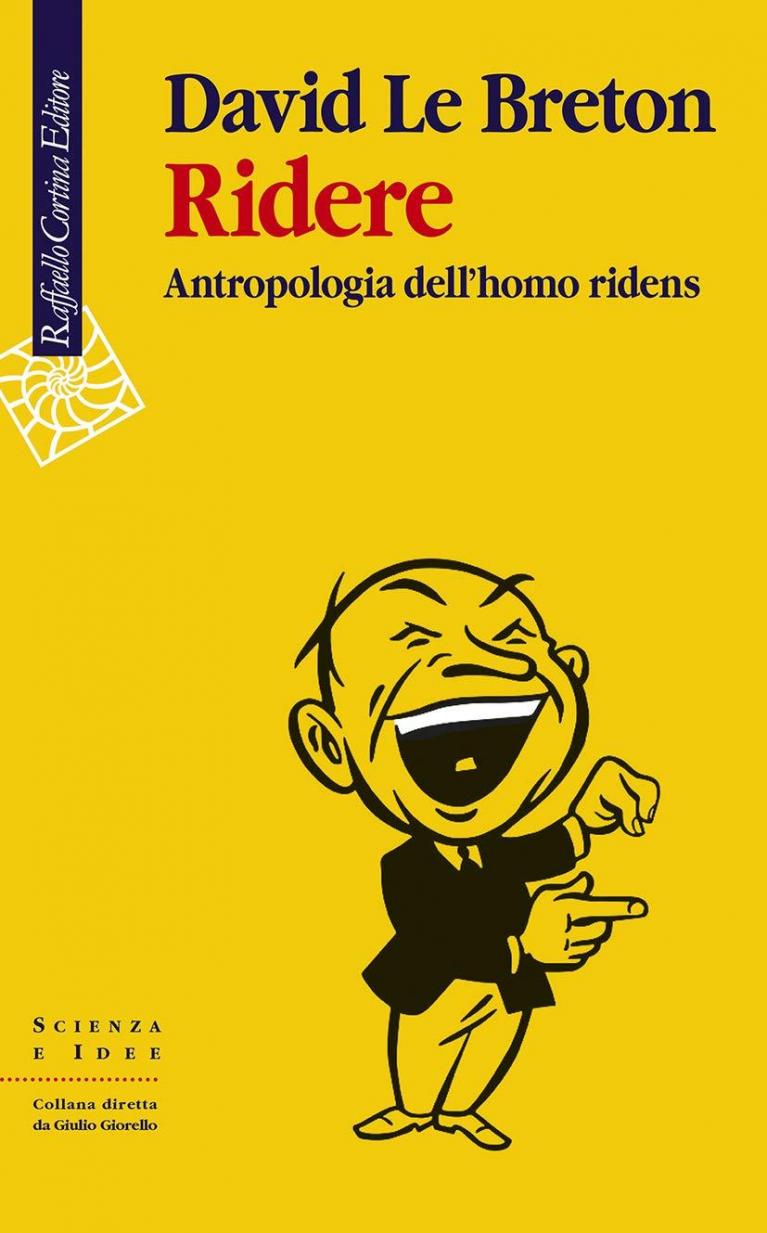
Il concetto cardine di questa estetica sta nel recupero dell’antico connubio di comico e tragico, già presente nel Simposio di Platone, ma declinato nella modernità. «Nella letteratura antica – scrive Dossi – o si rideva tutto o si piangeva tutto – e se talvolta il riso e il pianto convenivano nello stesso libro, ciò succedeva alternativamente. Nell’odierna invece Eraclito e Democrito sono venuti ad abitare la stessa casa – si ride e si piange, piove e fa sole nel medesimo istante. Ed ecco la letteratura umoristica – che è il giusto temperamento fra la passione e la ragione» (Note azzurre, n. 1161). Il motto di Giordano Bruno in tristitia hilaris, in hilaritate tristis può essere adatto al nostro futuro, nel quale intravediamo disastri ambientali e pericolosi rigurgiti politici totalitari: l’umorismo accosta al comico una sottile vena di malinconia dovuta alla visione scettica del mondo.
Lo scetticismo pone al centro della narrazione l’io, ma questo io si sdoppia, va a pezzi, si moltiplica, come l’io di Hume, diventa un fascio di sensazioni; ancor più in Dossi: si frantuma in «una popolazione di Ii, uno diverso dall’altro» (n. 2369), solo per potersi compiangere e rendersi ridicoli. Questo io non ha nulla a che vedere con la soggettività romantica, con l’io solipsistico di Fichte, oggetto del sarcasmo di Richter, non è nemmeno l’io di Weininger, impaurito dell’irruzione dell’Altro, soprattutto se in forma di donna. È l’io di Palazzeschi che riesce a spogliarsi dei luoghi comuni, che non si prende sul serio, che azzera il narcisismo, prendendosi a pesci in faccia, come farà Gadda che definisce l’io come «il più lurido di tutti i pronomi». «I pronomi! Sono i pidocchi del pensiero – scrive nella Cognizione del dolore –. Quando il pensiero ha i pidocchi, si gratta come tutti quelli che hanno i pidocchi… e nelle unghie, allora… ci ritrova i pronomi: i pronomi di persona» (La cognizione del dolore, Einaudi, Torino 1971, p. 85). È l’io che ritornerà in Landolfi come «dannato pronome» (Ombre, Firenze, Vallecchi, p. 121; cfr. Gino Tellini, «Liberarsi dei cenci». Il comico in Palazzeschi, in Le forme del comico, a cura di Simone Magherini, Anna Nozzoli, Gino Tellini, Società editrice fiorentina, Firenze 2019).
La tradizione dello scetticismo ci consegna anche la capacità di uno sguardo critico sul mondo, che nel comico e nell’umorismo diventa distaccarsi dalle cose, acquisire uno sguardo straniato, non integrato, divertito, ridere di tutto ciò che vi è di sacro nella vita di tutti giorni ben sapendo di appartenere a questa quotidianità priva di eroi, come scrive Fritz Mauthner nella voce Humor del suo dizionario filosofico del 1910, indicando come via per raggiungere l’essenza delle cose la strategia di aggirarle, disporle in lontananza, scivolare su di esse giocando con le parole (La maledizione della parola, Aesthetica preprint, 22, 2008) una strategia che ci può salvare anche nel nostro futuro.
.
C’è però un altro passaggio inquietante, prefigurato da André Breton nell’Antologia dell’humour nero che, nel 1937, raccoglie scritti di Baudelaire, Jarry, Savinio, De Chirico, Duchamp e molti altri, che hanno in comune la capacità di affossare ogni valore, di ridere anche del nulla con una risata agghiacciante, stampata sul viso come una smorfia alla Lautréamont. Questo scivolare del comico nel grottesco sembra trovare sempre più spazio nella letteratura e nell’arte, forse perché, come scrive ancora Gadda, «il barocco e il grottesco albergano già nelle cose» (op. cit., p. 236). Il termine ‘grottesco’ ha ampliato il suo significato originario legato alle grottesche rinascimentali, ispirate alle antiche decorazioni delle “grotte” degli scavi della Domus Aurea di Nerone, ne conserva però il richiamo nella libertà della creazione fantastica, nella deformazione, nella metamorfosi e nell’ibridazione che inducono spesso al sorriso e al riso. Invero non tutto il grottesco è comico, talora è pauroso e inquietante, ci turba, forse perché scopriamo che la maschera con il sorriso della smorfia non ce la possiamo più togliere, che non possiamo conciliare il brutto e il bello con gli strumenti della dialettica hegeliana, come aveva fatto, senza esserne del tutto convinto nemmeno lui, Karl Rosenkranz nell’Estetica del brutto.
Ricordate Quelli della notte di Arbore? Riccardo Pazzaglia, che interpretava il ruolo dell’intellettuale colto e squattrinato, invitava, ad ogni puntata, alla lettura di questo libro. Non aveva torto: l’impostazione fenomenologica di Rosenkranz ci può essere ancora d’aiuto per la riflessione su tutti i concetti legati in qualche modo al comico.
Non vogliamo comunque che il nostro futuro assomigli a quello descritto nel racconto dal titolo Palinsesto di Malerba (“Giornale d’Italia”, 1964, poi ripubblicato in Strategie del comico, Quodlibet, Macerata 2018, e inserito anche nella raccolta Sull’orlo del cratere, a cura di Gino Ruozzi, Mondadori, Milano 2018), nel quale l’umanità, in seguito a un cataclisma, si è ritirata a vivere nelle città sotterranee. Due professori – Selm e Kap – esaminano un reperto da museo, un misterioso segmento di nastro cinematografico che mostra un uomo in bombetta che cammina a zig–zag per la strada di una città del passato. Non capiscono: nella sequenza cinematografica talora l’uomo appare tagliato, la testa staccata dal corpo oppure il corpo senza la testa. Improvvisamente scoppiano a ridere. Non capiscono nemmeno il senso del loro ridere. Forse, si chiede Selm, forse l’arte stessa ha semplicemente lo scopo di far ridere, ma questa idea gli pare talmente azzardata, astrusa e irriverente che si vergogna di averla avuta. Riaccendono lo schermo, Kap inizia di nuovo a ridere, Selm non ride, vuole sorvegliare il volto di un suo lontano antenato seduto in una sala cinematografica: vuole capire come il comico produce il riso. Nemmeno noi lo abbiamo capito, ma ci teniamo moltissimo a ridere ancora.
Certo, ridere non è un progetto politico articolato per il futuro, e nemmeno tutto il ridere vi è contemplato. Direi il ridere come forma di resistenza, come lo definisce Le Breton che ci ricorda che il riso non è tollerato dai fanatici: in Afghanistan nel 1992, dopo la presa del potere da parte dei talebani, una delle prime misure adottate fu quella di proibire alle donne di ridere (il riso appartiene solo al maschio ed è osceno nelle donne). Goebbels dichiarò che l’umorismo doveva essere bandito dalla società perché ebraico e Hitler, nel luglio del 1933, riferendosi agli ebrei, aggiunse: «gli passerà la voglia di ridere...!». Nell’Unione sovietica di Stalin, durante gli anni Trenta, duecentomila burloni vengono arrestati per aver raccontato barzellette sovversive. Anche l’attacco alla redazione di Charlie Hebdo del gennaio 2015, che ci lasciò sorpresi e attoniti di fronte a una censura violentissima che pensavamo non avesse più spazio di esistere nell’Occidente democratico e liberale, testimonia il pericolo insito nell’umorismo per il fanatismo integralista. Il ridere implica la possibilità sovvertire le gerarchie, di prendere le distanze dal mondo, qualche volta addirittura, di invertire i ruoli tra vittima e carnefice.
Anche semplicemente il riso della gioia di chi non si prende sul serio è una bella patente per chi entra nel futuro con la consapevolezza della relatività delle cose di questo mondo.






