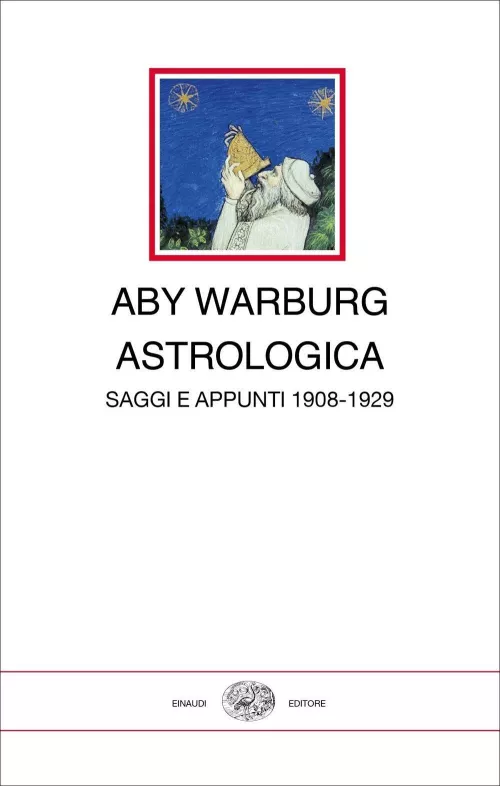Olimpico e demoniaco / Warburg e l’astrologia
Da anni l’opera e la figura di Aby Warburg (1866-1929) esercitano un’attrazione speciale e sempre crescente sulla cultura contemporanea, e non solo nel campo della storia dell’arte. Fenomeno che ha però anche un altro risvolto: Warburg è di moda. Citarlo, magari fuori luogo, è un modo per dimostrare di essere lungo la corrente giusta; a volte, invece, si ha l’impressione che evocare il suo nome serva per avvolgere le argomentazioni in una sorta di incenso nobilitante; poi, a non finire, ci si fa belli del suo motto (“Il buon Dio si nasconde nei particolari”), che non è suo: Ernst Gombrich ha smentito che la paternità sia sua, e ne ha rintracciato precedenti in ambito francese (e un’attribuzione a Flaubert). Del resto questa Warburg-moda non è cosa nuova: già Gertrude Bing (1892-1964), la sua più stretta collaboratrice, aveva scritto che la sua fama era “fondata più sul sentito dire che sulla conoscenza dei suoi scritti”, tanto che lo studioso amburghese ormai faceva parte di quella schiera di autori che “sono elogiati con più zelo di quanto siano letti”.

Ecco ora l’occasione per leggere di nuovo Aby Warburg: Maurizio Ghelardi, da anni suo attentissimo studioso, ha curato, per i Millenni Einaudi, Astrologica. Saggi e appunti 1908-1929; nel corposo volume troviamo articoli a stampa, manoscritti di conferenze, progetti di mostre: testi in gran parte inediti in Italia, tutti riguardanti il mondo dell’astrologia. Ghelardi vi premette un’ampia introduzione (Magia bianca. Aby Warburg e l’astrologia: un “impulso selvaggio della scienza”, pp. VII-LXX) che ripercorre la strada di Warburg dai suoi maestri e dalla sua formazione, fino agli ultimi progetti di ricerca (Giordano Bruno); la strada che, da una fitta “boscaglia”, era giunta a “un’altura libera e luminosa”, come aveva detto un suo allievo, Fritz Saxl.
Una parte consistente del saggio introduttivo è dedicata al rapporto tra Warburg e Ernst Cassirer (1874-1945). Al centro, naturalmente, ci sono simboli e immagini, che lo studioso amburghese affronta con un pensiero ben diverso da quello degli storici dell’arte suoi contemporanei. Per accorgersi di questa distanza basterebbe scorrere gli indici delle riviste d’arte del tempo: la presentazione di una trouvaille, l’analisi di un’iconografia, precisazioni e nuove attribuzioni, monografie su un artista minore, recensioni di libri e di mostre. Invece lo sguardo di Warburg – scrisse Cassirer – “non riposava in primo luogo sulle opere d’arte, poiché egli avvertiva e intravedeva dietro di esse le grandi energie creative. Tali energie non erano per lui altro che le forme eterne dell’essere uomo, della sua passione e del suo destino”. Per Warburg, spiega Ghelardi (p. XXVI), “le immagini sono depositi e trasformatori di spinte affettive che danno forma e creano una distanza, batterie di forza della vita che colpiscono l’occhio senza danneggiarlo”.
La storia dell’arte, del resto, allo studioso amburghese pareva ancora una “giovane disciplina”, brancolante “fra gli schematismi della storia politica e delle dottrine sul genio” (p. 63). Quando Warburg scrive queste parole ha 46 anni ed ha alle spalle lavori importanti: in un articolo del 1905, ad esempio, aveva messo a punto una delle idee più incisive: nella sua visione, gli antichi avevano coniato “formule genuinamente antiche di un’intensificata espressione fisica o psichica”, le Pathosformeln, schemi corporei che riuscivano a restituire visivamente il punto più alto dell’eccitazione emotiva; furono alcuni artisti rinascimentali, Dürer tra questi, a cogliere il senso profondo di queste “formule del pathos” e a valorizzarne l’energia nelle loro opere. Per la verità le “formulazioni di pathos” (così la traduzione in Astrologica) non hanno contorni troppo definiti; se in un primo tempo sembra prevalere il carattere di schema formale (per quanto carico di energia espressiva), più avanti nello stesso Warburg, quindi in Saxl e in Cassirer, si accentua il ruolo della dimensione simbolica. L’idea è insomma che l’analisi delle permanenze, dei sussulti e delle oscillazioni morfologiche riesca a illuminare i meccanismi della memoria visiva.
Compare, con le Pathosformeln, uno degli assi portanti delle ricerche di Warburg sin dalla dissertazione di laurea, la riflessione sul depositarsi della cultura classica nelle epoche successive, l’analisi della sua azione sul pensiero moderno; in particolare, si chiedeva lo studioso, quale significato aveva assunto l’antichità classica per gli uomini del Rinascimento? Forse questa inusitata ricchezza che l’Antico aveva avuto per il XV e il XVI, prima in Italia poi nel Nord europeo, poteva riverberarsi anche sul presente ed essere ancora d’aiuto “quando cerchiamo di perseguire una educazione razionale” (p. 184).

Può sembrare singolare, ma gli interessi astrologici di Warburg si inquadrano proprio in questo spazio, anzi ne sono uno dei momenti più rilevanti. In un congresso internazionale di storici dell’arte a Roma (1912), esamina il complesso degli affreschi nel salone di palazzo Schifanoia a Ferrara: è il saggio Arte italiana e astrologia internazionale a Palazzo Schifanoia a Ferrara (pp. 25-66, le illustrazioni a colori del ciclo corredano tutto il volume); facendo ricorso a una stupefacente sequenza di dati iconografici e testuali, per la prima volta lo studioso dà ragione dei soggetti (altrimenti a volte indecifrabili) e delle concatenazioni tra le varie sezioni del ciclo affrescato. Eppure non è questo ciò che gli preme, l’obiettivo non è offrire “la soluzione elegante di un enigma”; l’intento è di “sollevare un nuovo problema”, che viene esposto in questo modo: “in quale misura l’avvento nell’arte italiana di una trasformazione della figura umana può essere considerato come il risultato di un confronto transnazionale con le rappresentazioni figurative sopravvissute della cultura pagana dei popoli del Mediterraneo orientale?” (p. 63).
Banalizzando: nei primi decenni del Quattrocento, in Italia, le forme classiche sostituiscono quelle legate alla lunghissima tradizione tardoantica e medievale; questa sostituzione non è solo un fatto esteriore, poiché trascina ed è a sua volta trascinato da un concomitante cambiamento dei valori e delle idee, esito di un rinnovato confronto con la letteratura greca e latina. È in gioco qualcosa di più della perizia degli atelier degli artisti o del “genio” dei maestri (concludendo il suo intervento Warburg polemizza garbatamente con questa sopravvivente idea romantica, anche oggi tutt’altro che scomparsa); il caso ferrarese dimostra appunto che il recupero delle forme classiche avviene entro un fitto intreccio di relazioni spazio-temporali, attraverso una serie di “migrazioni” delle immagini astrologiche da est a ovest e da nord a sud.
I temi astrologici vengono esposti – con preziose varianti e inserimenti – da Warburg in più di una conferenza (testi che sono molto di più di semplici appunti, tanto è vero che vi troviamo addirittura le indicazioni necessarie alla proiezione delle diapositive in vetro: “buio!” ... “luce!”). Gli intricati itinerari delle immagini astrologiche ricostruiti dallo studioso delineano un nuovo scenario, in cui la contrapposizione non è tanto tra apollineo e dionisiaco, quanto tra olimpico e demoniaco. Ecco, ad esempio, come viene letta la decorazione astrologica della cappella voluta da banchiere senese Agostino Chigi in Santa Maria del Popolo a Roma: “l’Antico era venerato come arma bifronte: per un verso si presentava con un volto scuro e demoniaco, che esigeva un culto superstizioso, per l’altro con un viso sereno e olimpico, che richiedeva una venerazione puramente estetica”.
In questo passo, parte di un saggio scritto nel pieno della malattia (1920), si coglie bene l’inconfondibile maniera di Warburg, una scrittura concentrata sulla minuziosa analisi filologica, oppure – all’improvviso – impegnata a tracciare grandiosi quadri storici e geografici; una scrittura ora segnata da bagliori e oscurità, ora ornata da immagini estrose (“Dal bruco borgognone imbozzolato fuoriesce la farfalla fiorentina...”). Ma è un altro ancora il peculiare tratto warburghiano, che emerge di nuovo a proposito della Cappella Chigi: “qui le sette antiche divinità planetarie volgono ancora oggi lo sguardo verso il basso, anche se il loro temperamento pagano appare domato dai vicini angeli che stanno sotto la guida suprema di Dio Padre”; il testo anima una scena altrimenti immobile: le “divinità planetarie” non sono piatte figure dipinte, ma forme viventi impegnate nello scontro di sempre, quello tra la paura del caos e la serenità della luce, tra la sfera della magia e il mondo della logica.

Tensioni e conflitti che lo studioso stava indagando nell’età di Lutero, ma che aveva osservato prima di tutto su di sé, fino al disastro della crisi psichica, e oltre, nella successiva guarigione. Ernst Cassirer lo mise in rilievo nel suo necrologio: “Erano queste le tensioni che egli sapeva sempre di nuovo rinvenire, indipendentemente dalla molteplicità delle forme sotto le quali esse si nascondevano, e che egli perseguiva attraverso i secoli con una certezza incrollabile e visionaria. Tuttavia, tale capacità non corrispondeva solo al dono tipico del ricercatore o a quello dell’artista: Warburg attingeva qui proprio alla sua esperienza più intima” (p. LVII). Alla fine, stanno proprio qui, nell’impressionante – eppure fecondissima – coincidenza di esperienza personale e itinerario di studi, tanto le ragioni del fascino che, a quasi un secolo dalla sua scomparsa, Warburg esercita su di noi, quanto i limiti della sua stessa, pur grandiosa, visione.