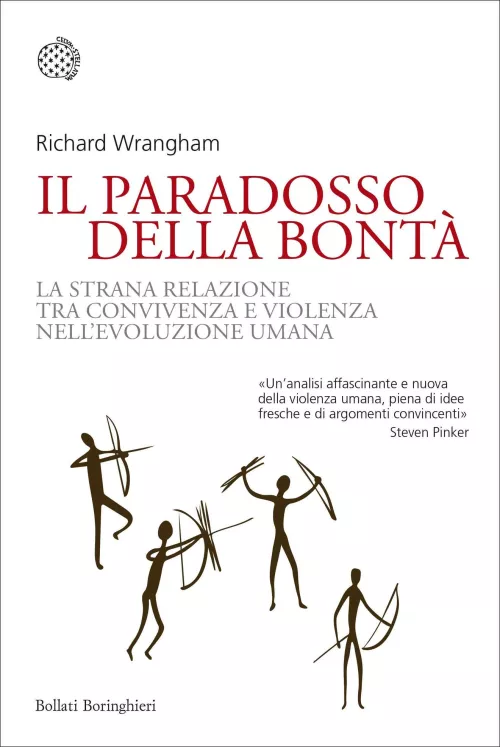Responsabilità / Diventare umani

In quello che è uno dei romanzi chiave del Novecento e del nostro tempo, Atlante occidentale, Daniele Del Giudice, parlando delle relazioni tra persone e del rapporto tra loro e il contesto, scrive: “Pensò che tutto questo teneva in piedi un individuo, come un’impalcatura, e se fosse venuto a mancare, chiunque sarebbe crollato, come quelle persone decapitate in movimento il cui corpo fa ancora qualche passo e cade giù” [p. 13, Einaudi, Torino 2019; prima edizione 1985]. Ci individuiamo diventando quello che siamo con gli altri e grazie a loro. È la nostra intenzionalità congiunta e collettiva, la caratteristica unicamente umana che sembra distinguerci come specie. È dinamica, quella caratteristica, e fa di noi quegli esseri che siamo perché è divenendo che esistiano, pur essendo noi principalmente concentrati sulla nostra essenza stabile, impegnati a difenderla e ad affermarla, come facciamo soprattutto in questo tempo, in cui brandiamo l’identità come se fosse un’arma.
Una tipica deformazione, una forma di autoinganno della nostra mente, dei tanti che ci caratterizzano e ci affliggono, pur se allo stesso tempo sono fonte del nostro modo di essere umani. Si tratta di processi costosi che, nel caso in cui si consolidano, sostenuti come sono dalla condivisione conformista, possono dar vita a processi di esclusione e distruzione. Per fare solo un esempio, il costrutto di razza appartiene, in effetti, a quei tipi di deformazione di cui stiamo parlando. Noi oggi sappiamo in modo inconfutabile che le differenze genetiche tra due esseri umani bianchi, nati da bianchi in una città italiana, ad esempio, possono essere più elevate delle differenze genetiche tra quei due bianchi e un essere umano con la pelle nera del Ghana o della Nigeria. Questo però non basta per evitare l’attribuzione di razza inferiore a chi ha la pelle nera e, soprattutto, di aver fatto e di fare della razza uno strumento di morte, di schiavizzazione e di esclusione, pur essendo, quel costrutto, una credenza culturale deformata dalla mente individuale e collettiva, anch’essa, quindi, un’intenzionalità congiunta e collettiva. Non diverso è il processo riguardante il costrutto di identità che, incluso il suo uso nel linguaggio quotidiano corrente, non corrisponde a nessun fenomeno effettivo, essendo noi caratterizzati da somiglianze evolutive e vivi in quanto diventiamo, cambiando continuamente, nei picosecondi dell’evoluzione delle nostre vite.
Delle somiglianze si è occupato Marco Aime su doppiozero, analizzando il libro di Francesco Remotti, Somiglianze. Una via per la convivenza, Laterza, Roma-Bari 2019. A quel cambiamento opponiamo la resistenza provvisoria della nostra durata e tendiamo a reificarla e a fissarla in un costrutto che vorremmo persistente, come quello di identità. Fissiamo quello che esiste in quanto è dinamico e reifichiamo le nostre stesse credenze e rappresentazioni. Le cose però, con tutta evidenza non stanno così. Non solo grazie alle verifiche scientifiche, ma anche nelle narrazioni e nei linguaggi di molte culture.
Ad esempio, la radice sanscrita bhu significa sia essere che diventare. Ogni essere è bhuta: siamo tanto congiunzioni quanto disgiunzioni nel continuum spaziotemporale delle nostre esistenze. Diventiamo quello che esprimiamo nella nostra esperienza umana. E ciò non riguarda solo noi: i pesci ereditano non solo le pinne ma anche l’acqua; i cuccioli umani ereditano un ambito socioculturale ricco di artefatti, di simboli e di istituzioni culturali, e non si comprenderebbero le loro esclusive capacità di maturazione senza un contesto culturale in cui svilupparsi. “Diventare” sta diventando una parola importante quando si parla di cosa significa essere umani. Questo gioco di parole indica un campo di particolare rilevanza per comprendere chi siamo. Fissarsi sull’ente piuttosto che sulla dinamica mediante la quale l’ente diventa tale, è stato ed è un continuo tentativo di creare una verità su chi siamo e come siamo diventati quello che esprimiamo.
Veniamo scoprendo che più che agli enti conviene guardare alle relazioni e alle interdipendenze tra gli enti. Non si tratta di mettere in discussione le condizioni evolutive di lunga durata che ci fanno appartenere ai mammiferi, al regno animale e al sistema vivente sul pianeta dove viviamo. Certo che esiste la predisposizione, ma non darebbe vita a niente se non si entrasse in relazione. Pare proprio che sia nella relazione e nell’intersoggettività che diventiamo noi stessi. Non smettendo mai, peraltro, di diventarlo. Divenire vuol dire essere in grado di creare in continuazione mondi altri e mondi oltre. Conoscendo e conoscendoci ci individuiamo e la conoscenza è sostituzione continua: ogni artefatto e ogni immagine di noi è ricorsiva con noi stessi mediante la risonanza con gli altri e la loro restituzione. Entra così in crisi il mito dell’individuo, dell’indivisibile. Quel gioco incerto dell’azione con cui ci individuiamo smentisce la nostra pretesa di trasparenza e di neutralizzazione dell’opacità. È l’opacità che fa sì che noi siamo un dialogo in quanto negli spazi dell’incertezza e della non determinabilità dell’altro si aprono le condizioni per riconoscerci in quanto riconosciuti. È nel dialogo che ci individuiamo. Quando la risonanza e il ritorno riconoscente si interrompono, com’è accaduto, ad esempio, per l’uscita dall’eliosfera di Voyager 2, noi siamo perduti. Il non riconoscimento equivale alla perdita: rasentiamo e spesso sperimentiamo, oggi, con la crisi del legame sociale e la singolarità, la crisi dell’intersoggettività che genera l’individuazione.
Michael Tomasello, giungendo a un compendio di circa trent’anni di lavoro sperimentale, fornisce un ampio spettro di verifiche dei processi mediante i quali diventiamo umani. Accanto alle tesi che la specie umana sia diventata così com’è mediante l’evoluzione, Tomasello pone al centro lo sviluppo e, con le sue ricerche, mostra come i fattori che ci rendono distintivamente umani si costruiscono nei primi anni di vita dei bambini. L’attenzione delle ricerche presentate in questo libro, Diventare umani, Raffaello Cortina Editore, Milano 2019, che riesce a proporsi come un punto di svolta e una sistemazione di particolare importanza sul significato di essere umani, è rivolta principalmente alle trasformazioni ontogenetiche che sfociano nella psicologia unicamente umana di un bambino di sei o sette anni, che opera nella sua cultura come una persona emergente basata sulla ragione e sulla responsabilità.

Un ex-ergo che Tomasello pone, all’inizio della parte prima, contiene l’ipotesi scientifica su cui si fonda l’intero percorso del libro. È dovuto a Edward O. Wilson che con la sua sapienza, in L’armonia meravigliosa ha scritto: “Sono le regole epigenetiche, le regolarità ereditarie dello sviluppo mentale che […] collegano i geni alla cultura […]. La ricerca della natura umana si può considerare come l’archeologia delle regole epigenetiche”. Ci eravamo chiesti a lungo come fosse stato possibile che un nuovo ramo dell’albero evolutivo potesse vivere una vita così profondamente differente da quella degli altri animali, compresi quelli molto simili da cui si era dipartito solo circa sei milioni di anni prima. In proposito Tomasello fa un’affermazione particolarmente impegnativa: “Oggi quell’enigma è stato sostanzialmente risolto”. E come? “A un certo punto della storia umana, è scaturito un nuovo processo evolutivo”. Noi umani viviamo tra i nostri artefatti, tra le nostre regole, i nostri simboli e le nostre istituzioni. “E poiché i bambini, qualunque sia la loro genetica, adottano gli artefatti, i simboli e le istituzioni particolari in cui sono nati, è chiaro che questa variazione nelle società, non può derivare dai geni, ma si crea socialmente. Il vero enigma, pertanto, è che gli umani, oltre a essere una specie che ha raggiunto traguardi cognitivi e sociali senza precedenti, sono al contempo una specie che esprime un nuovo genere di diversità a livello di gruppo, una diversità creata socialmente”. In quanto novità evolutiva, quella di homo sapiens scaturisce non dalla selezione naturale, “ma piuttosto dall’altra dimensione importante del processo evolutivo: la variazione ereditaria”. Sono la mutazione e la ricombinazione genetica a produrre, tramite processi ontogenetici, nuovi tratti.
Qui Tomasello mobilita e valorizza i recenti progressi della biologia evolutiva dello sviluppo, la cosiddetta Evo-Devo (Evolutionary Development Biology), in base alla quale sappiamo che non soltanto nuovi tratti nascono da processi ontogenetici, ma essi derivano dalle modalità e dalla tempistica con cui i geni esistenti sono espressi e vengono a patto con l’ambiente. “L’implicazione è che, se desideriamo spiegare come si crea la psicologia unicamente umana, dobbiamo concentrare la nostra attenzione sull’ontogenesi, e in particolare su come l’ontogenesi nelle grandi scimmie, in generale, si è trasformata nell’ontogenesi umana, in particolare” [p. 6]. Come con Wilson, Tomasello appoggia i propri piedi sulle spalle di giganti e lo fa anche con Lev E. Vygotskij, proponendo una teoria neo-vygotskijana: “La nostra ipotesi di lavoro per spiegare l’ontogenesi di una psicologia unicamente umana si richiama a Vygotskij: forme unicamente umane di cognizione e di socialità scaturiscono nell’ontogenesi umana, attraverso, e soltanto attraverso, forme di attività socioculturali esclusive della specie” [p. 7]. A sostegno di questa ipotesi è convocata la moderna teoria evoluzionistica che evidenzia come gli organismi ereditano i propri ambienti non meno di quanto ereditino i propri geni.
Da tempo la ricerca di Michael Tomasello si è concentrata sull’evoluzione della cooperazione umana e sul potere dell’agentività condivisa per cercare di comprendere come esse permettano i processi di coordinazione e di trasmissione culturale, cercando anche di riconoscere i motivi che fanno della cooperazione e dell’agentività condivisa aspetti distintivi e esclusivi della specie umana. Vale la pena fare subito un chiarimento ed evidenziare come quegli aspetti distintivi non significhino nulla che abbia a che fare con una presunzione di virtù e di bontà nell’esperienza umana. Ciò vale anche per il comportamento morale a cui Tomasello fa esplicito riferimento con i suoi contributi di ricerca. Siamo di fronte a caratteri distintivi della specie umana che presidiano tanto alla virtù quanto alla violenza, che entrambe richiedono coordinazione, cooperazione e agentività condivisa. A darci una mano a chiarire questi aspetti e ad assumere una posizione analitica e basata su un attento esame di realtà, è un contributo di Richard Wrangham apparso nel 2019 col titolo Il paradosso della bontà da Bollati Boringhieri, Torino, che esplora la strana relazione tra virtù, convivenza e violenza nell’evoluzione e nella storia umane.
Wrangham, che da studente ha avuto l’opportunità di collaborare al progetto di ricerca sugli scimpanzé che Jane Goodall stava conducendo in Tanzania, è giunto insieme ai suoi colleghi a porsi una domanda: come mai gli scimpanzé erano relativamente aggressivi rispetto ai cugini bonobo molto più pacifici? La conclusione a cui sono giunti è che i bonobo si siano separati dagli scimpanzé tramite un processo molto simile alla domesticazione, che loro hanno definito “autodomesticazione”. Analizzando le affinità tra i primati e gli esseri umani, Wrangham riconosce che anche noi umani, all’interno delle nostre comunità sociali, abbiamo una scarsa propensione allo scontro e siamo molto tolleranti rispetto agli altri mammiferi selvatici. Eppure nella società umana la violenza è pervasiva e ineluttabile, e le teorie che ne danno conto sono abbastanza solide. Emerge perciò una domanda: in che modo le nostre qualità da animali addomesticati si conciliano con la nostra capacità di mettere in atto violenze terribili? L’approfondita analisi dell’autore, che investe le proprie competenze di antropologia biologica e di biologia comportamentale dei primati, giunge alla formulazione di una spiegazione che contiene notevoli aspetti di originalità. A differenza di quello che potrebbe apparire a prima vista, tolleranza sociale e aggressività degli umani non sono due comportamenti opposti. Si tratta di due comportamenti basati entrambi sull’aggressività, ma elaborata in modi diversi. La tolleranza sociale è associata a un tipo di aggressività che viene definita reattiva, verso la quale noi umani abbiamo una tendenza piuttosto scarsa. La violenza che ci rende distruttivi e letali nasce, invece, da un’aggressività definita proattiva. Cercando le origini della nostra mente moderna nelle profondità del tempo Wrangham mostra come la nostra specie abbia finito per unire le due tendenze – scarsa aggressività reattiva ed elevata aggressività proattiva – in una storia che non è ancora stata raccontata. L’aggressività sembra essersi evoluta in maniera diversa in ciascuna specie.
A lungo abbiamo pensato che l’aggressività si fosse evoluta lungo una sola dimensione, dai valori bassi ai valori alti. Oggi, alla luce di decenni di ricerca che Wrangham documenta ampiamente, sappiamo che l’aggressività non compare in una sola forma, ma in due, ciascuna con le proprie basi biologiche e la propria storia evolutiva. Noi umani mostriamo un marcato dualismo: abbiamo un valore ridotto sulla scala dell’aggressività reattiva, e un valore elevato su quella proattiva. L’aggressività reattiva è una risposta a caldo, come quando per reazione immediata si sferrano colpi alla cieca. L’aggressività proattiva è una risposta a freddo, pianificata e intenzionale. In nome della prima forma di aggressività noi umani mostriamo una relativa docilità e tolleranza, aspetti scarsamente presenti negli animali selvatici, tranne che nelle specie addomesticate. Ciò depone a favore dell’ipotesi che noi umani attuali siamo la versione addomesticata di antichi progenitori. Dal momento che gli animali addomesticati mostrano notevoli affinità di comportamento, la domesticazione emerge come una spiegazione possibile della forma di aggressività reattiva degli umani. Ma chi ha domesticato gli umani?, si chiede opportunamente Wrangham. Grazie agli studi sui bonobo possiamo trovare una risposta attendibile. I bonobo, ad ogni evidenza, devono essersi addomesticati da soli. La stessa cosa pare sia accaduta da circa trecentomila anni in avanti per noi esseri umani homo sapiens. Se per ciascuna specie c’è una risposta diversa, gli indizi per comprendere l’autodomesticazione vanno cercati nei modi con cui si impedisce agli individui aggressivi di dominare sugli altri. Nel caso dei bonobo, i maschi aggressivi sono fermati per lo più dall’azione congiunta delle femmine che collaborano tra loro, punendo i maschi arroganti.
Nel caso degli umani, secondo Wrangham, sarebbe stata la forza selettiva dell’esecuzione capitale a creare le condizioni dell’autodomesticazione. L’impego della pena capitale nelle società umane avrebbe avuto la funzione di costringere i maschi dominanti a rispettare le norme egualitarie e a contenere l’aggressività reattiva degli esseri umani. Il libro si conclude con la frase: “Ironia della sorte, sono stati proprio gli assassini a portarci sulla soglia della saggezza” (p. 359). È questo un punto sul quale l’analisi stringente e documentata dell’autore suscita una reazione impegnativa, oggi, ma osservando con sguardo obiettivo il passato violento è difficile falsificare l’ipotesi proposta. Il confronto con i Neanderthal consente a Wrangham di sostenere che, grazie al contenimento maggiore dell’aggressività reattiva da parte di homo sapiens, è stato possibile dotarsi di una cultura più elaborata rispetto ai Neanderthal. Un altro fattore distintivo connesso al contenimento dell’aggressività reattiva da parte di noi esseri umani è, secondo Wrangham, il senso morale, rispettando il quale, una volta consolidato in una comunità, i suoi membri hanno scongiurato il pericolo di essere condannati e giustiziati. L’aggressione proattiva caratterizza tutte le società umane. La sua manifestazione sembra strettamente connessa all’esercizio del controllo sociale. Nel caso di homo sapiens c’è da dire che l’aggressività proattiva si spinge ben oltre quella degli scimpanzé e degli altri primati.
Noi disponiamo di un’abilità unica per concepire e organizzare l’aggressività proattiva: un esempio è la guerra. Nel confronto fra chi difende una prospettiva che Wrangham definisce rousseauiana, secondo cui saremmo una specie pacifica per natura corrotta dalla società, e chi difende una tesi hobbesiana, che ci considera una specie violenta per natura, civilizzata dalla società, la tesi del libro è che noi esseri umani siamo sia capre che leoni. “Abbiamo una scarsa tendenza all’aggressività reattiva e una elevata tendenza all’aggressività proattiva” (p. 345). Il paradosso della bontà, insomma, consiste nel fatto che noi esseri umani in confronto agli altri primati, nella vita quotidiana, pratichiamo livelli di aggressività eccezionalmente bassi; mentre la violenza delle nostre guerre provoca tassi di mortalità eccezionalmente alti. Ereditando i nostri ambienti e le modifiche introdotte e apprese, insomma, siamo diventati quello che siamo.
L’attenzione a quanto precede e concorre a formare l’ontologia consente a Tomasello di evidenziare che gli organismi ereditano i propri ambienti non meno di quanto ereditano i propri geni: “i cuccioli umani ereditano un ambito socioculturale ricco di artefatti, di simboli e di istituzioni culturali, e le loro esclusive capacità di maturazione sarebbero sterili senza un ambito socioculturale entro cui svilupparsi”. Concentrandosi sulle vie evolutive della cooperazione umana e su come si generano i processi di coordinazione e di condivisione culturale esclusivi della specie umana, Tomasello elabora il ruolo dell’intenzionalità congiunta che opera diadicamente, e dell’intenzionalità collettiva propria dei gruppi culturali. Emerge allora l’importanza della dimensione coordinativa della cultura e dell’insegnamento e dell’apprendimento conformista, con una rilevante integrazione rispetto alla prospettiva di Vygotskij che si era concentrato principalmente sulla dimensione trasmissiva della cultura. Le vie di sviluppo identificate sono riconducibili a tre insiemi di processi:
- In primo luogo, vi sono i processi di maturazione, che sono i riflessi più o meno diretti della storia evolutiva umana. Sono le capacità di intenzionalità condivisa proprie di ogni bambino a strutturare l’unicità cognitiva e sociale umana. Da quelle capacità si dispiegano i due passaggi essenziali: l’intenzionalità congiunta e l’intenzionalità collettiva.
- Il secondo insieme di processi riguarda le esperienze individuali dei bambini, con particolare riguardo alle esperienze socioculturali. “L’ontogenesi cognitiva e sociale unicamente umana dipende essenzialmente da scambi tra l’individuo e una ricca ecologia culturale”. La tesi sostenuta da Tomasello è che i bambini, prima dei tre anni, sono strutturati prima di tutto per sollecitare le cure e l’attenzione degli adulti. Dopo i tre anni sono predisposti sia per l’apprendimento culturale derivante dall’insegnamento degli adulti, che per sviluppare nuove abilità mediante interazioni intersoggettive e coordinate con i pari”.
- Un terzo insieme di processi è dato dalle varie forme di autoregolazione esecutiva proprie degli esseri umani. Questo punto è fortemente ispirato a Vygotskij e sostiene che molti aspetti dell’unicità cognitiva e sociale umana derivino dai modi in cui i bambini cercano di autoregolare esecutivamente i propri pensieri e le proprie azioni, non solo individualmente, come fanno molti primati, ma anche socialmente, tramite il controllo costante delle prospettive e delle valutazioni dei partner sociali. Prima dei tre anni la regolazione esecutiva dei bambini è principalmente individuale. Dopo i tre anni i bambini cominciano ad automonitorare socialmente la propria comunicazione. Lo fanno per verificare se sono comprensibili e ragionevoli per gli altri, e cominciano a verificare l’impressione che fanno agli altri, in modo da conservare le possibilità cooperative e per questo si autoregolano collaborativamente.
Per sostenere le proprie ipotesi Tomasello fa ricorso a un ampio e articolato apparato di ricerche che suffragano la prospettiva prescelta. Quello che interessa all’autore è evidenziare tutto quanto ci rende unicamente umani. Alla ricerca dell’unicità umana, l’attenzione viene riservata ai fondamenti evolutivi e all’ontologia della specie. Dopo un’analisi critica riservata alla cosiddetta psicologia dello sviluppo, l’autore si concentra sull’ontogenesi della cognizione unicamente umana. Considera così la cognizione sociale e lo sviluppo dell’attenzione congiunta; la capacità di immaginare cosa gli altri percepiscono; la coordinazione di prospettive e l’elaborazione della capacità di giudizio. È poi la volta dell’analisi della comunicazione, sia intenzionale, che cooperativa, che convenzionale. Uno dei vertici più interessanti del contributo di Tomasello riguarda il processo del diventare simbolici che è anche l’occasione per situare con maggiore precisione il ruolo del linguaggio verbale articolato. In particolare, mostrando la connessione tra la complessa infrastruttura pragmatica della comunicazione umana, con l’utilizzo di gesti referenziali e cooperativi, per poi acquisire un linguaggio convenzionale. Si evidenzia in tal modo uno dei fattori portanti dell’approccio di Tomasello, che riserva un ruolo di particolare rilevanza all’apprendimento culturale.
È l’apprendimento culturale che sollecita una conformità alle convenzioni e allo stesso tempo fornisce contingentemente all’individuo le condizioni per superarle. Siamo di fronte a una circolarità strettamente vygotskijana. Per queste vie si giunge al pensiero cooperativo e alla sua costitutiva importanza per l’espressione dell’intenzionalità condivisa. Nella parte terza del libro, Tomasello si concentra sull’ontogenesi della socialità unicamente umana e approfondisce la collaborazione, la pro-socialità e le norme sociali, fino alla produzione dell’identità morale. Non senza evidenziare i limiti delle teorie analizzate, l’articolato e documentato contributo di Tomasello giunge a proporre una teoria dell’agentività condivisa e del suo potere, in una prospettiva neo-vygotskijana. La teoria dell’intenzionalità condivisa invoca simultaneamente una predisposizione biologica unicamente umana per l’intenzionalità condivisa, intesa come causa permissiva, e l’esperienza socio-culturale individuale come causa prossima.
Per spiegare l’ontogenesi dell’unicità umana sono necessarie entrambe. Gli esiti unicamente umani che scaturiscono da queste condizioni costitutive possono essere parzialmente individuati, secondo Tomasello, in una serie di processi con cui diventiamo umani, quali: l’attenzione congiunta, l’assunzione di prospettiva, i gesti cooperativi/referenziali, la comunicazione linguistica convenzionale, l’imitazione con inversione dei ruoli, la conformità, l’apprendimento istruito, il pensiero ricorsivo, la soluzione cooperativa di problemi, la presa di decisioni coordinata, la collaborazione a duplice livello, l’impegno congiunto, il senso di equità e di giustizia, la protesta in seconda persona, l’applicazione e la creazione di norme sociali, la gestione dell’impressione attiva, un senso di vergogna e di colpa, un concetto di orientamento morale. Un senso profondo di responsabilità prende, alla fine di questi due importanti contributi, in quanto risulta difficile falsificare la verifica che umani si diventa: come, è lasciato alla responsabilità di ognuno di noi.