La realtà disturbata da Cartongesso
Cartongesso di Francesco Maino (Einaudi 2014) è come uscire dall’acqua dopo una lunga non voluta immersione e tirare il fiato tutto d’un colpo e riconquistare l’ossigeno. Una salutare esplosione nervosa, un urlo totale. Io credo che non si possa dire di meglio di un romanzo. Maino ha saputo costruire una drammaturgia speciale, giocata su un solo personaggio, un’unica corda tesa attorno a cui si disgrega una realtà che negli ultimi trent’anni era andata assumendo le mostruose proporzioni di una impresa colossale e folle che ha rischiato di risucchiare in sé le molte energie del Veneto, cioè di una parte cospicua della popolazione italiana.
Ecco, già dopo poche righe la mia narrazione se ne esce dal contesto finzionale di un romanzo e si caccia immediatamente nella chiacchiera “contenutistica” che riguarda tutt’altro. Io vorrei parlare di Cartongesso come romanzo, non del Veneto e delle sue recenti vicende storiche. Io vorrei provare a dire come “l’inesorabile potenza” (dalla quarta di copertina) di questa storia stia nel come l’autore ha saputo affrontare il tema e non nel tema tout-court. E in effetti tutto comincia dal titolo: con Cartongesso Maino prende la realtà drammaticamente complessa del Veneto contemporaneo e ne fa materiale da costruzione per il racconto della tragedia di un uomo contemporaneo.
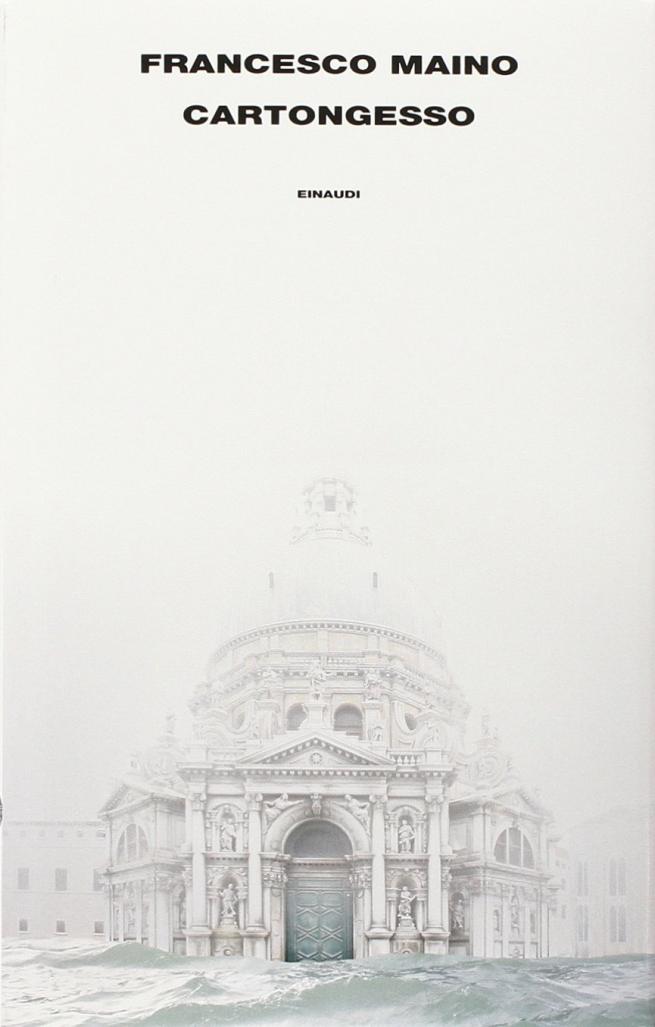
La vicenda di Michele Tessari, avvocato in Insaponata, si svolge nella terra che sta ai bordi della grande Venessia, nel Mesovenetorientale, dove gli uomini sono dediti al consumo di cose e di sé, dove si parla “il grezzo” (“sintesi della sintesi del dialetto delle paludi del seimila (6000) avanti Cristo bonificate nel primo Novecento dalle forze liberali”, p.14), dove solo la miseranda professionalità di Tessari può accogliere la vasta umanità dolente dei neoschiavi, per lo più stranieri, maltrattati e vilipesi e bisognosi di assistenza legale nel tentativo di riavere posti di lavoro perduti, salari dovuti e negati, case popolari rifiutate, e tutto senza un soldo con cui pagare il professionista. Tessari, figlio che non si emancipa da mamma e papà, che beve, tanto, che mangia, tanto, che vede tutto un mondo di “leader sociali”, politici o imprenditori, personaggi-brand di una avidità satanica, splendide coppie composte da mogli-puttanoni e mariti-“capannoidi”. E gli avvitopi, gli avvocati del tribunale di Venessia, popolazione di avvilenti animali che proliferano nella decomposizione generale. E Tessari, senza ancoraggi affettivi, macinato da un disturbo bipolare e dall’odio – un’infezione che cammina “dalle caviglie alla bocca” –, un odio sterminato per tutto e tutti e per se stesso, non ce la fa più a sopportare un mondo di cui è parte e nel quale tutto va in malora, perché, dice, «questo è il paese delle cose che stanno morendo. No. Questo è il paese dei corpi. Un paese pieno di corpi. Corpi che si svegliano morti, escono morti di casa, tornano morti; corpi che parcheggiano, scendono, sputano, corpi che si salutano, sbadigliano, bestemmiano sempre, fatturano. Corpi camminanti che hanno rapporti automatici con le cose e con gli altri corpi camminanti» (p.46). Fino alla fine, senza redenzione, con una lingua acuminata ed emotivamente aggressiva con cui Michele Tessari narra e conduce se stesso, il soccombente, allo spegnimento.
L’obiettivo primario di Cartongesso non è quello – troppo facile e asfittico – di dissacrare la terra natia o fabbricare invettive contro l’infima eticità del sistema economico che vi si è sviluppato, come in questi mesi spesso è stato detto riducendo il romanzo a “una sociologia” di Maino (in questo senso un culmine, direi imbarazzante, lo raggiunge Camillo Langone sul “Foglio” del 28 aprile scorso). La realtà di cui parla esiste, e lui la descrive e racconta con grande penetrazione ed efficacia scientifica, pagine e pagine di formidabili “disegni esplicativi” del meccanismo rovinato del Nordest, di ciascuna cosa ti spiega che cos’è e quali sono i percorsi che l’hanno fatta maturare, ma il senso del romanzo non sta nell’analisi della genesi della tragedia di Michele Tessari, di un’esistenza di oggi. Semmai si tratta di capire in che misura quella realtà ha determinato questa tragedia. Bisogna disturbare il reale per tirarlo fuori, per stanarlo, lo si deve urticare, devi dargli fastidio, se non gli si dà una spallata e lo si maltratta il reale non risponde, si limita a farsi guardare e osservare, a farsi descrivere e blandire, e a esistere ignorandoci. Questo ha fatto Maino, anzi Tessari (i due naturalmente vanno tenuti ben distinti), ha disturbato il reale, lo ha imbibito di vetriolo per poi immolarsi – “bonzo veneto” –, e svelare al mondo questa Waste Land. “Voi mi vedete ma è un vedere malato – pensa Michele Tessari passeggiando per Insaponata –, voi dite di vedere ma il vostro è il vedere d’un cieco [Giovanni 9.I–4], e io il fango che fa miracoli e toglie i peccati del mondo per i vostri occhi sfrattati non ce l’ho, non ce lo metto, non ve lo spalmo, e se anche sputassi per terra come il Cristo, se tentassi, lo sputo finirebbe sul marciapiede, sul cemento, non sulla terra, la terra da noi è finita, tutta cementificata, ingoiata, masticata, deglutita, digerita, cacata.” (p. 52)

Un muro di cartongesso è la finzione di un muro, è fatto di un materiale con cui si costruiscono strutture fittizie, pareti, scaffali, che servono a modificare l’interno di una casa più per un effetto visivo di arredamento, potremmo dire di scena, che per scopi di reale necessità strutturale. Le case non sono di cartongesso, eppure la gente ricorre spesso a questa soluzione per armonizzarne lo spazio interno, per sfruttare al massimo il vuoto che sta tra le pareti portanti, insomma per vivere meglio. Ecco, io trovo che il Cartongesso di Francesco Maino svolga esattamente questo compito, ed essendo un romanzo ben fatto ci aiuta a vivere meglio. Proprio perché è una costruzione finzionale. L’istanza che lo muove, cioè, non è informativa. La finzione sussume la realtà. E il Veneto, questo Veneto folle, in Cartongesso non è una pezza d’appoggio ma una precisa dimensione della sua costruzione drammaturgica. Il punto è questo: è la finzione del romanzo che governa il dato di realtà e non il contrario. Proprio come accade célinianamente, fatte le debite distinzioni, con la spaventosa America di William Faulkner, o l’Austria di Thomas Bernhard, o la Germania di Heinrich Böll o Günter Grass, o l’Ungheria di Ágota Kristóf, o la Francia di Houellebecq, o la Brianza di Gadda, ecc. ecc.
La ratio della letteratura sta al di là della realtà, è nella facoltà di sintesi che è propria degli uomini. Inventiamo cornici narrative entro cui mettere il reale per ricavarne una nuova esperienza, di emozioni e conoscenze. I singoli brani del mondo non hanno in sé alcun valore per la letteratura. Il singolo fatto può avere valore per chi lo vive e per coloro che ne riferiscono, o per chi dà informazione della sua esistenza. Saviano, con Gomorra, ci informa, con fare letterario, dell’orrore camorristico, e ciò che domina è l’informazione non il fare letterario poiché egli non ha un’idea letteraria, una cornice di significato oltre i fatti che narra. L’istanza, cioè, è informativa.
Penso al Veneto estetizzato di Parise dei Sillabari. Anche lui percorre il mondo per raccoglierne il senso nei suoi Sillabari, lancia in mare le sue lunghe reti a strascico, dalle maglie sapientemente larghe o strette, e tira su di tutto e poi mette in ordine, in un suo ordine, e lo espone nelle casse del mercato in bella mostra per vendere profumi, suoni e viluppi umani. L’istanza, cioè, non è informativa. È sempre la finzione che sussume la realtà.
“La realtà non è un racconto ben fatto” (Mario Lavagetto), ma una immensa perpetua dinamica tra quel che c’è e quel che può ancora avvenire, e quel che si può immaginare possa avvenire; la vivezza indefinita che scaturisce da questa dinamica, è il materiale da costruzione dello scrittore. Egli può lavorare con tutti gli avvenire che la sua immaginazione può produrre. Lo scrittore trasforma la realtà in “un racconto ben fatto”, è la forza lavoro che trasforma la materia prima in merce, e quindi in ricchezza aggiungendovi valore.
Della rapacità del reale sul finzionale ormai si va parlando dappertutto (non ho trovato di meglio di Realismo e letteratura di Federico Bertoni, Einaudi 2007, e Il realismo è l’impossibile di Walter Siti, Nottetempo 2013), e molto molto spesso oziosamente, pare una cultura invalsa di cui dovremmo convincerci. La TV, la rete e le tecnologie, nonché il presidente del consiglio Renzi che divorerebbe House of Cards, cioè fiction che produce realtà che produce fiction… Ma io credo che le astuzie della finzione si pongano ben al di là delle diverse realtà. Penso che la rapacità del reale dipenda essenzialmente dal fatto che la finzione come arte di composizione del simbolico è più coerente con un’epoca di solidità storica ed economica e mal si adatta ai momenti, come questo nostro, di estremo rischio sociale e materiale in cui il fabbisogno di concretezza è più elevato. Ed è ancora ragionevole pensare che la letteratura, comunque, conservi la sua funzione primigenia che “è e continua a essere quella di ancorarci alla realtà incentivando l’intesa con i nostri simili” (Mario Barenghi, Cosa possiamo fare con il fuoco? Letteratura e altri ambienti, Quodlibet, Macerata 2014, p.22).







