Un libro di Alessandro Zaccuri / Poco a me stesso: un'autobiografia alternativa
Tra le declinazioni della forma romanzesca si annovera da tempo la narrativa controfattuale, fondata sull’ipotesi che un cruciale evento storico – tipicamente, una guerra – abbia avuto esiti diversi da quelli realmente verificatisi. Esempio preclaro, La svastica sul sole di Philip K. Dick (The Man in the High Castle, 1963), ambientato alcuni anni dopo il presunto trionfo della Germania nazista e del Giappone sulle democrazie occidentali; ma non andranno dimenticati alcuni casi italiani, come Contropassato prossimo di Guido Morselli (1969-70, uscito postumo nel 1975), che ribalta l’esito della Grande Guerra immaginando vincenti gli Imperi centrali, o Asse pigliatutto di Lucio Ceva (1973), imperniato sull’eventualità di un irriducibile isolazionismo da parte degli Stati Uniti. L’attrattiva che suscita il filone delle ucronie, del romanzo fantastorico o «allostorico», del «What if», dipende evidentemente dalla sensibilità o dalla curiosità anti-deterministica del lettore: alla base è la percezione del divenire come risultanza mai inevitabile e mai ovvia di un insieme impregiudicato di variabili.
Ma cosa accade se la dimensione controfattuale si sposta dal campo lungo degli eventi collettivi, sfondo di una trama d’invenzione, al primo piano della biografia d’un personaggio famoso? Qualche decina d’anni fa, in Io venìa pien d’angoscia a rimirarti (1990), Michele Mari immaginò che gli incantati notturni lunari di Leopardi adombrassero un caso di licantropia. Alla figura di Leopardi si è ispirato più di recente anche Alessandro Zaccuri; ma la trama del romanzo Il signor figlio (Mondadori, 2007) comincia dove la vita del poeta nella realtà finisce, cioè nel 1837. Anziché morire di colera, qui Leopardi s’imbarca sotto falso nome per l’Inghilterra, dove il suo destino s’intreccia con quello di Kipling: dunque, più che la riscrittura fantastica di un’esistenza reale, si tratta di una giunta, un supplemento – un sequel. Nel suo ultimo libro – Poco a me stesso (Marsilio, pp. 234, € 16) – Zaccuri si dedica invece ad Alessandro Manzoni: o per dir meglio alla madre, Giulia Beccaria, còlta nelle ultime sue settimane di vita, cioè all’inizio dell’estate del 1841.
L’idea di fondo – la «trovata» – è che l’inquieta figlia dell’autore dei Delitti e delle pene, anziché rassegnarsi a sposare il vecchio conte Pietro Manzoni, abbia a suo tempo consegnato il neonato frutto della relazione clandestina con Giovanni Verri alla ruota di un orfanotrofio. Al piccolo viene dato il nome di Evaristo Tirinnanzi. Gracile, introverso, solitario e nervoso, ma brillante negli studi, il trovatello viene poi accolto a casa Beccaria come contabile; e in tal veste fa la sua conoscenza il protagonista del romanzo, un viaggiatore francese che si presenta come il barone Jean-Louis Aurélien di Cerclefleury, discepolo devotissimo di Franz Anton Mesmer, discusso fautore della teoria del magnetismo animale. Giulia lo prende sotto la sua protezione e lo introduce nel suo salotto, dove egli riscuote immediato successo presso le dame, affascinate in pari misura dai racconti delle sue avventure, delle persecuzioni subite dal maestro, dall’esposizione delle mirabolanti teorie mesmeriche, nonché dalla prospettiva di trarre da queste ultime concreti benefici: il francese infatti, pur avendo l’aspetto e il vigore di un giovane, proclama di avere quasi settant’anni (una decina appena meno della sua ospite).
Il Cerclefleury sospetta che l’austero e schivo Tirinnanzi gli sia ostile; ma presto scopre che, afflitto dal vizio del gioco, il contabile ha ben altro a cui pensare. Né i dadi e i debiti sono il suo unico segreto. Fin dall’adolescenza egli è visitato periodicamente da una grave, misteriosa voce che gli detta frasi smozzicate e sconnesse, trascrivendo le quali la sua stessa grafia muta, quasi fosse un altro a guidare la sua mano. Il quaderno, gelosamente nascosto, è un guazzabuglio incomprensibile a tutti, eccetto beninteso il lettore, che non stenta a ravvisare stralci dalle opere manzoniane: versi, espressioni, immagini, un grandioso universo di parole ridotto (ricondotto?) a uno stato di primordiale caos. Certo è che l’arcano oracolo interiore turba profondamente il povero Tirinnanzi. Che cosa succederebbe se la circostanza venisse resa nota? Verrebbe rinchiuso tra gli alienati mentali, sottoposto a esorcismi?
Non starò a ricostruire la trama: Poco a me stesso, al di là dello spunto storico-biografico, ha il decorso di un romanzo d’avventura, dove la suspense gioca il suo ruolo. Mi limiterò ad aggiungere che l’azione non si limita al quartiere di Brera (dove tuttora sorge casa Beccaria) e agli ambienti aristocratici. Lo scenario comprende anche il quartiere popolare del Bottonuto, a sud del Duomo, fra l’attuale via Torino e via Larga, già piuttosto malfamato a metà Ottocento; nel volume del 1923 Milano sconosciuta (cui la descrizione di Zaccuri è largamente debitrice) Paolo Valera lo definirà un «bubbone slabbrato», tant’è che nel decennio seguente l’intera zona verrà sottoposta a un radicale intervento urbanistico. E il sistema dei personaggi comprende anche un efferato malvivente, Aristide Faggini, che del Bottonuto è padrone: e che nella sua sfrontata scelleratezza risulta il personaggio più simpatico del romanzo.
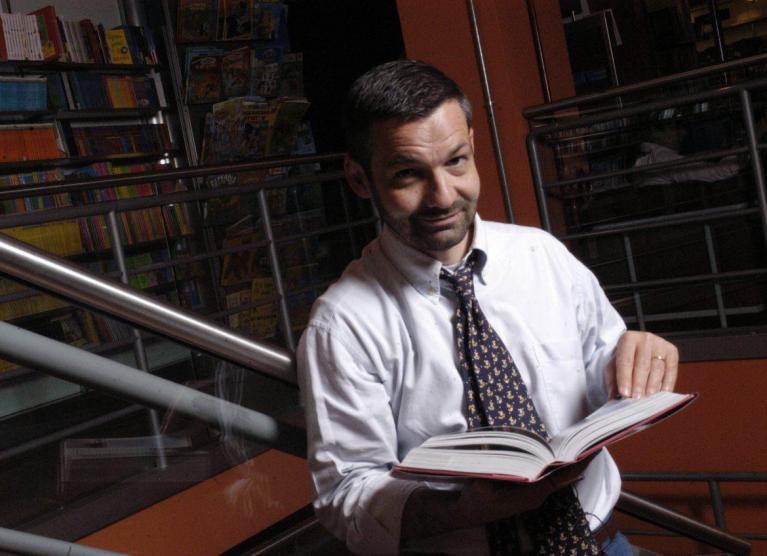
Nel famoso saggio Come leggere un libro (How Should One Read A Book?) Virginia Woolf paragona le biografie e i libri di memorie alle case di sera, quando le luci delle abitazioni sono già accese ma le tende delle finestre sono ancora aperte, e quindi il nostro sguardo può cogliere il quotidiano svolgersi delle esistenze («the servants gossiping, the gentlemen dining, the girl dressing for a party, the old woman at a window with her knitting»). Vediamo i personaggi occuparsi delle proprie faccende, mangiare, lavorare, riscuotere successi e insuccessi, odiare, amare. Ora, nel campo della memorialistica si è da tempo affermata la variante dell’autobiografia alternativa, condizionale o inattendibile (non dirò menzognera); con il libro di Zaccuri si rafforza la tendenza a istituire una forma analoga per i resoconti biografici, comprensivi di elementi finzionali che possono assumere carattere preponderante, come nella storia di Gesualdo da Venosa di recente rivisitata da Andrea Tarabbia (Madrigale senza suono, Bollati Boringhieri, 2019).
E di conseguenza sta cominciando a prendere piede, in ambito critico, il termine biofiction (corrispettivo dell’autofiction): una forma mista, declinata ora come biografia «finzionalizzata» di una figura storica o come scrupoloso resoconto biografico relativo a un personaggio di finzione. Su questo tema hanno già scritto contributi critici significativi vari studiosi, da Riccardo Castellana al giovane italianista bolognese Marco Mongelli: come sempre accade, quando una forma letteraria nuova acquista caratteri riconoscibili, s’impone come necessaria la ricostruzione della sua genealogia, nella quale di norma si ravvisano non solo anticipazioni e prodromi, ma modelli esemplari, prototipi, archetipi.
Resta l’interrogativo suggerito dal discorso della Woolf. Che cosa ci spinge a leggere una biofiction, visto che non si può parlare di curiosità per fatti realmente accaduti, né di interesse per la vita nascosta di personaggi pubblici? Dando per assodata la fascinazione contemporanea per le ibridazioni (che ovviamente non si limita al dominio della narrativa di parole, e sempre più volentieri valica i confini mediali), credo che convenga soffermarsi sulla specificità dei casi singoli. Poco a me stesso deve il suo titolo a un emistichio del sonetto autoritratto che il giovane Manzoni scrive nel 1801 (Capel bruno, alta fronte), per la precisione alla terzina finale, che così recita: «A l’ira presto, e più presto al perdono;/ poco noto ad altrui, poco a me stesso:/ gli uomini e gli anni mi diran chi sono».
Nell’appendice (Giustificazione e perdono), dopo aver narrato la genesi dell’opera, Zaccuri dice di essersi accorto a posteriori della complementarità fra la clausola del sonetto autoritratto e l’incipit dell’incompiuto poemetto La vaccina (1809-12): «In quella età che, di veder bramoso, / Ancor l'ingegno a le cagioni è cieco, / Ascoso un Genio, anco a me stesso ascoso, / Disse improvviso al mio pensier: Son teco». L’idea stessa di ispirazione poetica suggerisce un virtuale sdoppiamento della soggettività creatrice: ispirare è verbo transitivo, «essere ispirato» rinvia a un agente esterno, sia esso Musa, divinità, inconscio individuale o collettivo, memoria involontaria, Zeitgeist. Fin qui, nulla di nuovo. Che cosa ci dice, in più, la storia del figlio naturale di Giulia Beccaria?
Nel romanzo di Zaccuri, dove il cognome Manzoni non ha luogo, nessuno scrive il Cinque Maggio, l’Adelchi, i Promessi sposi; a meno di presumere che, oltre i fatti narrati, Evaristo non si possa conciliare con la voce misteriosa, facendola propria e assimilandone lo spirito. In questo caso il rapporto fra verità storica e ricostruzione controfattuale risulterebbe speculare. Alla morte della madre, il figlio di Giulia Beccaria che ebbe nome Alessandro Manzoni aveva sostanzialmente deposto la penna, e non avrebbe scritto più nulla per trent’anni. Non è quindi azzardato supporre che il rapporto di successione tra fervore creativo e silenzio poetico possa essere capovolto nel caso del presunto orfano battezzato Evaristo (graziosa, per inciso, l’affinità etimologica con il nome del capobanda del Bottonuto, Aristide: un trovatello e un delinquente, nel segno dell’eccellenza, áristos).
Ma al di là di questa ipotesi, resta il fatto che la controfigura del Manzoni storico presenta, accentuati, omologhi connotati di fragilità, dall’agorafobia alla balbuzie, dall’ipersensibilità alla tendenza bipolare, a tacere del vizio del gioco. Secondo la tradizione, fu il poeta Vincenzo Monti, di trent’anni più anziano, a rampognare il giovane Alessandro che giocava d’azzardo nel ridotto della Scala, inducendolo a smettere. E tornano alla mente, per contrasto, i passi dei Promessi sposi dove qualcuno gioca a carte o a dadi: loschi frequentatori dell’osteria della luna piena, facinorosi o ladruncoli, gli sgherri dell’innominato alla Malanotte, ma anche il prestigiatore (il «giocator di bussolotti») evocato per via di similitudine nel resoconto delle macchinazioni ordite dalla famiglia per intrappolare Gertrude. L’immaginaria figura di Evaristo Tirinnanzi giova insomma a rendersi conto di quanto precaria e esposta a insidie fosse la condizione di Alessandro Manzoni: e di quanto incidono le contingenze nell’assecondare o nell’ostacolare – ma forse bisognerebbe dire: nel modellare – le inclinazioni del carattere, e quindi anche l’espressione della genialità.
Un ultimo aspetto di Poco a me stesso che merita di essere sottolineato riguarda l’immagine della società che trasmette. La trama è caratterizzata da una serie di inganni e dissimulazioni: dal modo in cui si reciprocamente si neutralizzano o si corroborano dipende quello che poi in effetti accade. Il che non è affatto estraneo alla concezione manzoniana: basti pensare al cap. VIII dei Promessi sposi, la notte degli imbrogli e dei sotterfugi. Ma soprattutto corrisponde a una visione certo non ottimistica degli uomini, i cui comportamenti appaiono sempre regolati in primis dal tornaconto personale. L’amore – perfino l’amore materno – è meno forte delle norme della convenienza sociale; l’amicizia non è mai disinteressata; la verità è nascosta o esibita a seconda delle opportunità. E a questo punto – come nel capolavoro manzoniano – tanto vale che il romanzo abbia, a suo modo, un lieto fine.







