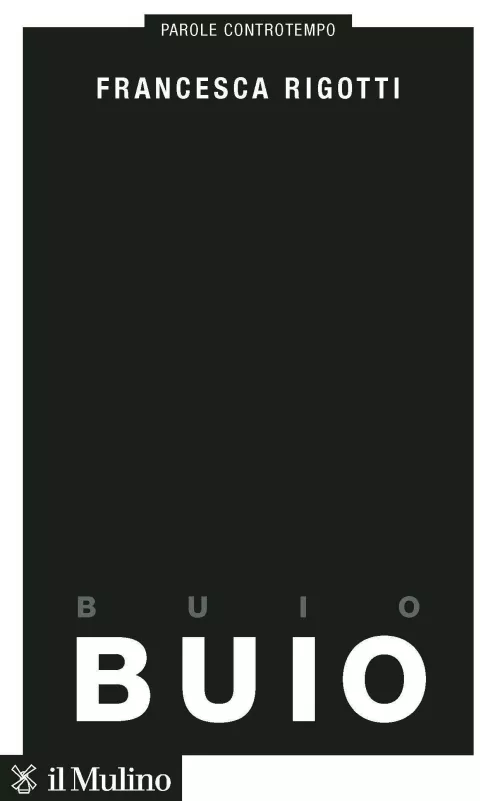Francesca Rigotti / Fare buio al buio
Neanche il buio è più quello di una volta. Se l’illuminismo ha vinto molte battaglie ma a quanto pare ha perso la guerra, l’illuminazione ha stravinto su tutti i fronti. “Ogni cosa è illuminata”, nel senso che più niente sfugge alla luce. Le cose, le case, le strade, le campagne, il cielo. Si cerca la luce per sentirsi sicuri, per esorcizzare la paura e la morte. “Infuria, infuria contro il morire della luce”, diceva Dylan Thomas. Ma il buio non è solo minaccia, è anche riposo, possibilità di riflettere, di isolarsi, di negarsi. Il buio è anche ciò che custodisce il segreto, che nasconde e accoglie; è la paura, ma anche, a volte, la protezione, il rifugio; il pericolo, la minaccia e la difesa; l’aggressione e l’intimità, degli amanti e di ciascuno con se stesso...
Ma negarsi alla luce diventa sempre più difficile. Sottrarsi alla vista, cercare zone d’ombra, angoli bui, è già un atto sospetto di per sé. Di noi, tutto deve essere visibile e tenuto sotto controllo, solo così possiamo essere protetti. E solo protetti in ogni momento della giornata (del giorno che include la notte, come la donna è inclusa nell’uomo e non viceversa) e da ogni parte, possiamo sentirci non minacciati, privi di ansie, sicuri. Solo se controllati, liberi, quindi. Niente deve restare nascosto. Se ti nascondi sei pericoloso, sei tu una minaccia.
Allora si deve portare tutto alla luce. Ma “povera è la vita di chi vende la libertà, il silenzio e il buio per egoismo e paura” (p. 106), scrive giustamente Francesca Rigotti (filosofa, metaforologa, docente dell'Università della Svizzera italiana dopo avere insegnato presso l'Università di Göttingen, autrice di numerosi libri, da ultimo De senectute, Einaudi 2018 e Migranti per caso, Cortina 2019), nel suo ultimo vorrei dire luminoso libretto, Buio (Il Mulino, 2020, p. 135), se il suo stesso contenuto non rendesse ancor più cauti del solito nella scelta delle immagini, che non sono mai innocenti.
“Il buio è bello, lo sappiamo tutti” (p. 9). Per trovare il buio si intraprendono lunghi viaggi, verso i monti più inaccessibili, i deserti, il mare aperto, con il cielo stellato sopra di noi, quella minuscola porzione di universo che già ci sembra infinita, inimmaginabile, e l’oscurità tutto attorno, con i suoi rumori, le sue voci, diverse da quelle diurne, finalmente udibili, fasciate di silenzio, nette, singolari e pur sempre misteriose. E anche così, a volte non basta, si cerca un buio ancora più scuro, grotte, foreste impenetrabili, vasche di deprivazione sensoriale, dove l’assenza di stimoli si traduce nel beneficio di un grandissimo rilassamento, una specie di nirvana termico. Chi può esce persino dall’atmosfera, nella notte delle notti, nell’oscurità della materia, nel regno inavvertibile della materia oscura.
Nel buio totale si perde l’orientamento, e a volte persino l’equilibrio; non si ha più la percezione del proprio corpo, si è insieme pesanti e smaterializzati, la pelle è come se si volatilizzasse, ma in compenso si percepiscono gli organi interni, alcuni quanto meno; invece del volume del corpo si sentono i suoi rumori, i liquidi che scorrono, il cuore che batte, l’aria che entra e esce dai polmoni che si dilatano e restringono, le tempie che pulsano, il sangue che formicola alle estremità. È un buon esercizio. Sospendere tutto, cambiare prospettiva, ripensare diversamente. Il buio si addice alla meditazione. E molti filosofi e poeti lo hanno infatti notato. La parola stessa “non è soltanto sinonimo di luce, ma anche di buio; e non esiste solo il canto notturno, nella notte, ma anche il canto della notte” (p. 93). E lo stesso vale per il pensiero.
Per questo ne abbiamo bisogno, come del silenzio, al quale pure Francesca Rigotti ha dedicato un volumetto (Metafore del silenzio. Il silenzio per immagini, Mimesis 2013). Piuttosto che niente, a volte chiudiamo gli occhi, per provare a dormire nella luce, per concentrarci, per toglierci dal mondo, almeno per un po’.

Opera di Lucio Fontana.
Ricordo un’opera di una ventina di anni fa alla Biennale di Venezia che mi ha molto turbato: oltre una tenda nera, si percorreva un lungo corridoio non illuminato, che diventava man mano più buio, finché non si sbucava in uno stanzino con un’immagine sulla parete di fondo, o forse era solo una scritta, che informava che il tempo del percorso, una ventina di secondi se ricordo bene, era quello durante il quale il cervello di una testa decapitata, e forse gli occhi e gli altri sensi, continuavano a essere attivi, prima di spegnersi progressivamente, per sempre. Una soluzione poco consigliabile, però.
Ci sono tanti aspetti positivi del buio, eppure normalmente ad esso si associa tutto quanto vi è di negativo: il male, l’ignoranza, la paura, l’errore, la superstizione, la morte e l’oltremorte, con alcune ottimistiche eccezioni. Pur essendo le tenebre accreditate da prestigiose tradizioni di precedere il mondo e la luce, raramente vengono però ritenute una sostanza a sé, autonoma e anche positiva, almeno in parte, come illustra benissimo Francesca Rigotti con una dovizia di esempi scelti soprattutto tra i testi fondativi della cultura occidentale, la Bibbia e Omero, fino a Camilleri (mi scuso per l’accostamento), da cui poi si diramano brevi incursioni, quasi dei raid, che di essi hanno tutta la rapidità e l’efficacia, in tutta la nostra storia culturale, e li articola gli uni agli altri, li contrappone o li mette in reciproca tensione, in urto e in frizione. Per fare luce senza togliere nulla al buio. Per fare buio al buio.
Il buio non viene considerato niente in sé, è solo il contrario della luce; la sua comprensione e valutazione ne dipendono in tutto e per tutto: se qualcosa di esso viene detto o visto, è solo alla luce della luce. Le parole non ingannano. Cioè, ingannano, ma, a prestarvi attenzione, dicono anche l’inganno. Cosa che Francesca Rigotti sa fare con sapienza e acume. Non sopravvalutare la lettera, ma nemmeno trascurarla; la metafora dice quel che dice, non solo quanto d’altro significa o implica. Non è tanto la letteralizzazione delle metafore, è la loro stratificazione, la loro storia, il loro intreccio, e il modo in cui alcune di loro, specie quelle che danno luogo alle coppie concettuali di cui è intessuta la cultura occidentale, sono diventate lettera, che contiene, magari nascosta, sepolta nell’oscurità del tempo e dell’uso, la complessità delle proprie origini e parentele. Come quella che lega bianco e nero nell’alto tedesco (blach e blanck) e nel medio inglese (blaek e blank) per dire rispettivamente il nero “luminoso” e il bianco “brillante”, già evidenziata anche da Pastoureau nel suo Nero (trad. it. Ponte alle grazie, 2013).
Francesca Rigotti analizza le coppie concettuali e le associazioni che ne derivano, le catene analogiche che ne dipartono (buio-notte-donna-errore-male/luce-giorno-uomo-verità-bene) che condizionano il nostro modo di pensare e di costruire la realtà facendoci apparire scontato, “naturale”, ciò che invece è pesantemente condizionato. Per districare queste reti, non abbozza tuttavia una storia culturale del buio, e nemmeno sociale, come invece ha fatto Nina Edwards con la sua Storia del buio, recensito su doppiozero da Michela Dall’Aglio, ma ricostruisce l’area semantica e la costellazione (ahi!) concettuale che peraltro nella storia dei termini che le definiscono in buona parte si radicano. Da sola la luce, come tutti i corni positivi di ogni coppia, possiamo azzardare a pensarla: e come altro nome della verità è ciò che la filosofia da sempre cerca di fare; la tenebra no. Essa è la negazione, la perdita, l’assenza della luce. Da solo, il buio è im-pensabile: in-visibile, forse addirittura ir-reale.
Il prefisso negativo dice già tutto. Prima della luce, cioè prima del mondo, prima della creazione, dicono le religioni, c’erano le tenebre; ma queste tenebre non erano niente, perché niente c’era: dunque esse stesse non esistevano. Solo dopo che la luce fu, ci furono anche le tenebre. Separate da essa, da essa estratte, rese differenti, opposte, e già subordinate. Già vinte. Il male che in esse si incarna è quello che si oppone alla luce: e non a caso nella religione ebraico-cristiana il portatore e signore del buio è l’angelo più luminoso caduto, Lucifero. Colui che porta la luce; ma non la è. Che voleva esserla e ne è stato escluso. Altrimenti dovremmo ammettere (ipostatizzare) un male che ha potuto essere prima del bene, o accanto, assieme, come diceva il profeta Mani la cui immensa opera non a caso è stata del tutto cancellata (ricacciata nel buio), e pertanto ad esso almeno pari, se non superiore. Ciò che è evidentemente impossibile. Lo vedono tutti. Provare a pensare il buio da solo è uno sforzo immane quanto vano. Sarebbe pensare l’impensabile, dicevo. Alcuni ritengono che per questo è uno sforzo da rigettare, dannoso più ancora che inutile; per altri invece l’unico pensare che valga davvero la pena è proprio quello che con l’impensabile si misura. Che si immerge nel buio e vi resta senza rifuggirlo. Anche se questo corrisponde, in più di un senso, al morire. (Pensare sarebbe dunque stare nella morte senza essere (ancora) morti?)

Die deutsche heilslinie, Anselm Kiefer, Hangar Bicocca.
Francesca Rigotti ha ben presente queste cose, ma sceglie di imboccare un’altra direzione, quella di dare sostanza al buio ponendolo allo stesso livello della luce senza con questo volerlo separare da essa e anzi mostrandone la pari dignità e la complementarietà, come nella volta stellata, “che tiene insieme il buio e la luce... che si alternano nelle posizioni attore/sfondo in relazione alla prospettiva di chi guarda” (p. 113 ). E lo fa cominciando a pensare ciò che in esso vi è di positivo andando a rintracciarne semi e ricorrenze nella storia della cultura occidentale, attraverso esemplificazioni di grande spessore e fascino, con una scrittura limpida e varia, e a volte (giustamente, dato che si tratta anche di decostruire pregiudizi diventati abitudini di pensiero consolidate e irriflesse) persino maliziosa, con un’arguzia che purtroppo non è molto frequentata dai filosofi, forse per il timore di sminuire il lor pensiero, di apparire poco seri. Il pensatore non ride. A ridere è la servetta tracia, quell’oca giuliva.
Ogni cosa è un buon motivo per essere tristi. (Ma questo non c’entra: è finito qui per caso.)
Il buio preso a sé è qualcosa che ci sfugge, è l’estraneità che resta sempre tale. Come la luce più intensa, peraltro, che non si può fissare senza accecarsi, cioè senza sprofondare nel buio, che ci impedisce di guardare il volto delle cose e degli esseri umani. Hanno la stessa ambivalenza, come sapevano bene gli antichi, che alla cecità associavano doni di preveggenza, come per Tiresia, o di visione, come per Omero, cioè di una vista oltre la vista. Dice Lévinas: “Il viso entra nel nostro mondo avanzando da una sfera assolutamente estranea, ossia, precisamente, da un assoluto, che è poi il nome stesso dell’estraneità più profonda” (devo la citazione a Enrico Manera). L’estraneità più assoluta è ciò che si manifesta nella sua massima evidenza restando incomprensibile; è l’incomprensibile, l’incommensurabile di tutto ciò che ci circonda dandosi a vedere nella luce più abbagliante, e lasciandoci al contempo al buio più completo. Che è come dire che viviamo letteralmente immersi nell’assoluto, circondati, e a contatto di miriadi di assoluti, destinati a restare tali, e che tuttavia si offrono a noi nella loro distanza, ci disorientano, ci interpellano e, più ancora, ci sfiorano. Ci scuotono e ci accarezzano.
Resta il fatto che, a ben pensarci quindi (a ben guardare), restiamo all’oscuro di tutto. Non sappiamo niente. Sappiamo quel che sappiamo. E quel che sappiamo è niente. Ma non dobbiamo spaventarci. Non del tutto, quantomeno. Perché essere all’oscuro è un grande dono che ci è stato fatto: cercare di capire portando un po’ di luce ci tiene occupati, ci dà una specie di scopo. O meglio: la possibilità che noi ci diamo un compito. Il più alto dicono alcuni. Esagerando. Portare un po’ di luce non elimina il buio. Da ogni parte, attorno, il buio permane. Però, facendolo, creiamo ombre, sfumiamo i suoi orli, smangiucchiamo i margini a noi più prossimi, come si fa con le unghie. E con la stessa soddisfazione (e dolore, quando esageriamo, e mordiamo la pelle, la carne: allora esce il sangue, e questo, anche questo, ci fa sentire vivi). Però anche allora, sempre, ovunque si spinge lo sguardo, il buio resta infinito.
E meno male. Non tutto è perduto, allora. Come dice l’altro Dylan, Bob, “It’s not dark yet, but it’s getting there”. Anche se non è ancora qui, il buio sta arrivando. Sempre imminenente L'intonazione è libera.