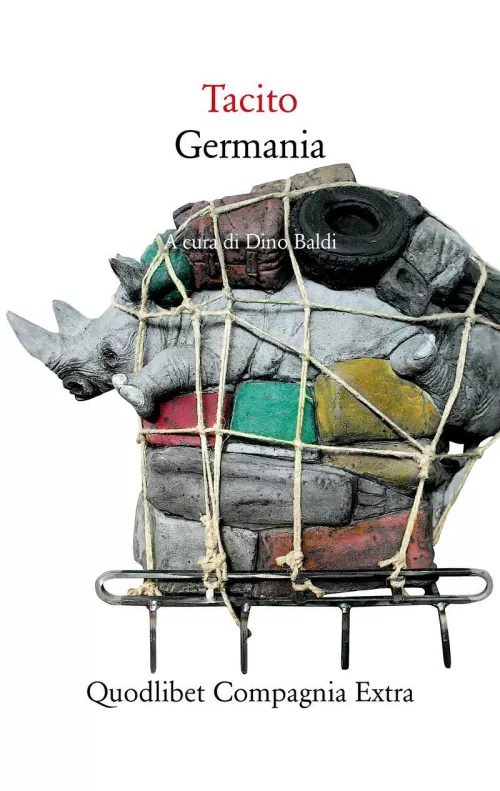La Germania di Tacito
“Uno dei cento libri più pericolosi al mondo”, così Arnaldo Momigliano definì la Germania di Tacito, di cui esce ora una nuova edizione, egregiamente curata da Giuseppe Dino Baldi, per i tipi di Quodlibet: novantacinque pagine di testo (e traduzione), accompagnate da ben duecentoquaranta pagine di commento (in corpo minore). E questo perché il curatore è consapevole che, in quest’opera, “quasi ogni parola apre labirinti di senso il cui intrico è accresciuto dalle interpretazioni prodotte ostinatamente nei secoli”. Ciò, aggiunge, “può essere faticoso per chi legge”, ma assicuriamo che non è fatica quella che abbiamo provato nel delibare annotazioni così ricche e sostanziose, tutt’altro.
Comunque l’importante, come diceva Breton, è sapersi orientare nel labirinto. Cerchiamo quindi di indicare alcuni possibili fili di Arianna che disegnino dei percorsi all’interno di questa trama avvincente, stesa tutt’intorno al nudo corpo del testo.
Innanzitutto, riallacciandoci al tagliente giudizio di Momigliano, cerchiamo di sondare la dimensione “maledetta” della Germania tacitiana (o, più correttamente, De origine et situ Germanorum, secondo il codice di Hersfeld, capostipite solo parzialmente conservato della tradizione manoscritta). Essa divenne in effetti l’aureus libellus della, per così dire, cultura nazista. Il mito funesto dell’autoctonia e quello ancor più esiziale della purezza etnica trovarono alimento e fondamento proprio nei primi capitoli dell’opera tacitiana, il secondo e il quarto per la precisione.
Ma cosa intendeva realmente Tacito quando sosteneva che i Germani erano “indigeni” e “non guastati dall’unione con altri popoli” e “simili solo a se stessi” (“tantum sui similem gentem”)? Intendeva semplicemente supportare l’assunto di un’identità integrale dei popoli d’oltre Reno, ossia voleva distinguerli nettamente dai Galli, per non portare la barbarie all’interno dell’Impero. Sallustio, per esempio, nel Bellum Iugurthinum, ancora confondeva le due popolazioni.
Non è certo, quella di Tacito, una posizione razzistica, pertiene piuttosto all’assunto latamente politico dell’opera, cui accenneremo oltre. Tanto più che sia l’autoctonia sia l’autosomiglianza non sono affatto caratteristiche esclusive dei Germani. Sono anzi un vero e proprio topos dell’etnografia antica. Eduard Norden fin dal 1920 aveva parlato a ragione di “Wandermotiven”, ossia “motivi itineranti” o ricorrenti che autori greci applicavano di volta in volta a popoli diversi. Per esempio, nel trattato Arie, acque, luoghi attribuito a Ippocrate, degli Sciti si legge esattamente che “assomigliano solo a se stessi e per niente agli altri”. E tali peculiarità venivano poi estese ad ulteriori genti ancora, come Celti o Traci, tutti popoli “primitivi”, realizzando in tal modo l’autentico e sorprendente paradosso di una unicità comune a tanti. Ma questa evidenza non contava nulla per occhi abbacinati dall’ideologia. Anzi: nemmeno la filologia poteva dirsi immune dalle pesanti interferenze di un’ossessione identitaria deleteria. Là dove il testo recita “unde habitus quoque corporum, tamquam in tanto hominum numero, idem omnibus” ossia: “questa è la ragione per cui si somigliano tutti, per quanto è possibile in una popolazione così ampia”, con un tamquam dal valore limitativo, i filologi nazisti preferivano di gran lunga la lezione quamquam, concessiva (sono tutti uguali nonostante il grande numero) e, dato che il codice Aesinas lat. 8 porta questa lezione, Himmler in persona nel settembre 1943, tramite un distaccamento di SS, cercò di impossessarsene ai danni del legittimo proprietario, il nobile di Jesi, conte Balleani. Per fortuna invano. Ma, benché frustrato, anche solo il tentativo indica l’importanza fondamentale che la Germania rivestiva per tali fanatici estimatori.

Va detto peraltro che altri passi dell’opera (per esempio il capitolo 26) sono stati interpretati in chiave opposta, addirittura come prefigurazioni di una sorta di comunismo agrario primitivo.
Il fatto è che la Germania ha sempre avuto “il privilegio e la condanna dell’attualità”. Inoltre si presenta come un testo “intrinsecamente ambiguo”.
I due aspetti effettivamente sembrano presiedere, uniti, anche alla sua stessa nascita.
Siamo nell’anno 98 d.C. e Traiano, dopo l’investitura imperiale, rimane sul Reno, non torna a Roma. Perché? Vuole assicurarsi della stabilità dei confini? Li vuole oltrepassare, portando guerra alle tribù germaniche? L’opera di Tacito, più che un trattatello etnografico, forse è quello che noi oggi chiameremmo un instant-book sulla situazione politico-militare dell’impero. Ma dalla duplice possibilità di lettura.
Si prenda infatti la celebre chiusa del capitolo 33: “quando urgentibus imperii fatis nihil iam praestare fortuna maius potest quam hostium discordiam” (“perché, in questo momento fatale per l’impero, la fortuna non può offrirci niente di meglio della discordia fra i nemici”). Si tratta di un’espressione simile a certe “illusioni ottiche nelle quali si possono vedere contemporaneamente due figure opposte o diversissime fra loro”. Ossia: Tacito pare o esortare Traiano all’azione, a combattere, a estendere le frontiere dell’impero, a vendicare la disfatta di Teutoburgo, a continuare le imprese di Druso, Tiberio e Germanico, perché il destino sospinge avanti e si compiano i gloriosi fati di Roma. Oppure si tratta, come disse Paratore, del primo vero rintocco funebre che le pagine tacitiane facciano squillare, del presagio della fine inevitabile di Roma, travolta dall’onda d’urto barbarica, sol che terminino le lotte intestine fra le varie orde tribali.
Ad analoga molteplicità d’interpretazione si presta anche un altro motivo, quello che passa per proverbiale di quest’opera, e cioè la contrapposizione tra “salute”, “purezza”, “ingenuità” barbarica di contro alla “corruzione”, “eccessiva raffinatezza”, “slombataggine” romana. Si sa che, come Manzoni nei Promessi sposi parlava a suocera (Spagnoli) perché nuora (Austriaci) intendesse, così secondo Gadda, allo stesso modo Tacito, in vari luoghi della prima parte (capitoli 1-27) della Germania, ma non solo, esalta certe usanze dei primitivi quasi esclusivamente al fine di deprecarne le analoghe romane. I barbari mangiano per togliersi la fame, non s’ingozzano per poi vomitare e poi ingozzarsi di nuovo; i barbari rispettano il matrimonio, non divorziano per poi risposarsi e divorziare ancora; i barbari non praticano l’usura; i barbari non celebrano funerali sfarzosi; i barbari non chiamano la corruzione moda dei tempi (“nec corrumpere et corrumpi saeculum vocatur”).
Ebbene, questi Germani così morigerati, si contrappongono sì ai Romani contemporanei, ma sono assai simili ai Romani di un tempo, a quelli a cui Cicerone, citando Ennio, poteva riferire il celebre verso moribus antiquis res stat romana virisque.
D’altro canto, se uno considera quel legionario della colonna Traiana che combatte tenendo fra i denti la testa di un Dace, può vedere agevolmente che i confini tra barbarie e civiltà non sono così netti come si potrebbe pensare a tutta prima.
La Germania parla dell’Altro e parla di noi, dove il noi non è solo quello dei Romani dell’epoca traianea, ma anche il nostro, contemporaneo, per quanto grandi possano parere le differenze con l’oggi, anche per esempio con il modo che abbiamo noi, noi dei secoli ventesimo e ventunesimo, d’intendere una monografia etnografica. Per noi è opera di ricerca sul campo, per Tacito è, come già ricordato, selezione di luoghi comuni di autori antichi (l’unico ad avere menzione diretta nell’opera è Cesare, “summus auctorum divus Iulius”). Per questo, a chiudere questa edizione, c’è una ottantina di pagine tratte da Cesare, appunto, Polibio, Plinio il Vecchio e altri, a rappresentare il contesto culturale entro il quale si muoveva il nostro autore, il repertorio di temi, motivi e atteggiamenti culturali che gli erano familiari.
Quanto alla traduzione di Giuseppe Dino Baldi, basti dire che è quella di uno scrittore, non di un traduttore.
In conclusione, ci permettiamo di dire che, delle varie Germanie circolanti oggi in Italia, in genere non da sole, ma accoppiate con l’Agricola e il Dialogo degli oratori, cioè con quelli che Syme chiama i “primi passi dello storico” Tacito, questa è, a nostro giudizio, senz’altro la migliore e, senza ombra di dubbio, di gran lunga la più completa.