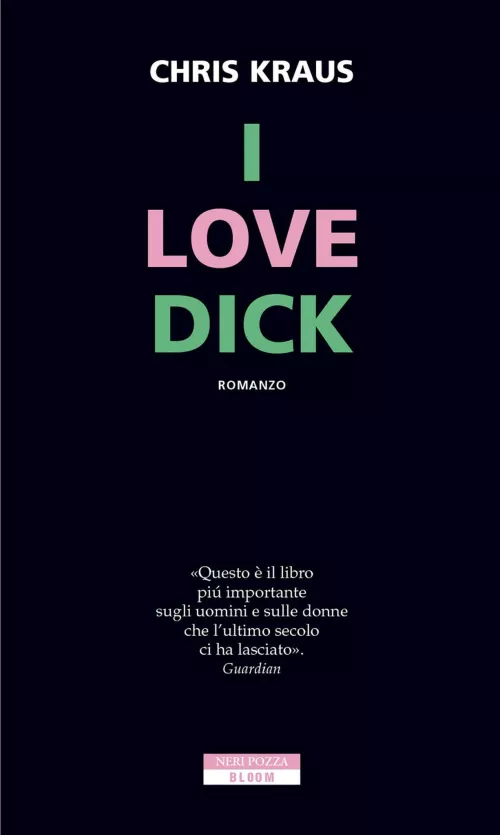Lo sguardo di chi l'ha tradotto / I Love Dick
Eccomi qui, dopo vari ripensamenti, a fare qualcosa che per le patrie lettere è stato a lungo un anatema. Sì, mi accingo a scrivere, complici gli amici di “Doppiozero”, di un libro da me curato e tradotto. A scriverne, proprio perché l’ho curato e tradotto.
Anni fa, quando in Italia l’era digitale muoveva i primi passi, le riviste culturali e letterarie ponevano un veto severo a una pratica considerata sconveniente. “Conflitto di interessi”: lo si spiegava più o meno così. Come se il traduttore/curatore, neanche fosse l’autore del libro, scrivendone criticamente, tirasse acqua al proprio mulino, agisse pro domo sua, insomma non fosse nella posizione ideale per dire la sua sul testo in oggetto.
Personalmente ho sempre pensato che la lettura più approfondita, acuta e dunque critica di un testo sia appunto quella di chi lo traduce. Quando si trasporta un libro dalla sua lingua originaria alla propria è necessario infatti entrare in sintonia profonda non solo con la lingua in cui è scritto, ma con tutto il non scritto – affettivo, culturale, storico, sociale – che lo precede e lo accompagna. In altre parole, la traduzione funziona se chi traduce entra intimamente in rapporto con la/e cultura/e dell’autore e con la sua complessiva esperienza di vita.
Per arrivare a noi, nel luglio del 2016 l’editore Neri Pozza mi propone di curare l’edizione italiana di I Love Dick, un romanzo epistolare/memoir/saggio di teoria culturale della nordamericana Chris Kraus. Pubblicato senza esito alcuno nel 1997, a quasi vent’anni di vertiginosa distanza politica e storica dalla prima edizione americana il testo è rispuntato prepotentemente a Francoforte, ed è andato a ruba in tutto il mondo. Io, che – mea culpa – non ho mai sentito parlare né del libro né della sua autrice, me ne faccio mandare copia e lo leggo d’un fiato, entrando in una specie di loop.
Quel testo sfacciato, irriverente, coltissimo e di estrema audacia politica, Chris Kraus lo scrive nei primi anni novanta tra New York e Los Angeles, tirando le somme del decennio passato e delle sue aporie, dei vezzi, delle finzioni, delle presunzioni, delle illusioni che hanno caratterizzato una certa intellighènzia di sinistra nell’edonistica – e per molti feroce – era reaganiana.
In quegli anni anch’io vivevo e lavoravo a New York e gli ambienti di cui Kraus parla erano limitrofi ai miei e talora con essi coincidenti. Silvère Lotringer, marito di Kraus, è l’intellettuale francese che, attraverso la rivista “Semiotext(e)” e l’insegnamento nelle università più prestigiose d’America, getta una specie di ponte intellettual/politico sul cultural divide atlantico. Sarà lui, più di ogni altro, a sdoganare negli Usa il pensiero di Deleuze e Guattari, o quello di Toni Negri & Co. Kraus lo affianca, lo aiuta, lavora silenziosamente al suo fianco, fa – si potrebbe dire – il lavoro sporco che permette alle riviste di esistere e al pensiero di circolare. Ma le luci della ribalta restano puntate altrove. Il jet set intellettuale è impietoso e esclusivo come ogni altro: c’è chi appare e chi fa apparire.
Il libro di Kraus – non è un caso che in quegli anni non l’abbia mai incrociata, mentre in suo marito era inevitabile inciampare – è una fotografia ad alta definizione di quei tempi e di quella vicenda culturale, soprattutto di un gruppo sociale cosmopolita ma non multietnico, nomadico ma non migrante: un’élite.
Fin qui si potrebbe pensare a un più o meno nostalgico “Come eravamo”. Nient’affatto. Kraus è incazzata: l’élite di cui si è creduta parte, il meglio dell’illuminata, aperta, ‘trasgressiva’ intellighènzia internazionale di stanza a New York in quegli anni, non ha capito un bel niente dell’“origine del mondo”. In altre parole non ha preso neanche in considerazione l’esistenza delle donne, se non come supporto (appagato? complice?) degli uomini.
In una delle pagine più esilaranti del libro Kraus, che al vittimismo rivendicativo e alla lamentazione preferisce la satira e un tagliente, lucidissimo humour, si definisce la “Più Uno” di Sylvère Lotringer. Così erano chiamate, a un certo tipo di party newyorkese, le anonime, mai-invitate-in-proprio, accompagnatrici (mogli e/o amanti) degli uomini famosi. Una specie di appendice/coda/rimanenza, perfettamente intercambiabile e insignificante.
Il tema che Kraus pone al centro della sua narrazione, mandando allegramente al diavolo ogni gabbia di genere, è come ci si possa smarcare da quella posizione. Posizione, si noti bene, non propriamente subita, ma piuttosto assunta, e dunque tanto più difficile da abbandonare, o meglio da togliersi di dosso.
Le operazioni diegetiche compiute dall’autrice sono plurime.
Innanzitutto, una volta stabilito che per una donna stanca di fare da ombra e da plinto agli uomini e alle loro omofile convenzioni l’unico comportamento corretto è la slealtà, Kraus si dà al sabotaggio dei generi, sessuali e letterari. Conoscendoli intimamente e possedendoli tutti, può divertirsi ad applicare al suo – davvero esemplare – ‘caso di vita’ tutte le forme in cui si è declinato nel corso degli ultimi secoli il rapporto uomo/donna.
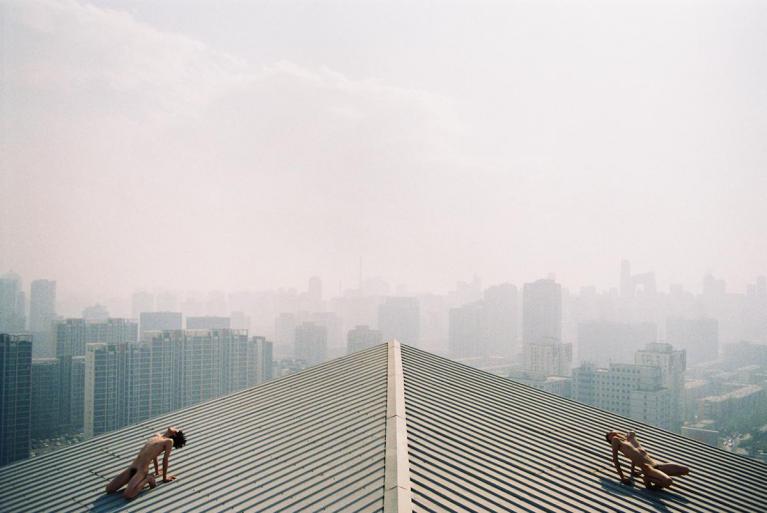
Ph Ren Hang.
Non per nulla l’intera prima parte del testo è un paradossale epistolario à trois che, per geometrica lucidità e perturbazione del desiderio, ha ben poco da invidiare alle Relazioni pericolose di Choderlos de Laclos o ai labirinti spaziali e temporali costruiti da Madame de La Fayette attorno alla Principessa di Clèves. Né è casuale che, per fare il verso tanto alla naturalizzata supremazia maschile quanto all’altrettanto naturalizzata abnegazione femminile, Kraus scelga di pendolare tra la scrittrice Katherine Mansfield (che George Gurdjieff definiva una ‘lavandaia’) e il muscolare regista teatrale Richard Foreman, tra “Dick” (controfigura letteraria del teorico culturale inglese) e artiste dichiaratamente femministe come Hannah Wilke o Louise Bourgeois.
È evidente che non le basta né le interessa dimostrare e mostrare che l’imperatore è sempre nudo: quel che le sta davvero a cuore è capire perché lei e tante altre donne tendano a impigliarsi negli abiti più o meno nuovi del suddetto. Perché, sembra domandarsi con passione crescente Kraus, le donne si portano dietro un vero e proprio vuoto di identità e sono pronte a lasciarlo riempire dal primo che passa. È masochismo il loro? Oppure una sorta di disadattamento alle regole di un gioco sociale che pare più roccioso della Maiella?
L’interrogazione cui Kraus si e ci sottopone non ha nulla di autocoscienziale. La sua strategia discorsiva mira anzi a uscire dall’involucro chiuso del sé per aprirsi al mondo. In I Love Dick le pagine sulla passione amorosa non sono certo quelle dedicate alla sua non corrisposta infatuazione per Dick o all’uggiosa solidissima relazione coniugale con Lotringer, bensì quelle sull’unione tra un’attivista statunitense, l’avvocatessa Jennifer Harbury, e il leader ribelle maya Efraín Bámaca. Lì, in quell’inusitato rapporto costruito sul dono e su una diversità radicale, Kraus verifica la sterilità dell’attrazione tra identici/disuguali. Lì il modello in uso tra noi si incaglia, barcolla e cede.
E le pagine forse più acute di questa incalzante autoanalisi sono senza alcun dubbio i ritratti d’artista di Kraus, per esempio le sue descrizioni dell’opera di Hannah Wilke o di R. B. Kitaj. Leggendole, viene da pensare a Carla Lonzi, alla sua libertà di analisi, alla sua consapevolezza che per dire quello che si vede in modo diverso vanno trovate parole e costrutti diversi.
L’interrogativo che si pone con forza a chi lavora su un testo come quello di Kraus, apparentemente sregolato, frammentario, agerarchico, è esattamente questo: come restituirne il ritmo e la lingua di testo nascente, senza bonificarlo? Come non sottrargli la sua necessaria insubordinazione?